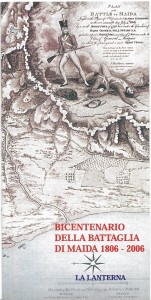Anno 2006
Il fronte mediterraneo nell’età napoleonica: La Calabria 1792–1815 e la battaglia di Maida: 4 luglio 1806
I saggi del Convegno internazionale sulla Battaglia di Maida
I 33 contributi che seguono sono la sintesi delle relazioni che gli studiosi convenuti a Maida hanno tenuto nel corso del convegno internazionale del 7 ed 8 luglio 2006 Il fronte mediterraneo nell’età napoleonica: la Calabria 1792 – 1815 e la battaglia di Maida: 4 luglio 1806.
Il bicentenario della Battaglia di Maida è stato l’occasione per interessare la popolazione locale alla conoscenza della propria storia, per invogliare i giovani alla ricerca ed allo studio e per richiamare l’attenzione degli storici di professione su di un particolare avvenimento, non del tutto marginale, nel quadro degli accadimenti e degli scontri armati che hanno caratterizzato il decennio francese.
I testi prodotti prospettano una realtà analizzata da molteplici angolazioni e visuali. Vi sono spunti interessanti di riflessione e di ricerca che vogliamo offrire all’attenzione di un vasto pubblico. I saggi, per questo motivo, saranno pubblicati anche in inglese e saranno presentati a Londra presso il municipio di Westminster, allo scopo di accrescere le conoscenze, con uno scambio di informazioni ed un confronto di studi sull’argomento.
Per la disponibilità ad organizzare l’incontro con docenti inglesi e per la presenza ai lavori del convegno di Maida ringraziamo il console britannico per l’Italia meridionale, il professore Michael Burgoyne.
Un particolare ringraziamento va tributato al prof. Saverio Di Bella – Presidente del Comitato scientifico – ed ai tanti docenti e studiosi che hanno prodotto i saggi e le relazioni. Queste ultime, una volta pubblicate, saranno presentate oltre che a Maida anche presso la Facoltà di Lettere dell’Università Federico II di Napoli.
Se e quando ciò sarà possibile, si adempirà l’impegno assunto anni addietro dall’associazione “La Lanterna” e dal compianto presidente Vincenzo Iuffrida per una rievocazione che contribuisse ad accrescere l’informazione, la consapevolezza, la conoscenza dei luoghi e la loro valorizzazione.
Spiace che le istituzioni non abbiano dimostrato di apprezzare l’intento. Sempre prodighe di solenni impegni, sempre avare di risorse, sprecate per finanziare l’effimero.
Leopardi Greto Ciriaco
Il bicentenario della Battaglia di Maida 1806–2006: le ragioni di un convegno
I risultati scientifici del Convegno sulla Battaglia di Maida (4 luglio 1806), che vide le forze armate di Napoleone sconfitte per la prima volta in campo aperto dalle truppe inglesi e napoletane, consentono di valutare con obiettività e serenità un avvenimento la cui memoria è gelosamente custodita in Inghilterra e che in Italia è stato sepolto nell’oblio.
Non a caso. L’Inghilterra a Maida ha sperimentato tecniche di combattimento che le avrebbero consentito di contrastare anche sulla terraferma le armate napoleoniche. Perciò la vittoria di Maida è la dimostrazione che le truppe francesi della rivoluzione e di Napoleone non sono imbattibili in campo aperto. La vittoria di Maida è l’inizio di una svolta militare che avrebbe portato alla vittoria di Waterloo, il trionfo dell’Inghilterra, la tomba militare di Napoleone.
Il silenzio sulla vittoria di Maida in Italia è stato viziato da un pregiudizio che ancora non è morto del tutto: le armate napoletane dovevano essere quelle dell’ammuina o dello sfacelo di fronte al nemico: disorganizzate, mal dirette, vili.
Così conveniva per grettezza d’animo e miopia politica ai vincitori che hanno scritto la storia del Risorgimento.
Dava fastidio una tradizione militare che è fatta certo di sconfitte, ma anche di vittorie e di fulgidi esempi di eroismo.
Dava fastidio riconoscere il diritto e la capacità di iniziativa del popolo anche sul piano militare.
Si è preferito perciò bollare come brigantaggio la ribellione popolare e la guerriglia vittoriosa contro la prima invasione francese nel 1799 e ancora come brigantaggio la seconda insurrezione contro Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat dal 1806 in poi. Perdente.
Ma con pagine di eroismo di cui un popolo deve rivendicare con orgoglio la memoria perché il coraggio è un valore prezioso e gli eroi vanno ricordati con onore e rispetto, anche quando hanno combattuto sotto altre bandiere, per diversi ideali, con una diversa visione del mondo.
Maida è un esempio prezioso come cartina di tornasole per capire l’errore gravissimo che si è consumato nel condannare all’oblio una vittoria preziosa: a) le truppe anglo–napoletane sono guidate da un generale nato nelle colonie che avrebbero creato gli USA e che aveva scelto l’Inghilterra e la fedeltà al Re preferendoli al nuovo Stato; b) nella battaglia hanno un ruolo decisivo, accanto agli inglesi ed ai soldati di varia origine che militano sotto le loro bandiere – polacchi, corsi, maltesi – i reggimenti siciliani, napoletani e calabresi.
Soldati di un esercito regolare, fedeltà a un Re legittimo, alleati sicuri dell’Inghilterra. Valorosi e vincenti. Da ricordare, non da dimenticare.
Il Convegno li ricorda e apre nuovi orizzonti sull’importanza del fronte mediterraneo per capire i segnali di crisi presenti nell’impero napoleonico al momento del suo apogeo, ben prima della campagna di Russia.
Sono, infatti, le rivolte popolari e la guerra di guerriglia scatenate nel Regno di Napoli nel 1806 e in Spagna nel 1808 a logorare irreparabilmente ed a dissanguare le armate imperiali.
Ed anche a insegnare loro che la guerra può essere un calvario feroce disseminato di scontri tra gruppi poco numerosi ma motivati e agguerriti che creano mini vittorie e ostilità diffusa tra la popolazione: la rivoluzione può essere rifiutata da un popolo e i suoi eserciti possono essere giudicati come invasori e occupanti, non come liberatori.
Dei valori rivoluzionari quello che viene riconosciuto è il diritto alla rivolta; su tutto il resto le differenze sono abissali e la contrapposizione è feroce.
Il Convegno sulla battaglia di Maida fa i conti con la storiografia del passato ed apre nuovi orizzonti alla ricerca. È stato perciò un momento proficuo che ha sia raccolto che seminato.
Un grazie a chi lo ha voluto e realizzato ed a chi ne ha consentito il successo partecipandovi.
Saverio Di Bella
Legioni polacche combattono a Maida nelle file dell’esercito francese
La presenza delle Legioni polacche sulla penisola italiana si ricollega direttamente ad una situazione particolarmente difficile nella storia del mio Paese. Questo periodo viene contraddistinto da un forte indebolimento e successivamente dalla cessazione dell’esistenza delle strutture statali indipendenti e, di conseguenza, dalla schiavizzazione della nazione polacca; ma allo stesso tempo corrisponde al rafforzamento dell’identità nazionale ed al rifiorire dei sentimenti ed atteggiamenti patriottici impregnati di speranza nella riconquista della libertà da parte della Polonia, dopo che nella II meta del XVIII secolo, per gli accordi tra Prussia, Austria e Russia, i territori Polacchi erano stati occupati e spartiti.
Poiché i polacchi non si sono mai arresi all’idea che il loro paese fosse cancellato dalla mappa dell’Europa dell’epoca, quasi subito, dopo la Terza spartizione della Polonia (anno 1795), sono nate le prime organizzazioni di cospirazione volte a riconquistare la sovranità. Già nel 1796 è stato firmato a Cracovia il segretissimo atto della Confederazione che preannunciava la lotta contro i tre spartitori al fianco della nazione francese. Molti polacchi sostenevano allora che la via per la libertà passasse proprio attraverso la Francia, poiché la rivoluzione in atto in quel paese era vista con grande ostilità dai più grandi paesi europei, comprese le tre potenze spartitrici. Da qui la prospettiva di un’alleanza con la Francia che, in quanto avversaria delle monarchie assolute, era già oggettivamente un alleato della Polonia. I patrioti polacchi si sono pertanto rivolti alle autorità francesi con la proposta di creare reparti militari polacchi in Francia, per la quale, d’altronde, risultava comodo disporre di nuove unità militari. Da lì gli attivisti politici polacchi sono stati rimandati in Italia, dove, al comando dei reparti francesi c’era il generale Napoleone Bonaparte.
Egli dette il suo appoggio all’idea di creare dei reparti militari polacchi, tuttavia non volendo fino in fondo coinvolgere la Francia nella complicata Questione Polacca, ordinò che il relativo accordo venisse firmato con il governo della Repubblica Lombarda, piccolo stato nel nord Italia creato sotto il protettorato francese. L’accordo fu stipulato tra il governo lombardo e il generale Jan Henryk Dabrowski nel 1797.
Così create, le Legioni, da un punto di vista formale, appoggiavano la Repubblica Lombarda, mentre in realtà prestavano servizio sotto il comando della Francia.
Nell’organizzazione delle Legioni venne applicato il modello francese, inclusa una disciplina democratica dei rapporti interni. Vennero abolite le pene corporali ed ai militari privi di nobili origini furono assicurati avanzamenti di grado; venne inoltre introdotto l’insegnamento del leggere e dello scrivere.
Sin dal 1797 le Legioni hanno partecipato a tutte le battaglie italiane. Nel settembre 1799 è stata creata la Legione sul Danubio. Dopo la pace firmata con l’Austria a Luneville nel 1801, il valore delle Legioni polacche per la Francia diminuì in modo significativo. Una parte degli ufficiali presentò le dimissioni, mentre i soldati furono inseriti in tre brigate dell’esercito francese, due delle quali furono inviate da Napoleone all’isola di Santo Domingo (oggi Haiti), dove era scoppiata la rivolta degli schiavi. I durissimi combattimenti e l’insopportabile clima tropicale causarono la sconfitta della spedizione. Dei circa 6 mila soldati polacchi ne tornarono in Europa soltanto alcune centinaia.
La terza brigata ha invece partecipato ai combattimenti sul territorio della Penisola contro il corpo di spedizione inglese e ciò che ne rimane è stato più tardi annesso all’esercito del Principato di Varsavia. Sono stati proprio quei polacchi a formare la brigata Peyri nel corpo del generale Reynier, che ha preso parte alla battaglia di Maida.
Michal Radlicki
La cartografia, il territorio e la battaglia di Maida
All’alba dell’Ottocento l’impaludamento del litorale lamentino pagava anche le conseguenze del sisma del 1783, che aveva prodotto sconvolgimenti idrogeologici tali da cambiare il corso dei fiumi, creare stagni, laghetti e pantani.
C’era dunque, forse, una ragione geofisica dello sbarco di Fra Diavolo ad Amantea e del generale inglese Stuart nella parte nord della piana: lì le colline si addossavano di più al litorale e l’impaludamento verosimilmente era minore che a sud, dove c’era il sistema fluviale dell’Amato e dei suoi tributari e ancora più a sud quello dell’Angitola. Com’è noto, gli inglesi, dopo aver stabilito una testa di ponte al bastione di Malta (vicino il villaggio di S. Eufemia), presero facilmente Sambiase e Nicastro, dove raccolsero dei rivoltosi come irregolari.
I francesi di Reynier, invece, presero posizione sulle modeste colline ai piedi di Maida e da qui secondo i piani, parte delle truppe avrebbe dovuto muoversi verso le colline di Sambiase per aggirare la sinistra del contingente inglese che si supponeva fosse fermo a S. Eufemia. Ma gli inglesi non volevano combattere con il mare alle spalle, né volevano restare ad ammalarsi di malaria lungo il litorale.
Come tutti sanno, le cose andarono diversamente: c’è chi dice che fu Fra Diavolo a indurre lo Stuart ad attaccare per primo; sta di fatto che il comandante inglese, dimostrandosi buon conoscitore del terreno, non puntò direttamente su Maida, perché avrebbe dovuto attraversare l’Amato e perdere tempo tra melme ed acquitrini. Protetto alle spalle dalla flotta – che contribuì a dare l’impressione che gli inglesi avrebbero anche potuto imbarcarsi e non combattere – Stuart procedette in due file lungo il litorale fino alla foce dell’Amato, dove piegò verso l’interno, lasciando il fiume alla propria destra, con lo scopo di impadronirsi della strada per Monteleone e raccogliere altri irregolari che colà convergevano.
Apparentemente Stuart dava un vantaggio tattico ai Francesi, consentendo loro di sfruttare il terreno in discesa per venire giù velocemente dalle colline di Maida, attraversare l’Amato e lanciarsi all’attacco con una poderosa onda d’urto. In realtà lo spostamento dei reparti da monte a valle non fu compiuto sincronicamente perché c’era da attraversare un terreno umido e insidioso che rallentò la marcia, con il risultato che sul campo le truppe si schierarono un po’ distanziate tra loro e ciò si rivelò un errore tattico che ebbe il suo peso nel corso della battaglia. Altro errore tattico commesso dai Francesi fu quello di avanzare in blocchi compatti allo scopo di sfondare le linee con scontri alla baionetta; gli inglesi si difesero opponendo linee lunghe e sottili di fucilieri, che potevano sparare anche sui fianchi del nemico e, soprattutto, ebbero l’accortezza di far fuoco a portata di tiro sicura.
Gli inglesi fecero buon uso dello spazio naturale su cui si svolse la battaglia: essi, di fatto, ebbero l’intelligenza di scegliere il campo, perché, oltre a non avere il fiume alle spalle, poterono schierare i reparti a giusta distanza e, sfruttando l’ampiezza del sito pianeggiante, poterono snodarsi in linee lunghe e distese in modo da formare un fronte di fuoco largo e avvolgente. Questo schieramento identifica una tattica difensiva basata su una linea lunga e frontale di reparti di fucilieri disposti su più file: gli inglesi lo applicarono sistematicamente nelle guerre coloniali dell’Ottocento sia in Africa che in India.
I francesi affrontarono il combattimento con supponenza e dando scarsa importanza alla geografia dei luoghi: una leggerezza insolita per l’esercito di uno Stato che si avvaleva di un famoso Ufficio Topografico Nazionale diretto da ingegneri militari e tra i più attrezzati d’Europa. Probabilmente erano convinti della loro invincibilità su terraferma. Gli inglesi, al contrario, si rivelarono pragmatici e prudenti: si schierarono in maniera da sfruttare al meglio il sito e soprattutto combatterono con alle spalle due eventuali vie di fuga, la strada per Monteleone e il mare, dove la flotta aspettava a ridosso della costa e poteva raccogliere i superstiti in caso di sconfitta.
Domenico Trischitta
Il paesaggio geografico e sociale
Le violente trasformazioni del quadro geografico di fine Settecento, intrecciandosi con la congiuntura politica degli anni immediatamente successivi, con delitti e vendette, determinano sostanziali conseguenze paesaggistiche strutturali.
Il contesto fisico in cui si svolge la battaglia di Maida è ancora fortemente caratterizzato dagli effetti devastanti del terremoto del 1783. Proprio in seguito a questo evento sismico iniziano a diffondersi le prime puntuali rappresentazioni grafiche del territorio (Saint–Non, Rizzi–Zannoni, etc.). Ma è dal Plan of the Battle of Maida, rappresentato cartograficamente, e da alcuni coevi documenti inediti, che si può restituire il paesaggio in cui si svolge la battaglia.
Si tratta di un territorio per la maggior parte di proprietà dell’antico Baliaggio di Sant’Eufemia, i cui fondi rustici sono descritti in un documento di inizio Ottocento. Un aspetto interessante consiste nella differenziazione funzionale dell’area centrale della Piana: le operazioni militari in sostanza si sviluppano nel corridoio compreso tra gli antichi corsi fluviali del Sant’Ippolito e dell’Amato, cioè nell’area meno praticabile per la presenza di acquitrini; mentre le azioni più violente del brigantaggio locale sono localizzabili nel Bosco di Sant’Eufemia e nell’area di Condò. La presenza dei briganti è uno dei motivi che prelude all’adozione di misure di rigore e ad ampie e sostanziali trasformazioni territoriali, quale l’abbattimento dello stesso Bosco e l’ampliamento e miglioramento dell’antica strada regia che delimita ad est il pianoro di Campolongo. Proprio quest’ultimo spazio rurale è caratterizzato dalle importanti trasformazioni colturali avviate dal principe Ruffo di Calabria a partire dalla fine del Seicento e poi completate nel corso del Settecento, e che costituiscono ancora oggi un’unità paesaggistica importante non solo dal punto di vista estetico ma anche sociale ed economico. Si può affermare, anzi, che queste trasformazioni colturali, ben evidenziate anche nella planimetria di mano inglese, costituiranno l’inizio della metamorfosi del paesaggio rurale che nell’Ottocento investirà l’area collinare e pedemontana di buona parte della Piana di Sant’Eufemia.
Nella storiografia, soprattutto dei grandi eventi, generalmente si trascura l’analisi del contesto fisico e sociale che, di fatto, condiziona qualsiasi azione umana, fino a determinarne anche i caratteri e i comportamenti. Il ripetersi a breve distanza l’uno dall’altro di terremoti e alluvioni genera nella popolazione una difficoltà di metabolizzazione della negatività, cristallizzando un senso di inutilità dell’opera umana rispetto all’imponderabilità dei fenomeni naturali. Questo atteggiamento di subordinazione, di costante minaccia dell’evento naturale, riveste un ruolo importante nel rapporto tra l’uomo meridionale e il territorio, visto come sintesi di natura e azione antropica.
Se a questo quadro si aggiungono le continue aggressioni degli uomini, le convulse vicende politiche di fine Settecento e inizio Ottocento: la repubblica partenopea, i fatti del 1799 e i numerosi episodi locali di violenza connessi a questi riferimenti storici, si può ben immaginare quale possa essere l’atteggiamento, non tanto delle poche frange politicizzate e legate agli interessi economici e alla tutela dei privilegi ottenuti dai Borbone o dalle promesse dei francesi, quanto dell’uomo comune, molto distante dagli eventi politici ma assai più vicino alla fame e ai problemi della sopravvivenza. La battaglia vissuta dall’uomo comune è, infatti, quella vista con gli occhi annebbiati dalla fame e dalla paura suscitata dal clima di violenza instaurato dai francesi, dai briganti e dai loro manutengoli: è una popolazione, dunque, accerchiata dal terrore.
In questo quadro geografico, sociale e psicologico si colloca la battaglia di Maida.
Giovanni Iuffrida
La battaglia di Maida nelle relazioni dei viaggiatori stranieri in Calabria
«La battaglia è perduta, colpa nostra» scrive nella lettera del 12 agosto 1806 l’ironico e schietto umanista Paul Courier, uno dei pochi scrittori che non assume un atteggiamento “di parte” a proposito della battaglia di Maida celebrata, descritta o semplicemente citata da molti dei viaggiatori stranieri recatisi in Calabria.
Dal 1806 al 1914 personaggi di nazionalità diverse quali Keppel Craven, Craufurd Tait Ramage, Duret De Tavel, Joseph Anderson, Francois Lenormant, Horace Rilliet, Augustus J.C. Hare, Philip Elmhirst, Lubin Griois, James Grant, Nicolas Phillips Devernois, Joseph Viktor Widmann danno il loro contributo perché non venga perduta la memoria della battaglia di Maida.
Alcuni viaggiatori però ritengono più opportuno non fare alcun riferimento all’evento, come Dumas e Du Camp, i quali visitano la Calabria rispettivamente nel 1842 e nel 1860 e, pur dedicando molto spazio alla città di Maida non scrivono un rigo sulla battaglia.
Nella descrizione dell’evento bellico da parte di coloro che vi parteciparono o nel commentarla si riscontrano tematiche comuni ai viaggiatori, tematiche che talvolta sono quasi stereotipi. Il clima sfavorevole rappresentato dal caldo eccessivo e dalla conseguente condizione malsana delle paludi presenti nella zona teatro della battaglia è un elemento ricordato da Griois, Desvernois e De Tavel il quale afferma che sarebbe bastato «lasciar agire il clima» per vincere.
Uno stereotipo utile a giustificare la sconfitta è quello che contrappone lo slancio e impetuosità dei francesi alla freddezza degli inglesi; Devernois sottolinea il «carattere suscettibile e focoso dei francesi» e gli fanno eco anche Anderson, Griois e Lenormant i quali aggiungono che i francesi erano certi della vittoria, «ben visibili, mentre avanzavano sfrontatamente e con sicurezza, aspettandosi evidentemente che potevano, e volevano, sconfiggerci» (Anderson) e «animati da quello slancio che gli fa presagire il successo» (Griois).
L’enfasi sulla brevità della battaglia viene posta sia dagli inglesi che dai francesi cui «un quarto d’ora è bastato ad assicurarne la disfatta» (Griois) e la descrizione del magnifico paesaggio che si presenta davanti agli occhi di entrambi gli eserciti ricorre nei resoconti più dettagliati.
Anderson, Griois e Grant nel corso dell’accurata e partecipata narrazione che si riferisce ai momenti antecedenti la battaglia si soffermano a riflettere sul sangue che verrà inevitabilmente versato; scrive Grant: «noi non potevamo non pensare al sangue che doveva scorrere prima che quel sole glorioso che ci illuminava si rituffasse nella marina».
Per quanto riguarda il popolo calabrese i viaggiatori esprimono giudizi contrastanti poiché sia i francesi che gli inglesi li considerano loro alleati, ma hanno in comune la tendenza a dar loro poco spazio. La Calabria e i calabresi sono sullo sfondo, i protagonisti sono i due eserciti stranieri, protagonista della narrazione è la battaglia di Maida.
Maria Rosaria Costantino
La Calabria nella lotta anglo–francese in età napoleonica: la battaglia di Maida
Dalla ricostruzione della dinamica della battaglia emerge con chiarezza che lo scontro di Maida, pur essendosi svolto sulla terra ferma, dipese nella sua essenza e nei fatti dalla lotta ingaggiata sui mari da Inglesi e Francesi: il Mediterraneo vi gioca un ruolo centrale, quale cerniera tra Oriente e Occidente. Il Mediterraneo, per la sua stessa natura eteroclita, è un insieme di vie marittime e terrestri, un crocevia di strade poste in collegamento tra loro, uno snodo di singolare importanza per l’entroterra e le città. E nello svolgere un ruolo privilegiato per la circolazione – esprimendo una complementarietà delle montagne e delle pianure, della terra e del mare col rilevarne l’interna, profonda unitarietà – costituisce esso stesso un sistema di cui è facile comprendere la valenza e la veste di funzione storica.
L’Italia, asse mediano del Mediterraneo, sdoppiata tra un’Italia volta a ponente e una volta a levante, rivestiva e riveste una posizione geografica determinante per il controllo sul Mediterraneo. A Napoleone non poteva certo sfuggire una tale cosa, e nemmeno ai suoi avversari.
La Calabria, gigantesco ponte (strategicamente e naturalmente “gettato” tra la Sicilia e il continente, ancor più geodeterminante per la vicinanza alle porte marine dell’isola di Malta e dello stretto di Messina, separata da una lingua di mare da un’isola, la Sicilia, posta a cavaliere del Mediterraneo occidentale e, assieme porta – con le isole Jonie – per l’Oriente) costituiva un territorio di scontro tra le due potenze straniere, ognuna delle quali espressione di interessi opposti e al tempo stesso convergenti (il predominio dell’una sull’altra). Ma era anche la regione in cui si mescolavano interessi locali di rilievo e dove però le popolazioni locali rivestivano un ruolo non certo comprimario. La sollevazione delle popolazioni calabresi contro i Francesi – dopo averli prima accettati nella speranza di un miglioramento e poi rigettati a causa delle loro violenze – trascolorò nella guerra civile, nella lotta senza quartiere tra le opposte fazioni, assumendo i caratteri di una guerra sociale (come avrebbe osservato lo Stuart «(è) la guerra della povera gente… contro la classe più elevata»), potentemente coadiuvata dal brigantaggio e conclusasi con l’opera di sottomissione del “terribile” Massena e con la feroce repressione del Manhes.
Irretite dalle asperità dell’événementiel, esacerbate dalla violenza delle armi e fomentate dalla corte borbonica – in esilio in Sicilia e desiderosa di revanche, soprattutto la Regina Maria Carolina – le popolazioni scatenarono una violenta reazione che, più che di stampo legittimista, in una provincia tartassata e subissata, presenta i caratteri di una rivolta contro i nuovi venuti e trae le sue radici dall’humus politico e sociale. A ciò contribuì potentemente anche il configurare con i Francesi il volto di certa borghesia arricchitasi e ancora in fase di ascesa economica con lo sfruttamento degli eventi politici favorevoli.
L’occupazione francese non era un cambiamento di dinastia; essa costituiva un cambiamento di leggi, di costumi, di principi ma – ahimè!– portato sulla punta delle baionette. Ma non fu la fortunosa, o fortunata, conquista delle Calabrie da parte dei Francesi, con tutti i drammi profusi a piene mani da Memorie del tempo, né la repressione del brigantaggio: a configurarsi è la vita organizzata delle province calabresi che i Francesi hanno sottratto a un secolare isolamento e a un’arretratezza economica e amministrativa inconfutabile, per avviarla a una modernizzazione di forma di vita sociale più consona ai tempi a venire.
Rosella Folino Gallo
La Battaglia di Maida del 4 luglio 1806 nel contesto storico e sociale della Calabria
La battaglia di Maida del 1806 s’inserisce nella storia moderna non solo per gli equilibri militari e politici d’Europa, ma per la storia della Calabria, da secoli campo di battaglia di eserciti stranieri senza che mai i suoi abitanti ricoprissero ruoli significativi. Solamente i vecchi baroni si alleavano di volta in volta con chi permetteva loro di perpetuare il loro antico predominio sociale. Il panorama storico risultava dominato da sanguinosi duelli tra le maggiori potenze europee.
La Calabria viveva agli albori del XIX secolo realtà economiche ancora avvinghiate a strutture feudali e l’estrema labilità del suo tessuto sociale ne faceva ideale terra di conquista. L’unica risorsa economica di sussistenza rimaneva la terra. Dalla terra scaturivano attraverso il duro e quotidiano lavoro dei Bracciali i frutti della sopravvivenza di tutti anche se il sistema limitava fortemente lo sviluppo produttivo delle terre. I prodotti agricoli rappresentavano non solo il sostentamento naturale, ma erano anche merci apprezzate per l’esportazione. Il commercio avrebbe quindi potuto rappresentare una significativa forma di economia se solo ci fossero stati strade e porti agibili: seta, vino, uve e oli giungevano in Inghilterra il più delle volte per metà guasti. La Calabria era ricchissima di boschi e nei primi anni del 1800 rappresentava l’area regionale a più alta densità boschiva del meridione. Ma anche l’enorme patrimonio di legname appariva irrimediabilmente come una risorsa malissimo amministrata e quasi per nulla utilizzata. Ma in Calabria cominciava a trovare spazio il dibattito culturale e sociale europeo basato sulla polemica antifeudale e sulle prime riflessioni di economia politica che avevano preso avvio dalla Rivoluzione francese.
La Rivoluzione francese innestò anche uno sconvolgimento militare in tutta Europa e nel bacino del Mediterraneo. Nei mari attorno alla Calabria si scontrarono presto inglesi e francesi. Nel febbraio del 1806 i Francesi occuparono militarmente Napoli mettendo in fuga il sovrano borbonico Ferdinando IV e mossero verso sud. In Calabria furono numerose le rivolte popolari antifrancesi. L’Inghilterra diede inizio allora ad una serie di approdi militari sulle coste calabre. Il 30 giugno una flotta inglese, al comando di Sir John Stuart, approdò sulla baia di Sant’Eufemia e si inoltrò lungo la pianura verso Maida. Sulle alture attorno a Maida stazionava il generale napoleonico Reyner con cinquemila uomini e sei cannoni. L’impatto fu allora inevitabile. lo scontro avvenne la mattina del 4 luglio: una battaglia rapida che scompaginò le linee francesi costringendo i soldati napoleonici alla fuga. Gli inglesi rinunciarono all’inseguimento e concessero ai francesi di riorganizzarsi e di ricevere rinforzi: infatti, nello stesso mese di luglio rioccuparono quasi tutta la Calabria. La battaglia di Maida fu simbolo dello scontro di due mondi: da una parte vi erano le nuove idee giacobine, fondamento di civiltà e democrazia, dall’altra le forze reazionarie e conservatrici di decrepiti ordini sociali. Ma la storia non è mai semplice e netta: i francesi vollero imporre con la forza quelle idee originando solo ostilità nei calabresi e gli inglesi si trovarono sul fronte opposto solamente per motivi politici e militari legati alla loro profonda opposizione ai disegni egemonici napoleonici. Basti pensare al ruolo inglese durante la spedizione dei Mille e a quello che rappresentò Londra per uno dei padri mistici della nostra unità: Giuseppe Mazzini.
Salvatore Piccoli
La Battaglia di Maida nell’archivio Bonelli e la guerriglia antifrancese
La Battaglia di Maida è un avvenimento non molto conosciuto, se non agli addetti ai lavori ed agli appassionati di storia calabrese ed io stessa ne ho appresa l’esistenza allorché, sfogliando tra le carte di una famiglia, ho scoperto un diario scritto da un antenato e che ho pubblicato agli albori della mia carriera universitaria. «Alli principi di marzo 1806 scese nel Regno una formidabile armata francese comandata da Giuseppe Bonaparte»: così un galantuomo di Girifalco, borbonico di sicura fede, don Raffaele Bonelli, vissuto tra la presa della Bastiglia ed il crollo del Regno delle due Sicilie nel 1860 inizia a descrivere l’evento in Memorie da leggersi e regolarsi a ben vivere di mio figlio Pietrantonio.
Lo scritto è una miscellanea di pensieri ed esposizione di fatti (dal prezzo delle patate, al racconto dei terremoti e delle epidemie di colera; dalle gesta dei briganti come Pane di grano, e Benincasa, alla schietta e primitiva esultanza per la pioggia che era riuscita a salvare, appena in tempo, un raccolto; dal racconto particolareggiato della sommossa del 1848, vaticinata dalla Società “Unità” con il suo capo Magno, alla sopravvivenza dei vecchi diritti feudali; dal messaggio di Garibaldi alla gente del sud, alla diligente annotazione delle tomolate di terreno coltivate a grano) che hanno il precipuo compito di consigliare, ammaestrare il figlio maggiore ed erede Pietrantonio.
Ma vi è anche la seguente annotazione: «... nella nostra Calabria era situato un corpo d’armata di circa 12000 uomini comandato dal generale Rogier che era posto in linea fino a Reggio e prima dell’anno 1806 del mese di luglio; approdò nel Golfo di Sant’Eufemia l’armata navale inglese e sbarcò una divisione di truppe comandata dal generale Stuart ed al 4 luglio di detto anno nella marina di Maida dette battaglia alla marina francese che era comandata dal generale Rogeri uomo esperto nell’arma; alla vista dell’armata inglese successero emozioni in molti paesi della Calabria, sostenuti dagli inglesi si sollevarono e successe la rivolta e nuovamente li calabresi si dettero agli eccidi, saccheggi e rapine. Li francesi della marina di Maida si ritirarono in Catanzaro, ma le truppe di massa li inseguirono e furono costretti attaccandosi ogni giorno colla massa, ritirarono in Crotone…».
Reynier non era uno sprovveduto; era un generale di esperienza, padrone della tattica militare; ma fu costretto a ritirarsi con le sue truppe ormai allo sbando, meditando su una battaglia combattuta e perduta e su una rivincita che solo il tempo e gli aiuti inviati in Calabria, alla guida del generale Massena, avrebbero risolto a suo favore.
Nel frattempo, però, era esplosa in Calabria la rivolta contro i francesi, fomentata dagli inglesi che avevano pianificato una strategia di logoramento dell’esercito di Napoleone, alla scopo di impedirgli di passare lo Stretto ed invadere la Sicilia; perciò, impiegando denaro e promesse di aiuto, mobilitarono le masse popolari, che si lanciarono contro i resti delle truppe sconfitte a Maida, non risparmiando neanche i feriti. Il piano inglese prevedeva quindi non una guerra, ma la distruzione sistematica, oltre che degli uomini, anche di viveri e mezzi di trasporto. Le masse popolari in armi si sarebbero dovute trasformare, come almeno inizialmente si verificò, in una spina nel fianco dell’esercito napoleonico.
Non una guerra, quindi, ma una guerriglia; veri e propri atti terroristici caratterizzati da imboscate, dalla rapidità dell’attacco e dalla fuga degli attaccanti dopo l’azione, sortite veloci contro le posizioni francesi, impedendo i rifornimenti, con lo scopo di fiaccare e disperdere le forze nemiche che avrebbero dovuto volgere ad una umiliante ritirata. Perciò gli inglesi non risparmiarono mezzi e promesse, stringendo patti, possiamo dire, anche col diavolo, i numerosi capibanda che scorazzavano “santificati” all’epoca della Repubblica napoletana, nel 1799, dal Cardinale Ruffo.
Ernesta Bruni Zadra
Quell’uom dal fiero aspetto
Se c’è un personaggio del nostro sud capace di conquistarsi una fama mondiale che si protrae a duecento anni dalla morte, questi è il colonnello Michele Pezza, meglio noto come Fra Diavolo. A costruirgli attorno una sorta di leggenda nera ci ha pensato una storiografia faziosa, figlia della propaganda filo francese che aveva interesse a dipingerlo come un brigante sanguinario. La sua vicenda umana ci racconta invece ben altra verità. Ed é giusto ricordarla, nel bicentenario dell’impiccagione che a soli 35 anni pose fine alla sua carriera d’indomito guerrigliero legittimista.
Alimentò sin da fanciullo la leggenda, quando le sue marachelle gli fruttarono la trasformazione in Fra Diavolo del nomignolo Fra Michele dovuto all’abitino da frate indossato per esorcizzare una malattia. Il carattere generosissimo, ma irascibile lo rese responsabile di un duplice omicidio commesso forse per difendersi in una rissa o forse per salvare l’onore di una fanciulla.
Datosi alla latitanza, ottenne la commutazione della pena in 13 anni di servizio nel corpo dei fucilieri di montagna. Coinvolto nella ritirata delle truppe napoletane allo scoppio delle ostilità con la Francia, decise di combattere a modo suo con un gruppo di volontari nel bel mezzo della gola di S. Andrea, presso il paese natale. Di fronte alla sua micidiale ed inedita tattica fatta di fulminei colpi di mano e di altrettanto subitanee scomparse, gli invasori reagirono saccheggiando Itri e massacrandogli il padre. Fa parte del mito il giuramento di vendicarlo che Fra Diavolo avrebbe pronunziato sulla tomba, mentre è realtà il filo da torcere che dette al nemico tagliandone di fatto le comunicazioni da Terracina a Capua.
L’eco delle sue gesta preoccupò la Francia ed entusiasmò la corte borbonica e gli stessi inglesi. Nella successiva controffensiva di Ruffo che scacciò i francesi dal regno, Fra Diavolo guidò l’ala sinistra dell’esercito del duca di Roccaromana fino a Roma. Liberò Velletri, Marino ed Albano dall’incubo del sacco nemico. Nominato colonnello, visse gli anni seguenti angustiato dai creditori, a causa degli impegni che aveva contratto in favore dei suoi uomini durante la guerriglia.
Alla seconda invasione napoleonica Fra Diavolo tornò a praticare la guerriglia ai danni dei francesi impegnati nell’assedio di Gaeta. Richiamato a Palermo, partecipò alla spedizione della flotta inglese nel golfo di S. Eufemia del luglio 1806. Mentre risulta che galvanizzò i difensori di Amantea, non trova riscontro la versione che, dandolo presente pure a Maida, gli attribuisce il merito di aver spinto l’incerto generale Stuart ad attaccare vittoriosamente battaglia. Provò poi ad armare le masse di Terra di Lavoro, collegandosi con la resistenza delle Marche e degli Abruzzi. Costretto a tornare ad Itri, dopo strenua lotta dovette ritirarsi tra i monti.
Da allora la sua Legione della vendetta venne braccata da ogni parte, perdendo gradualmente i suoi effettivi. La fortuna ormai aveva voltato pagina perché Fra Diavolo non riuscì a difendere neanche Sora, che aveva fortificato. Da ultimo rimase del tutto isolato dai compagni, in una zona non conosciuta e con un’ingentissima taglia sul capo. Disarmato e scalzo, venne arrestato a Baronissi per la delazione del farmacista cui s’era rivolto per una ferita. La sete di rivincita dei Bonaparte non gli perdonò i tanti scacchi subiti. E così, dopo un processo sommario, alle ore 13 dell’11 novembre 1806, il più grande guerrigliero del Regno di Napoli dovette subire a piazza Mercato l’oltraggio della forca, che si riservava ai comuni criminali. Poco prima aveva respinto l’offensiva proposta di passare al nemico.
Gaetano Marabello
La battaglia di Maida nelle vicende rivoluzionarie del Risorgimento
Richard Hopton, nel suo saggio intitolato The Battle of Maida. 1806. Fifteen Minutes of Glory (Pen & Sword, London, 2002) giustamente, inquadra la battaglia di Maida all’interno dei due avvenimenti più importanti relativi alla Terza Coalizione: la vittoria di Nelson a Trafalgar, che pose fine a qualsiasi pretesa francese di poter sfidare gli inglesi sul mare, e Austerlitz, che stroncò qualsiasi speranza per gli eserciti della Coalizione di annullare l’ambizione di Napoleone nell’Europa continentale. Infatti, – sostiene Hopton – malgrado le schiaccianti vittorie di Napoleone a Ulm e Austerlitz, per gli alleati «ci fu un barlume di luce in tutte quelle tenebre: la battaglia di Maida. La sola vittoria conclusiva ottenuta dagli eserciti della Terza Coalizione […]. Fu una piccola battaglia, con 11.000 combattenti in tutto, combattuta su una spiaggia lontana dal centro dell’Europa. Essa non può essere vista, in senso stretto, come parte della storia della Terza Coalizione che era stata dichiarata morta 6 mesi prima con la pace di Presburg. Ma Maida era un figlio di questa alleanza, sebbene un figlio postumo».
Nel valutare la battaglia, Hopton riporta due commenti. Il primo è quello di William Windham, segretario alla guerra, il quale, nel ricevere la notizia della vittoria inglese, asserì, certamente esagerando, che essa aveva la stessa grandezza di Poitiers, Crecy e Agincourt negli annali della storia militare britannica. Il secondo giudizio è quello del Times il quale forse era più vicino alla verità quando pubblicò la notizia sotto il titolo «Glorious Victory».
La battaglia di Maida, sottovalutata dai “grognards” napoleonici che quasi con disprezzo hanno parlato de «l’affaire de Sainte Euphemia» come «la bataille d’un quart d’heure», non merita – conclude Hopton – l’oblio storico. Essa, infatti, mostrò come sconfiggere i potenti francesi e, come tale, presagì i trionfi della guerra peninsulare. A sostegno della sua tesi Hopton riporta l’osservazione di Charles Oman il quale afferma: «la poco ricordata calabrese battaglia di Maida fu un giorno che fece epoca nella storia militare britannica. Sulla pianura sabbiosa dell’Amato 5.000 fanti in linea ricevettero l’urto di 6.000 in colonna e inflissero loro una delle più grandi sconfitte».
L’importanza della battaglia di Maida nella storia militare è stata ben messa in evidenza da Piero Pieri nella sua Storia militare del Risorgimento (Einaudi, Torino, 1962, p. 14). Secondo Pieri la battaglia di Maida segnò «il trionfo dell’azione tattica distruttiva dell’arma da fuoco contro l’azione tattica risolutiva dell’arma bianca».
Per i francesi la battaglia di Maida rappresentava l’opportunità di punire definitivamente gli inglesi per la loro temerarietà, «buttandoli a mare» e – come ha scritto Hopton – aggiungere Sir John Stuart alla lunga lista di generali che avevano tentato, ma avevano fallito, nello sfidare la potenza della Francia sul continente europeo.
Per l’Inghilterra, invece, il piccolo esercito di Stuart, giunto a S. Eufemia dalla Sicilia, rappresentava in questa parte remota dell’Italia meridionale l’ultima speranza di un orgoglio che poteva essere salvato dal disastro definitivo. Questo piccolo esercito rappresentava la speranza di poter mettere qualche limite alle ambizioni continentali di Napoleone. Rappresentava anche – come ipotizza Hopton – la possibilità di mostrare che gli inglesi non erano soltanto una nazione di marinai e che avevano un esercito di terra degno di questo nome.
Ecco perché Stuart poté vantarsi di una vittoria autentica: in due ore aveva eliminato oltre 3.000 francesi, mentre tra le sue truppe i morti erano stati solo 45 e i feriti 283.
La notizia della vittoria fu ricevuta in Inghilterra con grande compiacimento e giubilo. Perfino la House of Lords e la House of Commons votarono ordini del giorno esprimenti soddisfazione per l’evento ed elogio per i combattenti. Il nome di Maida fu associato a quello delle più famose battaglie della storia nazionale inglese. Il Re Giorgio III conferì a Stuart il titolo di duca di Maida ed i principali comandanti ricevettero speciali decorazioni. Venne coniata una medaglia commemorativa e strade e viali presero la denominazione di Maida.
Vincenzo Villella
Il Regno ed il Re
Assunto di questo intervento è che le genti meridionali sono state per otto secoli fedeli al Regno, anche se non sempre fedeli al re che di volta in volta regnava.
Per questa ragione un mutamento di dinastia non apparve altro che un avvicendarsi di persone, al più di partiti, mai un dubitare della natura statale del Regno.
Tuttavia le vicende del Meridione non furono affatto serene e, come accadde del resto a tutti i reami d’Europa, vi si può individuare una continua, strisciante guerra civile, sia pure indefinita e mutevole, che ebbe inizio già con i primi avventurieri normanni. Per questa ragione, le tendenze centrifughe furono sempre altrettanto forti degli intenti dei sovrani di accentrare poteri e amministrazione.
Anche nel Meridione si possono individuare dunque le costanti della storia europea di quei secoli: il re tenta di sottoporre a sé tutti i sudditi; i feudatari cercano di abusare delle loro funzioni; le città e i borghesi sono, in genere, dalla parte del re.
Tralasciando troppo remote ragioni, la genesi degli eventi del 1799 e del 1806–1815 va ricercata proprio nei due secoli del viceregno, che possono distinguersi in due distinti momenti.
Gli eventi del 1647, noti come la Rivolta di Masaniello, sono un vero scontro di classe, segno dell’inquietudine dei ceti popolari. Difatti, nel 1708, divampando in Europa la guerra di Successione spagnola, Napoli e Sicilia passano a Carlo d’Austria, poi Carlo VI imperatore. Forse quell’Italia confederata era soluzione migliore della violenta e soffocante piemontesizzazione del 1860.
Il Reame meridionale si poneva come egemone dell’Italia e vindice della sua libertà.
Gli ultimi decenni del decaduto vicereame castigliano avevano segnato momenti di trascuratezza amministrativa, di cui avevano approfittato i feudatari, i cui “abusi”, cioè l’arrogarsi poteri regi, vennero subito repressi. La politica estera dei due regni fu improntata alla massima indipendenza possibile, fino a negare il vassallaggio della Chiesa per Napoli; e una flotta attiva difese le coste dai pirati barbareschi.
Come ai tempi degli Svevi avevano chiamato gli Angiò, con le conseguenze che sono note, ai tempi dei Borbone un partito timoroso dell’autorità regia attirò altri re francesi, sebbene questi, nel 1798, si facessero chiamare repubblicani. Ma nel 1806 cadde anche la finzione, e il loro capo si intitolò re, del resto Napoleone era già da due anni imperatore. L’eterna storia: un re contro un altro re.
La corte borbonica di Palermo, impegnata a difendere l’isola dalle minacce di Murat, e in subbuglio interno che porterà alla costituzione del 1812, poté poco, al di là della rioccupazione di Crotone per qualche mese del 1808, e della spedizione di Philipstadt fino a Mileto. I re di Gran Bretagna sono di origine tedesca. Per le popolazioni, dunque, o almeno per uno dei loro partiti, poteva venire deposto un re della dinastia di Borbone ed elevato, al suo posto uno della neodinastia dei Bonaparte o dei Murat. Continuarono a ritenerlo così anche i “patrioti” del 1820 e del 1848. Averlo scordato nel 1860 nel nome di un ingenuo o callido entusiasmo unificatorio, è forse la causa prima di tutti i mali del Meridione.
Ulderico Nisticò
Appartenenza e senso di fedeltà alla corona nel Regno di Napoli in età spagnola
Le rivoluzioni, le rivolte, le sommosse, le congiure e qualsiasi altra forma di insubordinazione nei confronti del potere costituito hanno sempre attratto in misura considerevole l’attenzione degli storici, pronti a rilevare ed indagare qualsiasi elemento di rottura, tendente ad introdurre ogni sorta di modificazione in seno agli Stati e alle relative società del passato. Dal punto di vista storiografico, è superfluo sottolinearlo, ciò risulta del tutto naturale giacché è proprio ponendo l’attenzione verso fenomeni del genere che si possono cogliere le motivazioni e le reali spinte che hanno portato le società e gli Stati ad evolversi dinamicamente verso forme di progresso.
Se dunque l’attenzione verso “l’eccezione” è stata nel tempo alta e costante, quella verso “la regola”, al contrario, raramente è apparsa adeguata e significativa. Così, diversamente dagli studi su rivoluzioni e rivolte, abbondanti e significativi, la produzione di ricerche sul consenso, la fedeltà e la lealtà alle proprie istituzioni non sempre si è rivelata all’altezza delle aspettative: anche gli studi sul Regno di Napoli in Età moderna non fanno eccezione, confermando in modo inequivocabile tale tendenza.
Il contributo, così, sebbene in forma preliminare, si è proposto di indagare quali furono le reali motivazioni che spinsero, salvo rare eccezioni, la stragrande maggioranza della popolazione del Regno di Napoli a rimanere sostanzialmente fedele alle proprie istituzioni e alla Corona spagnola per oltre due secoli, fra gli inizi del Cinquecento e quelli del Settecento, anzi a sentirsi parte integrante del sistema spagnolo che, conscio della diversità dei popoli che lo costituiva, fu più rispettoso di quanto si possa immaginare di istituzioni e tradizioni dei regni e delle popolazioni che si trovò a dominare.
In questa ottica il punto di riferimento naturale appare il pensiero e l’opera del filosofo spagnolo tradizionalista Francisco Elías de Tejada (1917–1978) che, alla visione classica e consolidata dalla storiografia italiana di una Napoli in crisi, resa schiava dagli Spagnoli e incapace di qualsiasi vivacità, contrappone quella di un Regno di Napoli che, all’interno del sistema spagnolo, mantenne intatte le proprie istituzioni e la propria cultura partecipando a pieno titolo e condividendo le imprese dei sovrani spagnoli in difesa della fede cattolica e di una visione del mondo a cui altre e nuove, nel corso dell’Età moderna, venivano a contrapporsi prepotentemente.
Il pensiero napoletano di quel tempo, con le sue talvolta originali idee in materia di organizzazione statuale, si trovò in perfetta sintonia con la politica internazionale della Spagna, a conferma del fatto che il regno meridionale era portatore di una visione, forse discutibile, ma sicuramente “altra” rispetto a quella che si stava affermando e consolidando nell’Europa del tempo.
In considerazione di ciò, di questa diversità napoletana, fenomeni come la sconfitta della Repubblica Partenopea o la durissima opposizione delle popolazioni meridionali all’invasione francese e a taluni cambiamenti imposti dagli occupanti, potrebbero confermare, a posteriori, l’inadattabilità del Regno di Napoli a modelli, certamente innovativi, ma elaborati altrove e indubbiamente estranei al sentire comune delle popolazioni meridionali.
Vincenzo Naymo
“Dies irae”: crudeltà e terrore nella guerra civile calabrese
Lo studio delle guerre civili in età contemporanea, dalla rivoluzione francese ad oggi, ci dice a chiare lettere che in esse vi è un eccesso di violenza, alimentato dal fatto che le motivazioni ideali del conflitto armato danno libero corso a esplosioni di rancore, invidie e vendette private. La violenza privata e criminale, in altri termini, approfitta della guerra, al cui riparo essa cerca di nobilitarsi, moltiplicandosi e potenziandosi. Ma è, peraltro, la stessa guerra civile a produrre un surplus di violenza, non conoscendo essa alcun confine tra belligeranti e non belligeranti e prefigurando, dunque, il carattere di “guerra totale” dei conflitti del XX secolo.
Ciò che accade in Calabria dopo la conquista napoleonica e in specie dopo la battaglia di Maida, che costringe alla rotta l’esercito francese, rientra appieno nella categoria delle guerre civili. Ancor prima che dilaghi l’insurrezione antifrancese, si riscontrano episodi di violenza in cui è evidente che lo scontro ideologico tra Francesi e Borboni, Modernità e Tradizione, Laicismo e Religione, è puro e semplice pretesto. È il caso di Soveria, dove una precoce insorgenza nasce come reazione «all’oltraggio di una giovane del luogo» commesso da un ufficiale francese; soprattutto è il caso di Pedace, dove l’insorgenza altro non è che l’assalto sanguinoso ad una famiglia del luogo da parte di vecchi nemici locali, col risultato del successivo saccheggio da parte francese.
Questi fatti si moltiplicano dopo la sconfitta francese di Maida. Il punto di non ritorno è costituito forse dagli avvenimenti di Lauria, dove gli insorti massacrano un battaglione polacco. Subito dopo, il borgo è messo a sacco dall’esercito francese, che riduce uomini e cose ad un cumulo di macerie in fiamme. La vendetta, ad opera dell’insorgenza, non si lascia attendere: a Longobardi, per iniziativa del “capomassa” De Micheli, si fa strage anche di donne e bambini, buttati poi a mare, con l’intenzione palese di colpire a morte i nemici personali dei “massisti” e le loro famiglie.
Ancor più eloquente è un massacro narrato da P. L. Courier. L’ufficiale–letterato racconta che quando i francesi giunsero a Cassano molti abitanti, viste le divise rosse di un battaglione svizzero, li scambiarono per inglesi e corsero loro incontro, abbracciandoli e ringraziandoli per aver scacciato quegli scomunicati dei francesi. Questi ultimi, decisero in seguito di fucilare in piazza cinquantadue cassanesi “filoinglesi”, ma successe incredibilmente che questi «furono eliminati dai loro compatrioti, dai calabresi nostri amici, dai buoni calabresi di Giuseppe, che chiesero come un favore di essere utilizzati in quella carneficina».
Di fronte ad episodi del genere diventa indiscutibile che è la guerra civile, più che l’opposizione ai francesi, la causa delle violenze, di una violenza che covava endemicamente nelle strutture primarie della società locale, dominata «da opportunismi, da ambizioni, da profondi rancori personali, da sordidi interessi privati, da un’ineluttabile brama di vendetta […], in una terra barricatasi da secoli in indistruttibili pregiudizi ed inesorabili costumanze» (Caldora).
Giudizi condivisibili, purché non implichino l’attribuzione delle forme estreme di violenza ad una ferocia primitiva e atavica, dalla quale la civilizzazione ci metterebbe al riparo. Se così fosse, la violenza e la crudeltà tipiche delle guerre civili riguarderebbero solo le periferie arretrate del pianeta o gli strati inferiori del mondo evoluto. La storia del XX secolo ci dice purtroppo che le cose stanno diversamente, che la crudeltà e il terrore non sono sempre altrove, ma germogliano anche nel cuore delle civiltà.
Vittorio Cappelli
Misogallismo del popolo calabrese dalla spedizione del Ruffo ai fatti di Maida
Dalla spedizione del Ruffo alla battaglia di Maida fino alla fucilazione del Murat fu tutta una rigogliosa esplosione di odio che mai i calabresi avevano manifestato nei confronti di tanti altri eserciti invasori.
Da dove nasceva la carica di odio del popolo calabrese nei confronti dei francesi? Forse una plausibile risposta può venire più dall’esame della strategia egemonica messa in atto dalla Francia rivoluzionaria che dall’improbabile risveglio delle coscienze delle masse popolari, risveglio che semmai è da ricercarsi nel versante opposto, tra le schiere di quanti si immolarono per un sogno di libertà combattendo a fianco delle forze francesi non sempre coerentemente leali con i patrioti locali.
Negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione del 1789, la Francia inaugura in Europa una sorta di “imperialismo ideologizzato” con il quale, sulla scorta di principi universali di libertà e di uguaglianza, il nuovo Stato si erge a difensore dei diritti naturali dell’umanità. Esportare la democrazia diventa quindi per la Francia quasi un obbligo contratto con tutti gli uomini della terra, obbligo da onorare con ogni mezzo.
Da questo momento la conquista di un paese non deve essere giustificata da più o meno legittime pretese di diritti dinastici ritenuti usurpati strategie, ma dalla consapevolezza di dover liberare i popoli dall’oppressione morale e politica esercitata per secoli da regimi dispotici.
Le conseguenze derivanti dalle due contrapposte politiche di intervento al fine di estendere la diretta egemonia nei riguardi di un altro Stato sono divergenti e generano reazioni diverse.
Se infatti il nuovo assetto politico conseguente all’occupazione di un territorio in nome di presunte rivendicazioni dinastiche non alterava in genere i rapporti di classe, né tanto meno incideva in modo radicale sull’esercizio dei privilegi tradizionalmente riservati alle classi dominanti, la conquista compiuta in nome di alti principi che esaltavano la libertà e l’autodeterminazione dei popoli obbligava la Francia ad esercitare una capillare intromissione nelle pieghe stesse della vita politica, sociale ed economica del paese “liberato” finalmente dalla tirannide.
Individuati pertanto i regimi “canaglia”, quegli Stati cioè dove era negata ogni forma di libertà, la Francia si assume il compito di esportare la democrazia con la forza delle armi per venire incontro alle istanze di rinnovamento manifestate a suo giudizio da nutrite schiere di “patrioti” operanti nell’ambito di contesti politici liberticidi.
Uno dei territori più favorevoli a legittimare un intervento armato in nome dell’immortale triangolo della ragione (libertà, uguaglianza, fratellanza) fu ritenuto il Regno di Napoli dove la monarchia borbonica aveva nel corso degli anni scontentato quasi tutte le classi sociali e anche le stesse alte gerarchie della Chiesa e lo stesso Papa.
La Francia intende liberare il Regno di Napoli dalla tirannia borbonica e per ben due volte, dal 1799 al 1805, manda i suoi eserciti a portare a compimento quel nobile mandato. Ma la Francia napoleonica non si accontenta di occupare un territorio, lo vuole pure amministrare, vuole rifondare un nuovo stato, vuole in altri termini governare e per fare ciò deve colpire interessi enormi, sovvertire gli ordinamenti esistenti, intaccare vecchi privilegi, offendere diritti usurpati, proporre un nuovo ordine e impegnarsi con ogni mezzo alla sua realizzazione.
Scatta, è ovvio, la reazione. Solerti libellisti “laici” e confessionali fomentano l’odio contro l’invasore demonizzato come un nemico di Dio e della “Madre Chiesa”, un procacciatore di martiri, un bieco sovvertitore di caste unioni consacrate dal matrimonio. L’esercito della Santa Fede, i lazzari napoletani, i briganti e i manutengoli di ogni contrada del regno hanno finalmente il loro catechismo civile e religioso. Lo devono soltanto applicare contro l’invasore e i suoi fiancheggiatori.
Francesco Tigani Sava
Riflessi della spedizione del 1809 nella Piana di Gioia Tauro e in Calabria Ulteriore
Nell’estate del 1809 Ferdinando IV convinse il generale Stuart ad organizzare una spedizione navale contro il continente. Le truppe francesi lasciarono la parte più meridionale della Calabria per Monteleone in modo da accorrere nel punto dove sarebbe avvenuto lo sbarco più massiccio. Alcuni paesi furono quindi preda delle bande di briganti che approdarono facilmente. Altri paesi, armi alla mano, si opposero a simili orde, tra questi Polistena dove il comandante della guardia civica Manfré fu ucciso dai briganti provenienti dal vicino paese di Cinquefrondi, la dura reazione dei francesi che seguì e commentata dal parroco di Cinquefrondi, nel libro dei morti della parrocchia, con la seguente espressione «da civitate nostra posta confinibus accusatus contra extulissa cervicam», accusa confermata nel registro dei morti, presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria dall’annotazione «venne in questo comune la truppa estirpata contro il brigantaggio e contro coloro che di tanto venivano imputati, volge il suo furore ed in tale stato di cose morirono i seguenti cittadini…» e segue l’elenco di trenta morti.
Un cosi triste bilancio non trova riscontro in nessun altra occasione nella provincia; a motivazione possono considerarsi le accuse in una lettera, rinvenuta nei conti comunali del vicino paese di San Giorgio Morgeto, del 10 luglio, del comandante la colonna mobile del 20° reggimento Colin, «il comune da sicuro asilo ai briganti, il governo si aspetta che tutti i cittadini si armino di valore e di coraggio per distruggere gli assassini, ma se un sol brigante penetrerà nel comune voi esperimenterete tutto il rigore della licenza militare, mi lusingo che vi uniformerete perfettamente a questi miei sentimenti per non darmi il dispiacere di venire all’esecuzione degli atti di rigore».
Anche a Bagnara il comandante della guardia civica fu ucciso dal brigante Fica ma in una rissa per la spartizione del bottino, l’assassino venne decapitato dai suoi compari che portarono la sua testa mozza in giro per il paese, nei conti comunali di Bagnara è riportata la seguente annotazione «16 giugno dato alla truppa inglese quando venne per liberarci dell’infame capo Fica pane, vino ed un prosciutto ducati 5,35». Un’altra cruenta zuffa si verificò a Palmi dove, il 4 luglio, nel libro parrocchiale sono annotate le morti di Agostino Vizzari, della moglie e del rivale Giuseppe Rotundo alias Volpe. Angela Valente ricorda che il Vizzari era stato graziato dai francesi per fare la spia in Sicilia ma che contemporaneamente era al servizio degli inglesi.
Un altro ufficiale della guardia civica di Monteleone, fu ucciso dal famoso Bizzarro ma la sua morte venne vendicata con l’uccisione del cugino del brigante tale Speziale alias Cossari, cosi per come si evince nei conti comunali di Pedavoli dalla giustificazione di spesa di 80 carlini per la vettura con cui il capitano della guardia civica, Rechichi, portò la testa a Palmi. A Varapodio i briganti uccisero il sindaco De Felice ma nonostante ciò l’Intendente chiese alla povera moglie che fine avessero fatto i libri dei conti comunali. Il generale Parthennaux, nel ritirarsi ritenne opportuno far saltare il castello di Scilla subendo dopo l’accusa di Murat di aver danneggiato un così strategico bene.
Della scellerataggine degli irregolari si resero conto anche gli inglesi che tentarono di arginare la loro ferocia con veementi proclami dello Stuart e del Martin e con una taglia di 200 pezze per la cattura di Francatrippa e del Bizzarro. Alcuni dei briganti sbarcati furono uccisi, altri ritornarono in Sicilia, ma la maggior parte rimase in Calabria rinvigorendo quelle effimere formazioni che soltanto con la repressione del Manhes furono distrutte; a tal proposito mi sembra opportuno ricordare che Murat diede pieni poteri al Manhes dopo l’uccisione di un altro comandante della guardia civica di Polistena, Lombardi, che sorpreso nel bosco di Rosarno dal Bizzarro fu squartato ed i suoi resti dati in pasto ai cani. E’ quindi nostro dovere esaltare il coraggio dei calabresi di allora riconoscendo, tristemente, come la loro genia si sia oggi persa a tutto vantaggio dei discendenti di quanti essi combatterono.
Roberto Avati
La Terra dei briganti. Memorie elitarie e subalterne delle insurrezioni calabresi
Il brigantaggio ottocentesco, pre e post unitario, una delle più tipiche quanto controverse manifestazioni delle classi subalterne, è stato considerato per lungo tempo come una protesta selvaggia e brutale delle popolazioni meridionali e i suoi principali protagonisti sono stati descritti o come eroi oppure come delinquenti spietati e feroci, a seconda dei punti di vista degli osservatori, data la demonizzazione postunitaria dell’intera vicenda e la sua strumentalizzazione filoborbonica.
Non sorprende, quindi, che per lungo tempo anche stimati studiosi di storia del Mezzogiorno abbiano espresso un giudizio fortemente negativo sulla vicenda del brigantaggio meridionale ritenendola una delle pagine da espellere dalla storia nazionale e da relegare esclusivamente nelle cronache criminali.
Appare abbastanza evidente, da queste brevi considerazioni, che per inquadrare il fenomeno del brigantaggio meridionale adeguatamente e per effettuare una riscrittura della sua storia, un racconto di fatto omesso dalla storia ufficiale del Mezzogiorno d’Italia, vi è bisogno di una nuova griglia concettuale e interpretativa, che tenga conto della mentalità e della politica delle classi subalterne, che proprio a partire dalla fine del Settecento, sia per le sue condizioni di sfruttamento e di disagio sociale, sia per il mutato clima politico e culturale, inizia a manifestare i primi segni di auto coscienza della sua natura di classe.
In queste considerazioni, che non hanno la pretesa di essere esaustive ma rappresentano un primo momento di riflessione, cercherò di esaminare il fenomeno del brigantaggio, in particolare calabrese, attraverso l’esame della letteratura, che possiamo definire amena, e cioè quella produzione culturale, nazionale e regionale, colta, popolare e semipopolare, prodotta sul brigantaggio soprattutto nel periodo post unitario che contribuì notevolmente a diffondere quel mito dei briganti. L’intento è quello di verificare in che modo si sviluppò nell’immaginario collettivo la rappresentazione dei briganti, la cui figura quasi sempre è stata liquidata come avulsa dalla realtà storica, e a seconda dei punti di osservazione, come si è detto, esaltata o demonizzata dalle classi egemoni.
Da quanto emerge dalla produzione letteraria, generalmente il brigante appartiene a classi sociali subalterne, costretto alla macchia per rispondere a una qualche violenza subita e a farsi giustizia da sé, risulta sempre difensore degli umili e avversario dichiarato delle classi egemoni.
Questa tradizione eroica del brigante ribelle si fissa nell’immaginario borghese europeo, individuale e collettivo, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, e si deve ai grandi scrittori Schiller, Byron, Scott, che nelle loro opere consacrarono una rappresentazione sociale del brigante tipica dell’eroe romantico: contrapposto alle istituzioni sociali e all’ordine vigente. Questa percezione, seppur in maniera più colorita e con un’adesione psicologica molto più intensa, traspare in parte anche tra i narratori popolari, in particolare in quelli che raccontavano le “storie brigantesche”, un genere che, alla pari dei cantari, dei lunari, degli almanacchi, delle vite dei santi e delle canzoni, appartiene al patrimonio culturale delle classi subalterne meridionali.
Nei racconti popolari si assiste pertanto ad una circolarità tra cultura colta e cultura popolare, dove però il brigante è considerato un uomo del popolo, che seppur conduce una vita riprovevole ed esecrabile, comunque ne condivide lo stesso sistema di valori. Ed è proprio questa condivisione, che molto spesso nella realtà rispecchiava un appoggio materiale da parte delle singole comunità ai briganti, a determinare quell’adesione sentimentale e psicologica del lettore/ascoltatore con il racconto.
Daniele Casanova
Intellettuali per la rivoluzione: Antonio Jerocades e la massoneria alla marsigliese
Il Mezzogiorno ed in particolare la Calabria, nella seconda metà Settecento, sono caratterizzati, da un lato, da una profonda arretratezza, dall’altro dall’esigenza di radicali trasformazioni proposte, per lo più, da intellettuali che fanno propri gli ideali riformisti e rivoluzionari provenienti dagli ambienti illuministi europei.
Tra questi emerge con forza la figura dell’abate Antonio Jerocades di Parghelia, “voce solitaria e nuova” in quel periodo, il quale denuncia l’arretratezza della Calabria dove «il sapere non si estende al di là della pedanteria. L’educazione e la cultura tradizionali gli appaiono come “Erculee colonne piantate a vista della gioventù studiosa per far sì che sbigottita volga indietro lo sguardo”. La scuola e la cultura, invece, devono essere strumento fondamentale per la liberazione dell’uomo, per la “costruzione” di un nuovo sapere, di una nuova società, per l’apprendimento di “un chiaro catechismo cristiano e civile».
Per realizzare questo “progetto”, nel 1768, pubblica a Napoli, dopo averlo sottoposto all’attenzione di Antonio Genovesi, il Saggio dell’umano sapere ad uso de’ giovanetti di Paralia. Uno scritto di pedagogia e di didattica tra i più moderni ed avanzati per quel periodo storico.
Nato a Parghelia (allora Paralia) nel 1838, studia nel seminario di Tropea, luogo culturale non eccelso, ma ha come maestro Andrea Serrao, futuro vescovo di Potenza, assassinato dalle truppe sanfediste del cardinale Ruffo. E’ qui che apprende «i primi elementi dell’umano e del divino sapere, e mosso dalla fama di Martorelli e di Genovesi venni a Napoli ad ammirar quei due valenti in filologia e filosofia e con essi loro mi strinsi in familiare e soave amicizia».
A Napoli conosce e frequenta la migliore intellettualità progressista e insegna economia e commercio, filologia e filosofia all’Università.
L’abate di Parghelia è un intellettuale impegnato che viaggia per l’Italia e l’Europa. Frequenta spesso Marsiglia dove, tra l’altro, vive «una folta colonia di mercanti parghelioti». E’ nella città francese che conosce direttamente uomini e idee della massoneria che gli appare come l’organizzazione politica che può cambiare il mondo e avere un ruolo determinante per il rinnovamento del regno di Napoli.
Ne Le Parabole dell’Evangelio, nel Paolo e ne La lira focense, ma anche in altre opere, sottolinea sempre il ruolo culturale e politico della massoneria ed il possibile, anzi necessario, legame massoneria – cristianesimo, nonostante l’ostilità della Chiesa di Roma, perché tutt’e due hanno come sostrato il concetto di fratellanza.
Ne La lira focense, l’opera più diffusa e conosciuta di Jerodades, scritta in versi, è chiaro il messaggio politico, così come la necessità della lotta contro i tiranni, perché solo dopo la loro sconfitta possono trionfare la libertà e la verità. Fonda logge massoniche ed è in continuo contatto con Marsiglia e le varie realtà rivoluzionarie. Introduce in Calabria la “massoneria alla marsigliese” che poi si diffonde nel resto del regno di Napoli. Le due logge di Tropea e di Catanzaro dipendono direttamente dalla loggia madre di Marsiglia.
Agli inizi degli anni Novanta la massoneria si propone obiettivi rivoluzionari. Ciò anche per merito dell’abate Jerocades che ritiene giunto il momento di passare dalla fase riformista a quella rivoluzionaria.
Nel 1799 combatte per la rivoluzione; nonostante la malferma salute e le continue persecuzioni, è uno dei protagonisti di quella straordinaria esperienza rivoluzionaria.
Condannato al carcere, poi esiliato in perpetuo, nel 1801 torna a Parghelia. Segregato nella “casa dei liguorini” a Troppa, muore il 19 novembre del 1803 senza mai rinnegare le proprie idee, nonostante le pressioni di ambienti ecclesiastici e politici.
Antonio Bagnato
Donne e Risorgimento in Calabria
Un aspetto interessante del fenomeno del Brigantaggio è quello connesso alla realtà femminile. Lo studioso Valentino Romano ha raccolto numerose testimonianze che riguardano il dramma delle brigantesse. «Il fenomeno del brigantaggio approda nel Parlamento che, lungi dal preoccuparsi di tentare – con una saggia politica di riforme sociali – di rimuoverne le cause, sceglie la via della repressione, adottando una legislazione speciale, la legge Pica, che instaura il terrore nei territori occupati, la fucilazione sul campo, lo stupro delle donne dei ribelli». In questo contesto matura il dramma delle “brigantesse”, che è dramma della rottura dell’equilibrio familiare, dramma di madri senza più figli, di ragazze orfane dei genitori, di vedove: è dramma di donne disperate che, ribaltando un ruolo stereotipo di rassegnazione e sudditanza, si dimostrano capaci di affiancare con coraggio i propri uomini e partecipare attivamente alla rivolta contadina.
E’ difficile attribuire una data di nascita al brigantaggio femminile, ma una prima significativa figura femminile di Età moderna può essere individuata in Francesca La Gamba, nata a Palmi nel 1768 e attiva nel decennio di occupazione francese (1806–1816). Francesca, filandiera di professione, madre di tre figli, divenne capobanda, spinta da un’incontenibile sete di vendetta contro i francesi che l’avevano colpita negli affetti più cari. Rimasta vedova del primo marito, dal quale aveva avuto due figli, convolò in seconde nozze. Avvenente d’aspetto ed esuberante nel carattere, attirò le mire di un ufficiale francese che, invaghitosene, tentò – forte della sua posizione sociale – di sedurla.
Respinto dalla fiera Francesca il militare pensò di vendicarsi in maniera terribile. Notte tempo fece affiggere un falso manifesto di incitamento alla rivolta contro l’esercito francese di occupazione ed il mattino successivo fece arrestare i figli della donna, accusandoli di essere gli autori della bravata. Alle suppliche di Francesca, l’ufficiale fu irremovibile: i giovani subirono un processo sommario e furono fucilati. Francesca, pazza di dolore, si unì ad una banda di briganti che operava nella zona, dismise gli abiti femminili ed indossò quelli dei briganti. In breve fornì prove di ardimento tali da divenire il capo riconosciuto della banda stessa, seminando ovunque il terrore. I francesi si accanirono nella caccia della donna, fino a quando un loro drappello cadde in un’imboscata tesa da Francesca. Tra i soldati fatti prigionieri la sorte volle che ci fosse proprio l’ufficiale suo nemico. Con una coltellata Francesca gli strappò il cuore e lo divorò ancora palpitante.
Nell’orrore di questa vicenda, pure caricata di colore dal mito, possono leggersi le ragioni che hanno spesso indotto tranquille popolane meridionali a trasformarsi in Erinni vendicatrici: la prevaricazione degli occupanti, il loro disprezzo per gli affetti feriti, l’irrefrenabile ansia di vendetta suscitata nei popoli conquistati. Crollato il mondo familiare intorno al quale si è costruita a fatica una pur misera esistenza, la vendetta femminile si dimostra ancor più feroce di quella maschile. Si tratta di fenomeni tuttavia limitati che fanno da contraltare a tanti episodi di rassegnazione e di pianto: costituiscono un’eccezione, insomma, non già la regola.
Appare dunque azzardato il tentativo di attribuire autonomia assoluta al brigantaggio femminile preunitario. Forse sarebbe più corretto parlare di una “questione dentro la questione”. E questo non sminuisce il ruolo delle donne nella rivolta contadina. Anzi, lo amplia e agevola la comprensione dell’intera questione delle classi subalterne meridionali.
Caterina Capponi
Preti e rivoluzione: l’orazione eucaristica per le Vittorie di Sua Maestà recitata in Monteleone il 24 agosto 1799
Nella rivoluzione napoletana del 1799 il ruolo della Chiesa e degli ecclesiastici fu senza dubbio molto importante. La Chiesa fu chiamata a svolgere un vero e proprio ruolo di supplenza allo Stato: si offrì come il solo, intollerante cemento ideologico, riuscì a coagulare intorno a sé masse rurali, ceti poveri o spaventati dalla rivoluzione.
E’ appena il caso di ricordare in proposito la figura e l’opera del cardinale Fabrizio Ruffo per la riconquista del Regno e la diretta partecipazione di numerosi ecclesiastici alla controrivoluzione, in particolare di tre preti, Cimbalo, Apa e Sacchinelli, che presero parte agli avvenimenti della Repubblica Napoletana.
“Altare” e “Trono” furono i cardini della controrivoluzione, su questi il Cimbalo fondava la società. Fin dalle prime pagine della sua opera sono presenti, e con insistenza e frequenza, il “Trono”, la tradizionale concezione del potere regale, direttamente ricevuto da Dio, il ruolo subalterno e passivo del popolo..
Alla “Sagrosanta Religione” affiancava l’altro sacerdote, che partecipò all’impresa del Ruffo, l’arciprete Francesco Apa, «il Regno ed il Trono, che l’Onnipotente Dio con occhi benevoli ha sempre riguardato, pria di tutto ponendo in salvo il nostro amabilissimo Re Ferdinando IV, colla tenerissima nostra Madre Regina Maria Carolina, e l’intiera Augusta Real Famiglia».
La rivoluzione era «causa – scriveva il terzo ecclesiastico, l’abate Sacchinelli – di sciagure, di ribellione, di tumulti e di anarchia; era anche origine di disordini, di rovina, di insidie alla religione, al Trono e all’ordine promulgato». Attaccamento alla religione, desiderio di salvare le proprietà, la vita e l’onore delle famiglie, entusiasmo, castighi tra i più severi, ricompense avevano giustamente, e con successo, armato la mano dei controrivoluzionari.
Anche a Monteleone, il 4 agosto del 1799, alcune settimane dopo la conquista di Napoli da parte dell’Armata della Santa Fede, furono celebrate «solenni Feste per le felici Vittorie di Sua Maestà, essendo sindaci gl’Illustrissimi Signori D. Gio. Battista Ceniti, e D. Domenico Siliato»; nella chiesa di S. Leo Luca, abate e protettore della cittadina, fu «recitata un’orazione eucaristica dal Rev. D. Gio. Francesco Di Alessandria».
Il breve lavoro, molto organico e chiaro, con una copiosa presenza di citazioni latine tratte dai Sacri Testi, è articolato in un’introduzione e in cinque brevi parti.
Il sacerdote stabilisce un paragone tra la liberazione del Popolo di Israele, oppresso dal tirannico Governo della “furibond’Atalìa”, e «una nuova straniera non men furibonda, ed irreligios’Atalìa, che avea occupato il nostro Regno, e del Regal Trono, e Regia possanza illegittimamente investitasi, in contribuzion ci avea messi, ed in ischiavitù». Segue un’appassionata lode di «Fabrizio cardinal Ruffo, nato alle grand’imprese».
Il sacerdote riflette su un’orrida visione della rivoluzione, si sofferma sui passati pericoli, «le più nere immagini, ed orrorose di perfidie, di tradimenti, di calunnie, e minacce, di straggi, di ferite, di sangue; eppur tutto ciò, anzi che scemare, fa crescere la gioja, e nuovo lustro aggiunge all’odierna solennità, e più visibile splendore».
E’ finalmente giunto «il giorno della salvezza, del Regno di Dio, i satelliti tutti della vera Tirannia, dell’oppressione, dell’empietà fuggono sbigottiti».
La potestas Christi stende, ormai, il suo scettro sul Regno, signoreggia Ferdinando, sorge la bell’Aurora, si mettono in fuga le tenebre. Sotto il Re «goderemo della vera libertà Cristiana».
Mario Casaburi
La resistenza calabrese all’occupazione francese (1806/1813) e sua incompatibilità con l’agiografia risorgimentale italiana
Perché nei nostri libri di storia non vi è traccia della battaglia di Maida? Eppure essa fu l’unica vittoria militare della Terza Coalizione contro Napoleone! E ancora, perché nei nostri libri di storia non vi è traccia delle insorgenze popolari calabresi contro gli invasori francesi e delle stragi di inermi civili da questi commesse?
La risposta a tutto questo non è poi così difficile da trovare se studiamo con attenzione il periodo 1796-1815 che vide l’Italia invasa dai rivoluzionari francesi e successivamente dalle armate imperiali napoleoniche.
All’invasione seguirono intense insorgenze controrivoluzionarie che si svilupparono da nord al sud della penisola, assumendo fin da subito il carattere di resistenza armata, spontanea e duratura. Queste insorgenze sono taciute dalla storiografia ufficiale, alla pari di quelle antiunitarie del 1860-1880, in quanto incompatibili con l’agiografia risorgimentale.
Infatti, tutti sappiamo che il concetto di “nazione Italia”, ovvero il Regno d’Italia, nasce nel 1796 con la costituzione, avallata da Napoleone, della Repubblica Cispadana, con tanto di tricolore ed esercito cui furono aggregate la Lombardia, Venezia e poi altre province minori. Capitale del regno fu Milano. Sappiamo anche che il Regno d’Italia fu sotto Napoleone uno stato vassallo “modello” che fornì numerosi contingenti militari che combatterono contro Austria, Due Sicilie, Prussia, Spagna, Russia, Inghilterra etc. La lealtà del Regno d’Italia verso Napoleone fu e si protrasse imperterrita anche dopo la morte del noto “Ei fu” di accorata “manzoniana” memoria.
Con il Congresso di Vienna, Milano perse le prerogative di capitale ma rimase centro propulsore di un’Italia ideale che poi sarà compiuta con il noto “Risorgimento”, sotto la corona dei Savoia–Carignano con ampia regìa francese ed inglese.
Ma tornando rapidamente agli eventi in oggetto possiamo così riassumerne la cronologia:
Il 27 Dicembre del 1805 Napoleone ordinò al Massena di invadere il sud d’Italia con un corpo d’armata formidabile composto da tre eserciti, uno al comando del Massena stesso, il secondo sotto il Reynier e il terzo formato da italiani del Regno d’Italia sotto il generale Lechi.
A Campo Tenese (9 marzo), l’esercito delle Due Sicilie fu sconfitto dal Reynier ma una gran parte di soldati si disperse sul territorio calabro–lucano, sviluppando una efficace resistenza armata.
Il 12 maggio la flotta inglese si impadronì dell’isola di Capri e di Ponza.
Il 29 giugno Michele Pezza occupò Amantea.
Il 6 luglio 1806 a Maida l’esercito anglo–borbonico sconfisse quello francese infliggendogli perdite rilevanti.
La fuga di Reynier fu disastrosa, il suo ridotto esercito, braccato dai partigiani del Regno delle Due Sicilie, compì numerose rappresaglie contro l’inerme popolazione.
In questo contesto nacque la generale rivolta calabrese e lucana.
La reazione popolare, forte, diffusa e parte organica di un piano generale di insurrezione armata fu trasformata e riportata nei diari militari francesi come aggressione gratuita del popolo verso i soldati della Grande Armée. Paesani ladri, paesani guerrieri, paesani assassini… e così i cittadini meridionali «sont tous des brigands!».
«In questo modo la resistenza popolare calabrese fu svuotata di qualsiasi ideale patriottico», esattamente come accadde sessant’anni dopo con l’invasione piemontese.
Domenico Iannantuoni
Animi inquieti nella Calabria Ulteriore
«Mi tira sig. (sic!) il vedere l’oppressioni delle povere genti che si vedono alla giornata assassinate, e privi di poter faticare». A scrivere, nel 1809, all’Intendente di Calabria Ultra è D. Antonio Miceli, guardia civica di Gizzeria. «Io Sig. la supplico abilitarmi di una ventina di persone per andare in traccia contro detti assassini, e spero mantener la tranquillità alli territori suddetti, come ne’ mesi passati ho fatto». Questo civico sta chiedendo all’Intendente di concedergli un manipolo di uomini armati per contrastare degli assassini, dei briganti che si erano macchiati di omicidi e soprusi contro la povera gente. Dopo che i briganti, nei mesi precedenti, ebbero ucciso il comandante della guardia civica di Gizzeria, Antonio Miceli ne assunse il comando e con un contingente di uomini si diede alla caccia dei banditi. Dunque, Antonio Miceli è, forse, un ligio e convinto sostenitore dell’ordine pubblico? Dopotutto era suo dovere dare la caccia ai banditi.
Quello che colpisce, in fondo, leggendo le sue parole, è la convinzione che sembra caratterizzare il suo lavoro. Ed anche una sorta di rabbia per le condizioni in cui versa il territorio del suo paese, a causa del banditismo. Per diverso tempo, lungo tutto il XIX secolo e buona parte del Novecento la comunità di Gizzeria ebbe grande considerazione di Miceli e del suo operato. Il Tenente civico Miceli di Gizzeria riuscì a stanare il brigante Parafante nella boscaglia di Migliuso, nei pressi del comune di Amato, ove fu ucciso. L’accaduto risale al luglio del 1811. Ma più che per la caccia ai briganti venne ricordato per la sua attività durante gli anni successivi del Risorgimento.
«Intanto accorsero li Signori Luigi Baldaja, Raffaele Schipani, il primo nipote ed il secondo figlio di Nicola ed incominciarono a maltrattare i piantoni e quindi bastonarli disarmali e coi loro stessi schioppi tirarongli dei colpi che fortunatamente andarono a fallire… accorse Domenico figlio di Giovan Battista e nipote di Nicola e bastonò uno de’ soldati di linea… che era col percettore ed osservò in faccia a costui che non avrebbe fatta più fare la percezione in Squillace». Questo episodio narratoci dai documenti dell’Intendenza di Calabria Ultra accadde nella Squillace del 1811. Il caso diviene più interessante per la riflessione storica se si aggiunge che i genitori di questi stessi ragazzi parteciparono, in prima persona, al moto repubblicano di Squillace, arrivando ad erigere l’albero della libertà. Nella prima restaurazione la famiglia diviene vittima della vendetta sanfedista. La vicenda suggerisce una riflessione su un governo tanto agognato da una certa parte dei ceti medio–alti del Regno ma che nella realtà, spesso, deluse le stesse classi sue promotrici – o buone parti di esse.
I due casi ci mostrano se pur nella loro limitatezza di contesti, aspetti ed umori di quel decennio nell’istmo di Catanzaro sulla cui sella siede tra gli altri, proprio Maida. In entrambe le situazioni possiamo osservare mutamenti di scenari nel giro di pochi anni. Quali intenzioni – ove vi fossero – quali spinte e quali interessi stanno dietro alla vita di Antonio Miceli e alle prese di posizione di due generazioni della famiglia Schipani di Squillace? È palese che, in molti casi, la società calabrese che visse l’età della Rivoluzione e il Risorgimento si mostrava spesso irrequieta e pronta a sollevarsi, anche se priva di un disegno unitario e coordinato, retto da salde convinzioni.
Salvatore Bullotta
Il brigantaggio antifrancese in Calabria tra il 1779 ed il 1810: movimento reazionario o guerra popolare di liberazione?
L’analisi degli eventi svoltisi in Calabria tra il 1799 e il 1810 mette in luce il legame tra brigantaggio e insurrezione, considerando il primo non tanto come fenomeno criminoso ma come unico strumento a disposizione delle masse contadine per un loro riscatto economico e sociale. Così nel 1799, di fronte all’affermarsi dell’ideale repubblicano, i contadini formarono un fronte reazionario, unendosi alle bande sanfediste del cardinale Ruffo e combattendo per difendere il regime borbonico.
Essi identificarono la partecipazione al moto sanfedista con la lotta contro i proprietari terrieri (a loro volta sostenitori dell’ideale repubblicano). Tale lotta sfociò in insurrezione nel 1806, con l’arrivo dei francesi in Calabria. Il brigantaggio era l’unica speranza di resistenza popolare contro un esercito di occupazione. Esso assunse anche un carattere politico in quanto fu “opposizione allo straniero invasore” e ai gravami di varia natura che esso imponeva. Le bande dei briganti, pur essendo gruppi eterogenei e indisciplinati, compivano azioni di disturbo e di guerriglia con assalti ai reparti francesi e costringendo alla fuga intere divisioni (come nel caso della battaglia di Maida).
Solo attraverso lo stato di guerra e la dura repressione francese si riuscì a stroncare, anche se non definitivamente, la coraggiosa resistenza di un intero popolo alle armi straniere.
Non bisogna dimenticare che un invasore segue sempre i dettami della sua primaria necessità, cioè quella di dominare i popoli sottomessi in ogni aspetto della loro vita. Certamente i “giacobini” furono portatori di valori e principi ispiratori della Rivoluzione francese, fonte di progresso civile. La loro suddetta necessità però, li portava a controllare, attraverso le istituzioni delle “municipalità”, interi paesi del meridione con un patto non scritto tra i “notabili” del luogo e i loro rappresentanti militari, un ceto nobile–borghese che veniva coinvolto nell’amministrazione dei territori assoggettati o in via di occupazione e l’indistinta massa dei contadini, braccianti, proletari che vedevano gli odiati “galantuomini” vestire i panni dei liberali. Questa adesione dei notabili, nella maggior parte dei casi fu formale, perché impedì qualsiasi provvedimento che potesse suscitare interesse da parte del “popolo”. Così nel 1799 si ebbe il primo e tragico tentativo di affermare nuove istanze politiche e sociali, il cui epilogo mostrò il grave stato di disgregazione cui era pervenuta alla fine del Settecento la società meridionale tutta.
La spedizione sanfedista valse a mettere in luce il fatto che non solo esisteva un profondo divario tra il ceto dirigente e la classe popolare, ma che una frattura divideva le varie frazioni del ceto “borghese”, incapace di un’azione unitaria. L’evento realista è indicativo perché costituisce uno dei primi momenti di protesta sociale che condurranno la società calabrese a forme più evolute di coesistenza politico–sociale. Come sarà significativa la Battaglia di Maida del 1806 in cui scoppieranno tutte le contraddizioni di una società ferma ancora al feudalesimo come stratificazione sociale e distribuzione delle ricchezze.
Gli uomini di Napoleone non incontreranno resistenza a conquistare tutto il Regno fino allo scontro nella pianura maidese dove l’esercito più potente d’Europa subì una sconfitta cocente in una conquista che sembrava facile. Al di là degli episodi militari, è significativo il fatto che, subito dopo Maida, in ogni paesino della Calabria, la gente insorge e non c’è posto in cui i francesi non siano costretti a difendersi dagli assalti e dalle imboscate dei briganti. Il seguito è storia nota, passa per la definitiva occupazione francese della nostra regione, le leggi speciali, la dura repressione, gli arresti ingiustificati e i processi sommari.
La creazione di un fronte proprietario e borghese durante l’invasione, la formazione delle “guardie civiche” nei mesi successivi alla battaglia non nascevano solo dalla paura di un rinnovato sanfedismo ma rappresentava una scelta di campo. Questo dato è importante per valutare la reale natura dell’insurrezione popolare (o brigantaggio?) e i suoi effetti sull’intera società meridionale. Quel conflitto somigliava a una guerra dei poveri contro i ricchi.
A Maida si assiste alla rapidità della formazione delle guardie provinciali il cui nerbo era prevalentemente borghese. Questa forza non era certo autosufficiente ma dava alla presenza francese un carattere diverso dall’occupazione militare mentre forniva motivi di adesione all’appello realista.
Giovanni Cefaly
Il decennio francese nella memoria e nelle tradizioni orali[1]
«Sugnu de Santu Nicola, lu sapiti.
Soprannome Colacchiu su chiamatu.
Vorria mu sacciu de chi paisi siti;
Vorria ‘nu pocu mu su’ rispettatu.
“Tu nde teni sajimi e suppressati?”
Ed eu nci dissi: “Fati chi bboliti,
La cascia è aperta e vi nde pigghiati”.
Mugghierima. chi stava cota cota,
Singa mi facia de la ripata.
“Cittu, migghieri mia, ca si ssi vota,
Non ti la jetta sciocca la trempata!”.
Poi nc’era unu cu ‘nna scimitarra,
Paria lu Cummissariu de la guerra!
“Cittu, mugghieri mia, ca si nci sgarra,
Ti fa cadire cu la faccia ‘nterra”.
Quandu vinneru poi li Nazionali
a mia mi nde mandaru nsini nsini
ca li caddari mi li sbacantaru.
Pe’ mala sorte furu cosentini».[2]
Sanguinari, feroci, vendicativi, violenti, briganti, superstiziosi, bestie feroci: così vengono descritte le popolazioni calabresi dai viaggiatori impegnati nella spedizione francese e nelle relazioni ufficiali.
Ma cosa pensavano i calabresi, i contadini, i “briganti” dei loro osservatori, dei soldati e degli ufficiali francesi? Come li consideravano? Non è facile dare una risposta. I contadini analfabeti, si sa, non hanno lasciato relazioni scritte per gli storici di oggi e l’etnografia si riferisce soltanto alla contemporaneità, raccoglie voci in presa diretta. Tuttavia anche dalle relazioni ufficiali possiamo tentare di conoscere il giudizio, il punto di vista, le emozioni, i sentimenti di chi è stato osservato e giudicato, interrogato e, magari, giustiziato. La disamina critica delle fonti ufficiali ha un’efficacia ancora maggiore se vi accostiamo altri documenti, fonti di tradizione orale, in qualche modo riportabili all’orizzonte e alla sensibilità popolare o comunque ad una tradizione che si fondava sull’oralità più che sulla scrittura.
Non esiste molto per il periodo francese, tuttavia un canto popolare di S. Nicola da Crissa (inserito tra i canti narrativi e aneddotici da Raffaele Lombardi Satriani, nel III volume dei Canti popolari calabresi, pubblicato nel 1932) e di cui ho raccolto una versione negli anni Settanta del Novecento apre spiragli davvero illuminanti per capire il punto di vista delle popolazioni. L’autore del canto, un contadino benestante, che componeva farse e «cacciava storie» rivela un forte senso della dignità e dell’appartenenza e si rivolge ai francesi che vengono da fuori con orgoglio ed esigendo rispetto.
Caterina Martino (1875–1966), nipote del contadino autore del canto, e poi una sua figlia Bosco Caterina (1896–1993) – i cui racconti ho ascoltato tra gli anni Sessanta e novanta – «ricordavano» in particolare: il comportamento violento dei soldati francesi, «metà animali e metà cristiani e rubano le sopressate», fanno razzia di ogni cosa e vanno alla ricerca di belle ragazze, tenute nascoste dai genitori; la minaccia di un ufficiale di mettere a ferro e fuoco il paese; l’intervento miracoloso di S. Nicola che, percuotendo di notte a sangue con il suo bastone l’ufficiale, salva il paese. Siamo in presenza di un punto di vista delle popolazioni che è asimmetrico rispetto a quello degli invasori. La verità ufficiale degli invasori, che si presentano come liberatori, viene ribaltata da quanti si sentono oggetto di oppressione e di violenza.
Le due donne custodivano anche memoria delle gesta del brigante Vizzarro (Francesco Moscato) di Vazzano, che nel territorio di S. Nicola aveva uno dei suoi più famosi nascondigli. Nelle relazioni delle autorità francesi Vizzarro è descritto come un animale sanguinario, un feroce uccisore di innocenti, torturatore e cannibale, ma questi aspetti truci non emergono nelle narrazioni popolari, che privilegiano la simpatia per una persona che diventa brigante feroce per necessità, perché ha subito un’ingiustizia.
Dal racconto di Caterina Bosco viene fuori anche una diversa considerazione del brigante: non una assoluzione, ma una diversa una differente valutazione dei fatti, un’altra prospettiva. Il medico Alfonso Garcea, che cura il Vizzarro gravemente ferito, e viene indicato nelle relazioni ufficiali francesi come un incauto sostenitore del brigante, dal ricordo delle due donne appare un uomo buono e generoso, costretto a “destreggiarsi” (come l’autore del canto) tra briganti e soldati, diversamente violenti. Per popolazioni costrette, sotto minacce e ricatti, a continue scelte di campo, che non condividevano, la simulazione, la dissimulazione, la furbizia, la sagacia, l’ironia si configurano come delle strategie di difesa e di sopravvivenza, delle elaborazioni mentali e culturali che consentivano di mantenere una loro relativa autonomia all’interno di eventi e di vicende da cui si sentivano estranei e lontani.
Vito Teti
I concordati nell’età della rivoluzione e della restaurazione
Sia durante il periodo napoleonico che in quello della restaurazione, i rapporti tra la Chiesa cattolica e gli Stati sono stati complicati, sostanziandosi in accordi di difficile preparazione, i cui contenuti non appaiono certo uniformi. Quanto la Santa Sede sottoscriveva nel concordato napoleonico non era ciò che pretendeva dagli Stati tedeschi o dal Regno di Napoli. Non che non avesse una linea politica uniforme – v’era una continuità anche sul piano personale come con il cardinale Consalvi – ma gli accordi di tipo concordatario dimostrarono tutta la loro duttilità e flessibilità adattandosi alle diverse circostanze politiche del momento.
Certo era più agevole un’intesa con gli Stati cattolici e con quelli monarchici, a conferma che i concordati sono espressione di regimi autoritari e di posizioni legittimiste e non certo frutto della rivoluzione. Con il mondo anglosassone, non solo perché protestante, era impensabile il ricorso a un tal tipo di accordo, che si rivelava difficile anche dove, come negli Stati tedeschi, la riforma era risultata maggioritaria. L’attività concordataria si interromperà quasi del tutto nella seconda metà del secolo XIX e riprenderà in Italia con il fascismo. In quel periodo non si rinvengono voci di enciclopedie sui concordati che non vengono nemmeno presi in considerazione dalla manualistica.
Al tempo del conflitto anglo–francese in Italia e della battaglia di Maida (1806), non era stato ancora sottoscritto il concordato del 1818 e non vigeva certo in quei territori il concordato con la Repubblica italiana del 1803. Il re borbonico era riparato in Sicilia lasciando un vuoto politico e militare che aveva consentito la presenza francese e quella inglese nei propri territori, e le divisioni stesse tra i calabresi, che si ritrovano infatti su entrambi i fronti. Il papa, tradizionale alleato dei Borboni, non poteva fare molto o articolare alcun intervento in loro favore né con i francesi né con gli inglesi. Siamo all’inizio del conflitto con l’Imperatore, già incoronato, e di lì a poco il papa diventerà suo prigioniero.
Tra gli insorti calabresi – ed è questa circostanza davvero singolare – vi sono dei preti come padre Michele Ala, cappuccino e capobanda che all’assedio di Amantea diceva messa sulle mura in faccia ai francesi, o come il sacerdote Giuseppe Papasodero di Centrache, capo degli insorti calabresi che, dopo una prima sconfitta, riuscì a togliere Maida ai francesi per un breve periodo proprio nel settembre 1806. Strane figure più di briganti che di sacerdoti, certamente senza alcun rapporto con la Santa Sede. I sentimenti filoborbonici erano comunque prevalenti non solo rispetto ai francesi ma anche agli stessi inglesi vincitori.
Mario Tedeschi
La missione civilizzatrice della colonizzazione europea e l’odierna frattura coloniale nel Mediterraneo: il caso francese
In un suo stimolante saggio Versant sud de la liberté. Essai sur l’emergence de l’individu dans le tiers–monde, l’egiziano Mahmoud Hussein (pseudomino di due autori: Bahgat Enaldi e Adel Refaat) ci prospetta un insieme di considerazioni circa les chances d’introdurre le libertà democratiche e la modernità nei paesi mediterranei del Vicino e Medio Oriente partendo dall’impresa napoleonica in Egitto nel 1798.
Così ci presenta la spedizione francese: «Momento in cui la storia cerca un’altra possibilità, un’altra prospettiva ai secoli dei Lumi, in cui essa abbozza il sogno, ben presto interrotto, di una conquista del mondo che non si riduca al suo asservimento ed assoggettamento, ma all’integrazione dell’Altro visto come possibile preludio alla sua emancipazione. Ecco il rendez–vous mancato di Napoleone con l’Egitto!».
Viene qui delineato il cruciale dilemma delle colonizzazioni di ieri e di oggi: sono processi di conquista come asservimento dell’Altro o di emancipazione dell’altro verso la modernità all’insegna dei valori della libertà, uguaglianza e della fraternità affermati dalla Rivoluzione francese con la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen?
In uno sguardo retrospettivo della storia coloniale europea nel Mediterraneo a partire dal XIX secolo, constatiamo che dalla complessa problematica della “missione civilizzatrice” di ieri si è passati a quella di oggi, spacciata come “ingerenza umanitaria”, cioè per dirla in parole povere, esportare la libertà e la democrazia con le armi.
Fu quella breve conquista napoleonica un appuntamento mancato sia dal colonizzatore, sia dal colonizzato: l’incontro suscitò grandi attese da ambo le parti come attesta uno dei leader del mondo arabo mediterraneo che è in preda oggi al dramma della democrazia e della modernità esportate a livello globale, non più soltanto sulla punta delle baionette ma dalle armi tecnologiche della superpotenza americana.
Nel 1954 Nasser, infatti, scrive nel suo saggio–manifesto Filosofia della rivoluzione: «E venne la spedizione d’Egitto: la cortina crollò… nuove idee si diffusero tra noi, nuovi orizzonti fino allora sconosciuti sorsero davanti ai nostri sguardi… Fu così che, uscendo dal nostro isolamento, riprendemmo il contatto con l’Europa e il mondo civilizzato: era l’inizio della nostra rinascita!».
Ma come ben sappiamo, quell’incontro si tradusse per i popoli del sud in violenta colonizzazione territoriale, economica e culturale. E per il loro riscatto verso la liberta e democrazia fu necessario pagare un alto prezzo di sangue e sofferenze. Con ricadute che condizionano ancora oggi i rapporti postcoloniali in ogni campo dei paesi euromediterranei.
A cavallo dell’Ottocento e del Novecento si sviluppa tutta una corrente di studio europea sulla diversità delle razze che, riguardo al fenomeno della colonizzazione, porta ad una classificazione tra razze superiore e razze inferiori, processo questo che porterà alla creazione di un immaginario coloniale in cui ovviamente la razza superiore è quella europea.
Hannah Arendt nel suo saggio Le origini del totalitarismo, L’imperialismo, pone la nozione di razza come “chiave di volta” per interpretare l’imperialismo coloniale: «essa punta a dividere l’umanità in una razza di padroni e in una razza di schiavi, in benefattori e in cattivi, in uomini bianchi e uomini di colore» vanificando quindi quei valori e quei principi di democrazia, creando invece una frattura razziale e sociale che è l’asse portante della società coloniale. Frattura coloniale che, rimossa dalla memoria storica nell’era postcoloniale, riemerge oggi criticamente nelle società multietniche e multiculturali delle metropoli europee.
Nel caso francese, risulta evidente la contraddizione tra i valori democratici e universali della Repubblica e la pratica coloniale, che in generale non ha funzionato perché ha sempre prevalso “l’état d’exception” per il colonizzatore nelle varie parti dell’Empire français (per esempio, Le code de l’indigenat per l’Algeria).
E dalla parte dei popoli colonizzati, perché non ha funzionato “la missione civilizzatrice” della colonizzazione? Perché, riprendendo la riflessione di Nasser, le speranze dei popoli del sud di uscire dall’immobilismo politico, sociale e culturale tramite l’incontro con la modernità europea o meglio della cultura occidentale si sono tradotte invece in uno stallo costrittivo d’assoggettamento dove la libertà, la democrazia e il transfert delle conoscenze sono a senso unico ed egemonico e non lasciano spazio e voce alla differenza e alle diversità delle civiltà locali. E tanto più oggi con gli sconvolgenti processi tecnologici della globalizzazione delle culture dominanti come evidenzia storico tunisino M. Taalbi.
Oggi il tema della frattura coloniale inquieta le società postcoloniali delle ex potenze coloniali europee in varia misura, anche quella italiana. Il corso della storia postcoloniale ha riproposto la società coloniale, sotto nuovi aspetti e dati, non più nei paesi decolonizzati bensì nelle realtà sociali delle ex metropoli coloniali dove la politica d’integrazione è in crisi. Il macroscopico fenomeno dell’immigrazione, che ha riversato milioni di ex colonizzati in Europa, ha prodotto e produce processi dirompenti nelle nostre società.
Il caso francese è, a nostro parere, il più sintomatico e dirompente. Oggi la Francia della quinta repubblica è in preda ad un senso di smarrimento di fronte alla sua storia coloniale che, rimossa per decenni dall’immaginario sociale, interpella le varie componenti sociali della nazione dove oggi la memoria coloniale evoca fatti e scenari contrastanti ed ha messo in crisi il modello d’integrazione repubblicano.
Il caso francese è il segnale dello stato di malessere delle società europee che sono in varia misura bloccate in situazione postcoloniali. Le ex potenze coloniali europee che hanno contribuito ad esportare la civiltà europea al di là delle sue frontiere devono decolonizzare la propria storia ed istituzioni perché tutte subiscono sul proprio territorio oggi “il ritorno dell’impero”, cioè l’immaginario coloniale ed i popoli ex-colonizzati dell’immigrazione. Ecco uno dei compiti da fare per costruire una nuova Europa politica e sociale e non solo economica.
Michele Brondino
La battaglia di Maida nella storiografia europea
In un tempo nel quale le immagini rovesciano quotidianamente su spettatori perplessi o assuefatti i drammi della democrazia esportata, può persino tornare d’attualità la lontana battaglia di Maida nella quale, duecento anni fa, giusto il 6 luglio 1806, l’impero trionfante di allora (quello di Napoleone) si trovò di fronte l’inattesa e vittoriosa resistenza delle popolazioni locali (ed allora si trattava dei contadini calabresi). Le montagne che circondano Maida non apparivano del resto ai soldati napoleonici meno minacciose di quanto possano oggi apparire le vette dell’Afghanistan, e la solitudine bruciante di quei luoghi può, a due secoli di distanza, facilmente accostarsi alle poco ospitali regioni dell’Iraq odierno. Persino il meccanismo degli equilibri internazionali aiuta il gioco, certamente un po’ facile ma non infondato, delle comparazioni.
Perché se è vero che l’ostilità delle popolazioni fu un fattore decisivo nell’infliggere una umiliante sconfitta ad armate che fino a quel momento avevano spadroneggiato in mezza Europa, è altrettanto vero che senza l’appoggio che l’Inghilterra, acerrima nemica della Francia napoleonica, si affrettò a prestare agli insorti delle Calabrie non ci troveremmo qui oggi a concordare con chi, tra gli storici di questi due secoli, ha visto nella battaglia di Maida un tornante decisivo della storia dell’Europa napoleonica e della parte che in essa recitò l’Italia meridionale.
Fu, anzi, la nuova strategia adottata dagli inglesi a decidere le sorti della battaglia. Mentre le truppe francesi avanzavano in ordine serrato, pronte a sferrare le linee avversarie quasi per l’effetto stesso del loro procedere compatto, gli inglesi usarono la precisione del tiro di fanteria per seminare il panico e mettere rapidamente in fuga il nemico.
Lo scontro fu brevissimo: si cominciò a combattere alle nove del mattino e alle undici tutto era già finito, ma quel modello di comportamento sperimentato per la prima volta a Maida divenne poi a Waterloo la chiave di volta del successo di Wellington.
L’ombra gigantesca di Waterloo si allunga, dunque, sulla piccola Maida, così come su di essa si proietta l’ombra della Spagna, della resistenza accanita che gli spagnoli opposero qualche anno dopo a quello stesso Giuseppe Bonaparte che dal trono di Napoli si trasferiva su quello di Madrid e che ad essi, come già ai calabresi, apparve nelle vesti dell’invasore piuttosto che in quelle del liberatore. A Maida, d’altronde, è ancora solo il dubbio di una periferia lontana quello che in Spagna diventa un interrogativo conclamato e drammatico: che rapporto c’è tra la libertà (e la democrazia), nate dalla Grande Rivoluzione di Francia e la loro “esportazione” sulla punta delle baionette della Repubblica e dell’Impero?
Chi, tra i liberatori (o conquistatori) si aggira tra le vie del Cairo nei giorni della campagna d’Egitto, nelle campagne calabresi, nei giorni di Maida, tra i villaggi spagnoli più tardi ancora, racconta tutto lo smarrimento, l’orrore talvolta, della scoperta di un mondo in cui libertà e modernità si declinano, se mai si declinano, con parole estranee ed ostili. E nello stesso tempo questo spazio mediterraneo si sta trasformando sotto i loro occhi nel centro di un mondo nuovo che non è più quello della scoperta dell’America ma è già quello che ha al proprio orizzonte l’apertura del canale di Suez. Lo sanno bene gli inglesi che, inseguendo Napoleone, conquistano l’Egitto, occupano Malta, sbarcano nel luglio 1806 in Calabria, per ricordare all’Imperatore che il Mediterraneo non potrà mai essere un lago francese e per ricordare a noi, duecento anni dopo, quanto il nostro Mezzogiorno sia figlio di quelle antiche resistenze e dei quei modernissimi contesti internazionali.
Luigi Mascilli Migliorini
Rivoluzione e popolo tra consenso e rifiuto: libertà e baionette nel Mediterraneo (1789–1815)
Il ruolo dirompente della Rivoluzione francese, la sua capacità di smantellare l’Ancien régime e di creare una società di cittadini portatori di diritti inalienabili sono acquisite.
Esiste una capacità fondante della rivoluzione e dei suoi miti che ne spiega la carica demolitrice verso il passato.
La Rivoluzione non ha esitazioni o dubbi sul diritto di uccidere i tiranni e i loro servi. Basti rileggere La Marsigliese.
La rivoluzione può quindi essere esportata con la forza, marciare sulla punta delle baionette. Un credo che resta saldo anche quando le armate rivoluzionarie sono ormai armate imperiali e non sono più viste come armate liberatrici, ma come armate occupanti da molti popoli o da una parte maggioritaria di essi.
La Rivoluzione esporta un’idea di società fondata sui diritti dell’uomo e del cittadino in quanto tali, e perciò scissi dai luoghi di nascita, dalle Patrie, dalle Nazioni. Conta l’appartenenza al genere umano che dà l’identità soggetto dei diritti.
È questa un’identità forte e che trova consensi al di fuori della Francia. Consensi e alleati.
Ma trova anche opposizioni feroci e indomabili figlie di un’identità alternativa che affonda le radici nel luogo di nascita, nella Patria e nell’appartenenza a un popolo, a una Nazione.
Che rifiuta a priori e comunque l’uso della forza e delle armi e del loro imperio presentati come liberazione.
Se si aggiunge: a) il laicismo della Rivoluzione e l’uso strumentale del fattore religioso come strumento di dominio sia da parte delle armate rivoluzionarie che di quelle napoleoniche; b) la fede forte e vera che animava alcuni popoli invasi, al di là di aspetti magico–religiosi e/o di vera e propria superstizione, si capirà la radicalità e la violenza delle guerre civili che insanguinarono il Mediterraneo in età rivoluzionaria e napoleonica.
Dal Regno di Napoli all’Egitto, da Malta alla Spagna eserciti contrapposti, popoli ribelli e armate francesi si contrapposero con una violenza inaudita.
Repressioni crudeli, insurrezioni violente, guerriglie implacabili unirono città e campagne e scrissero una storia alternativa a quella della rivoluzione.
Una storia che partiva dalla rivendicazione della propria identità territoriale, nazionale, religiosa e che della Rivoluzione francese faceva suo il diritto a insorgere.
A distanza di quasi due secoli sappiamo che i diritti universali sono sacri, inviolabili e intangibili. Ma sappiamo anche che questi diritti hanno radici nella identità territoriale e nazionale di ciascun uomo. Non esiste un uomo astratto, esiste un uomo che nasce in un luogo e fa parte di un popolo, per quanto piccoli possano essere quella terra e quel popolo. È da quella precisa identità che ne è il frutto che bisogna partire per fare propri i diritti universali. E i doveri universali.
Saverio Di Bella
Gli abusi feudali e le radici popolari della rivoluzione in Calabria
Il problema degli abusi feudali e della nascita di una sensibilità civile e giuridica che ha consentito di percepire e giudicare come abusi quelli che erano diritti feudali, rinvia alla evoluzione della cultura europea e in particolare alla cultura dell’illuminismo, che fa da base e da sfondo alla polemica sugli abusi.
A noi interessa ricostruire i filoni e i momenti politici che sanciscono storicamente l’abolizione della feudalità e dei diritti feudali. Debbo infatti precisare che, a mio modo di vedere, esiste un evidente strabismo nella storiografia italiana sulla questione. Mentre cioè è nota ed è esaltata l’influenza della Francia rivoluzionaria e le iniziative prese a Napoli dai sovrani napoleonici – Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat – per l’abolizione dei diritti feudali, non altrettanta notorietà e interesse ha suscitato l’analoga iniziativa dei Borboni che, ritiratisi in Sicilia, con la costituzione del 1812 hanno abolito anch’essi i diritti feudali.
L’articolo 12 della costituzione Siciliana del 1812 testualmente recita: «Con quel medesimo disinteresse, che il Braccio Militare ha sempre marcato nelle sue proposte, ha voluto e concluso, ed il parlamento ha stabilito, che non vi saranno più feudi; e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodj, conservando però nelle rispettive famiglie, l’ordine di successione che attualmente si gode. Cesseranno ancora tutte le giurisdizioni Baronali; e quindi i Baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui sinora sono stati soggetti per tali diritti Feudali. Si aboliranno le investiture, rilevj, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i Titoli e le onorificenze. Placet regiae majestati».
È evidente il fatto che la Costituzione siciliana nasce anche per l’influenza esercitata dagli inglesi, alleati dei Borboni, sulla dinastia e su Ferdinando IV. Ci sono però anche da considerare le spinte che nei paesi governati dalle dinastie borboniche provenivano dalle élites illuministiche la cui cultura non era esclusivamente affascinata dal modello francese. Elites che anzi, in seguito e a causa della violenza della rivoluzione e degli eccessi rimproverati ai Giacobini, guardavano con estremo interesse e come modello all’Inghilterra.
Tra l’altro l’Inghilterra era un modello di società certamente diverso rispetto a quella francese, ma era anche un modello avanzato sul piano politico ed economico perché il paese viveva la grandiosa stagione della rivoluzione industriale.
Né può essere casuale il fatto che l’altro re della famiglia dei Borboni, Ferdinando VII di Spagna, sempre nel 1812, possa vantare il sorgere di una Costituzione che nel Risorgimento sarà ritenuta un modello ambito.
Non voglio certo fare comparazioni tra le due Costituzioni del 1812. Ma una domanda la voglio porre: come mai a distanza di decenni pur avendo optato per la repubblica e non per la monarchia sabauda, ciò che i Borboni hanno fatto contro la feudalità non entra a fare parte della memoria collettiva dell’Italia Repubblicana?
I popolani che hanno difeso la propria città e la propria terra sono briganti ancora e non patrioti; gli intellettuali e un parlamento, quello siciliano, che hanno guardato all’Inghilterra come ispiratrice ed alleata sono confinati nell’oblio. È retorica la considerazione che ove si continuasse così, la storia del Mezzogiorno sarebbe ancora o criminalizzata o rimossa?
Carmelo Pellegrino
Le origini toponomastiche del nome Maida nella mappa urbana di Londra
«The origin of the name Maida is bizarre. The British fought a victorious battle in Maida, Italy in 1806. A pub called The Hero of Maida Vale opened on the Edgware Road, and the name caught on in a big way.
Maida Vale is a road in North–West London, and a district surrounding it. The road starts in Kilburn, near Kilburn High Road station as a continuation of Kilburn High Road. It goes South–East, past Maida Vale tube station, through the district known as Maida Vale. To the East is St John’s Wood and Lord’s Cricket Ground. When it meets St. John’s Wood Road, Maida Vale becomes the Edgware Road.
The district acquired its name from the Hero of Maida, a public house which opened on the Edgware Road soon after the Battle of Maida, 1806. The area is mostly residential, consisting of many large Edwardian Mansion Houses. It encompasses the Paddington basin, a junction of three canals with many houseboats. This area is also known as Little Venice.
In the late 19th and early 20th centuries, Maida Vale was a predominantly Jewish district, and the area contains the 1896 Spanish & Portuguese Synagogue.
Maida Vale is also home to a BBC Recording and Broadcast Studio, used primarily by BBC Radio 1. The studio was also home to John Peel’s Peel Sessions, a regular slot in which a current popular band would play a set exclusively for the show. The BBC Radiophonic Workshop was based here from 1958 until the Workshop was shut down in 1998. Their pioneering Delaware synthesizer took its name from the studio’s Delaware Road address.
Maida Vale tube station was opened on June 6th 1915, on the Bakerloo Line.
The great Victorian writer George Gissing celebrates this surrounding and neighbors of Great London in many of his romances and literary matters».
Le origini toponomastiche del nome Maida nella mappa urbana di Londra sono bizzarre. A Londra esistono tre località tributarie di questo toponimo calabrese: “Maida Vale”, “Maida Street” e “Maida Hill”. Tutte le denominazioni risalgono alla vittoriosa battaglia combattuta dalle truppe britanniche nella omonima località calabrese nel 1806. Un pub dove si riunivano i reduci e i militari che combatterono in quella battaglia fu intitolato subito dopo il ritorno delle truppe in patria agli “Eroi del Vallo di Maida”; il locale pubblico aperto su Edgware Road finì per dare fama a tutto il distretto, allora appartenente ai sobborghi del nord–ovest londinese, che successivamente per antonomasia fu conosciuto e denominato “Maida Vale”. Nel corso dell’Ottocento e del Novecento l’area era abitata da scrittori, artisti e pittori che avevano case e studi sulle chiatte nella zona paludosa dei sobborghi nord–occidentali conosciuta anche come Little Venice. In seguito divenne area residenziale con abitazioni in stile edoardiano. La popolazione fu caratterizzata in modo predominante da immigrati di origine latina, con una larga maggioranza di ebrei portoghesi e spagnoli (vi sono due importanti sinagoghe). Successivamente vi si stabilirono gli impianti radiofonici della BBC e i famosi studi di registrazione di Abbey Road ai tempi dei Beatles.
Lo scrittore vittoriano George Gissing, a cui questo contributo è dedicato, principale cantore dei sobborghi e della vita degli esclusi tra le periferie e i luoghi marginali della Grande Londra, presso i quali egli stesso visse e scrisse, celebra in più di un luogo della sua produzione letteraria la poesia e il fascino contraddittorio delle aree periferiche della Grande Londra che includono Maida Vale, mentre al suo profondo legame con la Calabria, di cui fu viaggiatore innamorato ed umanamente entusiasta, si deve l’invenzione dell’appellativo “Paparazzo” che oggi universalmente definisce la figura del fotoreporter scandalistico.
Mauro Francesco Minervino
Marina borbonica e Rivoluzione
Si colloca fra il 1803 e il 1804 una “avventura”, ancora non molto studiata perché “soverchiata” dall’interesse per le vicende napoleoniche “continentali”, però sicuramente interessante per mettere a confronto la Marina borbonica non più con la Rivoluzione francese, ma con gli esiti di una rivoluzione precedente, quella americana. Proprio nel 1803 nel Mediterraneo s’aggira una piccola flotta con la bandiera statunitense, alla ricerca di una dimostrazione di forza nei confronti del pascià di Tripoli Yusuf Caramanli, che si era “permesso” di chiedere una discreta somma di denaro per non corseggiare contro le navi mercantili americane.
Al comando del commodoro Edward Preble, fu quindi spedita nel Mediterraneo una nuova squadra composta dalle navi Constitution (ammiraglia), Philadelphia, Argus, Siren, Nautilus, Vixen ed Enterprise. La flotta si aggirava non solo alla caccia dei bastimenti tripolini, ma anche in cerca di basi e rinforzi. A questo punto il Preble, approdato a Napoli, si rivolge nuovamente a Ferdinando IV. «La risposta del Borbone fu, questa volta, positiva: egli mise a disposizione degli americani 6 cannoniere, 2 bombarde e 96 marinai napoletani»; e inoltre concesse la possibilità di utilizzare i porti di Messina, Siracusa e Palermo come basi navali da cui lanciare operazioni contro la Reggenza tripolina.
Approfittando del sostegno offertogli dal re delle Due Sicilie, Preble basa la squadra a Siracusa. Qui non mancano però problemi e incidenti: per completare l’equipaggio, una fregata arriva a sequestrare la banda del Reggimento Valdemone salita a bordo per un concerto, mentre gli americani lamentano ogni genere di truffe da parte dei siracusani. A loro volta i franco–italiani, che occupano militarmente la Puglia, inviano armi e rifornimenti a Yusuf e loro agenti riescono a sabotare le munizioni della squadra americana depositate a Siracusa.
I contrattempi non mancano: dal 31 ottobre 1803 il capitano Bainbridge – «a child of adversity», come si autodefinirà – comandante della sfortunata fregata Philadelphia, dando la caccia a uno sciabecco nemico, la conduce a incagliarsi su un banco di scogli proprio davanti al porto di Tripoli. Lui e i suoi trecento uomini vengono fatti prigionieri e quindi – come si usa nel Mediterraneo – schiavi. Lo scacco era grave, un disonore per la marina americana; l’idea fu quella di far saltare con un colpo di mano la Philadelphia. Il «compito fu affidato al luogotenente Stefano Decatur, che preparò il colpo con molta cura, servendosi di un veliero tripolino catturato ed al quale fu dato il nome di Intrepid. Con cinque ufficiali e 62 uomini di equipaggio camuffati alla maltese, la piccola nave, pilotata da un messinese, certo Salvatore Catalano, riuscì il 17 febbraio 1804, sfidando i marosi, ad accostare la Philadelphia: con temerario coraggio gli americani abbordarono, dettero fuoco alla santa barbara, riuscendo poscia a porsi in salvo sull’Intrepid, che usciva dal porto miracolosamente sotto il violento fuoco rovesciatogli addosso dalle artiglierie della piazza».
Grazie alle informazioni – dice un’altra versione dei fatti – che comunque Bainbridge riusciva a far pervenire da Tripoli e alla «perizia del pilota palermitano Salvatore Catalano (poi divenuto capitano di vascello dell’US Navy) il 16 febbraio 1804 il tenente Stephen Decatur riuscì a entrare nel porto usando una nave tripolina catturata e alzando bandiera britannica, e a distruggere la Philadelphia. I fondali di Tripoli erano però troppo bassi per consentire alle fregate di avvicinarsi a distanza utile per il bombardamento: occorrevano le unità sottili di cui era dotata la marina borbonica e re Ferdinando ne concesse a nolo dieci (8 cannoniere e 2 bombardieri) con 96 marinai.
Furono proprio queste a conseguire l’unica vera vittoria americana: il 3 agosto attaccarono il porto, infliggendo a Yusuf la perdita di sei navi (tre affondate e tre catturate) e 122 uomini contro 13 americani e siciliani. I successivi attacchi del 7 e 24 agosto e del 3 e 4 settembre furono meno fortunati: saltarono in aria una delle cannoniere siciliane e un brulotto americano».
Il 10 settembre, Preble passò le consegne a Barron e tornò in America, ma diversi siciliani e napoletani lo avrebbero seguito su quella rotta, a cominciare dal pilota Salvatore Catalano (per alcuni messinese, per altri palermitano, ma pur sempre siciliano). Lasciavano questi uomini la loro divisa borbonica per indossare quella della U.S. Navy, passando da una fedeltà monarchico–assolutista a una fedeltà federal–repubblicana.
Nel 1806, l’armata di Giuseppe Bonaparte procede all’occupazione dell’intera parte continentale dei possedimenti di Ferdinando, costretto per la seconda volta a rifugiarsi in Sicilia seguito da una piccola parte del suo esercito e da alcune unità della flotta. La Marina borbonica, a quel punto, è ridotta ad appena una ventina di legni, pochissimi dei quali di stazza medio–grande.
Giuseppe Restifo
Contadini contro la Francia
Alla fine del XVIII secolo l’Europa stava affrontando importanti cambiamenti costituzionali, che coincisero con la crescente perdita di potere dell’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, ridotto al ruolo di semplice spettatore delle questioni politico–economiche del Mediterraneo.
Nel settembre 1797 Napoleone scriveva a Talleyrand: «Pourquoi ne nous emparerions–nous pas de l’île de Malte? Quatre cents Chevaliers et au plus un régiment de cinq cents hommes sont la seule défense de la Valette. Les habitants sont très portés pour nous et sont dégoûtés des Chevaliers qui ne peuvent plus vivre et meurent de faim. Je leur ai fait exprès confisquer tous leurs biens en Sicile». Ma Napoleone non rappresentava la soluzione. L’errore che egli commise fu quello di osare troppo e troppo in fretta. Egli rimase a Malta solo otto giorni ma furono giornate molto indaffarate, secondo Laferla, «it is certain that no one in the space of a few days attempted more, did more and upset more the Maltese more than he did». Dopo avere fatto razzie di tutto ciò che di valore era presente nei palazzi, negli Alberghi e negli altri edifici, e dimenticando volontariamente tutte le promesse fatte, Napoleone si interessò alle chiese: tutti gli oggetti di valore e le opere d’arte d’oro e d’argento furono fusi in lingotti. Troppo velocemente i francesi dimostrarono che era per loro più facile fare promesse piuttosto che mantenerle: le spose e i parenti a carico dei marinai e dei soldati che partirono con Napoleone per l’Egitto non ricevettero mai la paga promessa. Peraltro, dal momento che la Gran Bretagna controllava tutti i mari, l’esportazione del cotone dell’isola fu paralizzata, con conseguenze disastrose per gli agricoltori e per tutti i maltesi. La questione “religiosa” fece esplodere la rivolta dei contadini, stanchi dei soprusi e della mancanza di rispetto delle loro tradizioni e della loro identità cattolica.
Numerose sono le fonti archivistiche che testimoniano la crisi generale vissuta dall’arcipelago maltese e la “turbolenza” europea; tra queste non vanno trascurate le memorie e i diari dei due anni di resistenza anti–francese. Il diario di Franciscus Xaverius Baldacchino – membro della Congregazione di San Filippo Neri – pone in rilievo il costante stato di ansietà e terrore provato dai cittadini oppressi dai francesi.
Il blocco che seguì l’insurrezione del settembre 1798 comportò una vera “operazione di guerra” nazionale cui parteciparono migliaia di maltesi, sia attraverso l’arruolamento nei ventuno battaglioni che erano stati costituiti nella campagna, sia attraverso il prestito di somme di denaro per il mantenimento delle suddette forze armate. Altri, liberamente, prestarono i loro servizi a livello nazionale.
La rivolta della campagna cambiò radicalmente la situazione dell’isola. Era una “rivolta dal basso” che, ben presto si trasformava in un movimento interclassista, coinvolgendo artigiani, mercanti e gentiluomini, attraverso la quale la popolazione maltese tornava a scoprire il senso dell’autonomia locale e la gestione allargata del potere.
I drammatici eventi, che si scatenarono dopo il 2 settembre 1798, non furono un episodio isolato e non possono essere separati dalla complessiva e “durevole” vicenda storica del XIX e del XX secolo a Malta come a Maida. Piuttosto, nella prospettiva della longue durée, la rivolta costituì nella sua totalità “l’iniziale evento traumatico” che “agì da catalizzatore” per l’emergere del lungo e strutturale movimento nazionalista per l’indipendenza. «Quella che sembrava essere stata una protesta spontanea e rurale, quasi “primitiva”, si sviluppò ben presto in una rivolta armata, organizzata su scala nazionale». Con la rivolta detta “dei contadini” inizia il lungo, tormentato e contraddittorio rapporto dell’arcipelago con gli inglesi, rapporto destinato in breve a trasformarsi in vero e proprio dominio della grande potenza europea nei confronti di quelle piccole isole poste al centro del Mediterraneo.
Carmelina Gugliuzzo
Vecchie e nuove fedeltà. Alla ricerca di un ordine legittimante dopo la Rivoluzione di Maggio del 1810
Perché introdurre un case–study latinoamericano nell’analisi del contesto mediterraneo in età napoleonica? Forse, sarebbe meglio chiedersi sulla validità dell’intervento abbordando la questione dalla prospettiva geopolitica del momento, se si considera la portata dell’irruzione delle truppe francesi in Spagna, come un fenomeno senz’altro paragonabile agli sforzi compiuti sul fronte mediterraneo. Infatti, l’invasione napoleonica del 1808 colpiva molto di più che il centro nevralgico della monarchia spagnola. La stessa costituiva una unità culturale, linguistica e religiosa che abbracciava un insieme di regni compressi tra il Mediterraneo, il Pacifico e l’Atlantico. In questo modo, il breve interregno napoleonico, messe in crisi la legittimità del sistema istituzionale della monarchia borbonica innescando un processo irreversibile che avrebbe condotto allo sgretolamento di questa vastissima unità. L’obbiettivo di questo lavoro è quindi, quello di ricostruire l’impatto degli avvenimenti metropolitani a Buenos Aires –capitale del Vicereame del Río de la Plata–, dove nel mese di maggio del 1810 si aprì un processo rivoluzionario che condusse alla proclamazione dell’indipendenza dalla Spagna e dopo decenni alla nascita dello Stato argentino. La prospettiva scelta, privilegia l’aspetto centrale di tutta la vicenda, orbene la ricerca di un nuovo ordine legittimante in grado di rimpiazzare in piena legalità istituzionale al precedente. Tuttavia, l’impresa non solo rappresentò una sfida per gli attori politici del processo indipendentista. La stessa, aprì una serie di questioni fondamentali per la “storiografia patria” quando una volta ultimato il travagliato percorso di costruzione dello Stato, dovette in qualche modo giustificare la vocazione nazionale delle ex–colonie. Oggi, alla soglia del bicentenario della Rivoluzioni, la storiografia argentina grazie agli apporti rinnovatori della storia istituzionale, agli studi sull’analisi del discorso e ad una rilettura contestuale delle fonti, ha sfatato i grandi miti fondanti della Repubblica, ricollocando lo studio di tutto il processo nella sua vera dimensione. La stessa, ha evidenziato la forte carica teleologica che la tradizionale versione dei fatti presenta, all’anteporre alla costruzione del futuro stato elementi di identità nazionale e progetti di emancipazione, praticamente allora inesistenti.
Ma pur se la storiografia è riuscita ad affrontare ogni problematica con nuovi approcci metodologici, ancora sembra non trovare accordo sulla vera natura del processo: fu l’epopea di maggio una vera e propria rivoluzione? Da una prospettiva d’analisi ravvicinata, senz’altro essa significò una rottura col dispotismo borbonico e l’avvento di un nuovo ordine repubblicano, in netta sintonia con le nuove idee annunciate dalla Dichiarazione dei diritti dell’Uomo. Tuttavia, essa non significò un taglio netto con il passato. Come ben presto si scopre, la legittimazione del nuovo ordine si realizzò in pieno rispetto della tradizione giuridica coloniale, e le grandi trasformazioni proclamate dai lumi, dovranno aspettare la seconda metà del XIX secolo per vedere la sua realizzazione.
Adriana Porta
[1] Per questioni degli angusti limiti editoriali il canto popolare non venne pubblicato nella brochure dell’anno 2006 né in dialetto calabrese, né nella versione italiana.
[2] «Sono del paese di S. Nicola, lo sapete./ Di soprannome sono chiamato Colacchio./ Vorrei sapere di quale paese siete;/ vorrei essere un po’ rispettato./ “Voi ne avete salati e soppressate?”./ Ed io risposi: “Fate quello che volete, /La cassa è aperta e ve ne potete prendere”./ Mia moglie che stava raccolta, raccolta,/ Segno mi faceva da un angolo. / “Zitta, moglie mia, ché se si gira,/ Non ce la tira brutta una manata in volto!”./ Poi c’era uno con una sciabola,/ Sembrava il Commissario della guerra!/ “Zitta moglie mia, ché se si sbaglia,/ Ti fa cadere con la faccia a terra”./ Quando giunsero poi i Nazionali/ a me ne hanno inviato a non finire,/ ché le caldaie me le hanno svuotate./ Per mala sorte venivano da Cosenza».
Anno 2007
San Francesco di Paola: un calabrese per il mondo intero[1]
San Francesco di Paola, gigante della santità cristiana
La ricorrenza del quinto centenario della morte di San Francesco di Paola, avvenuta il 2 aprile 1507, sta costituendo la felice occasione per riscoprire le Sue virtù e la Sua personalità: forte, umile e paziente. E ripensando, nel corso di questo fecondo anno celebrativo, che si concluderà il prossimo 2 aprile, la vita di questo gigante della santità cristiana, le popolazioni calabresi stanno imparando ad amarLo con nuovo impegno e con rinnovato ardore. Del resto non poteva, e non può essere diversamente per «il più calabrese dei santi, per il più santo dei calabresi». San Francesco di Paola è per davvero “il” Santo tra di noi, non semplicemente “un” santo tra di noi. E’ il Santo per eccellenza delle genti di Calabria. Rimane, dopo cinque secoli, con il suo messaggio di amore verso i poveri e gli indigenti, il Santo più attraente per l’uomo e la donna, che vivono questo incerto inizio di millennio. E’ il Santo più conosciuto, più popolare, più invocato. Non v’è, infatti, comune della Calabria, piccolo o grande che sia, che non nutra una particolare devozione per il Santo paolano, proclamato Patrono della Calabria da Papa Giovanni XXIII e, prima ancora, da Pio XII Patrono delle genti di mare.
«La devozione a San Francesco è radicata nella gente di Calabria, al punto che tanta parte della Sua fede passa attraverso la fiducia, la devozione, la preghiera rivolta a Lui. In molti, tale devozione è il segno forte della professione di fede e dell’appartenenza alla Chiesa». E’ questo un passaggio molto significativo del messaggio che i Vescovi della Calabria hanno rivolto alle loro Chiese in preparazione delle celebrazioni del quinto centenario. E sono proprio i dodici vescovi che ci aiutano a riscoprire San Francesco come il contemplativo, l’eremita accogliente, il penitente umile ed austero, il profeta di conversione, l’esempio del protagonismo. Cinque prospettive per ri–orientare la presenza dell’uomo e della donna nel contesto degli eventi del terzo millennio.
La contemplazione, innanzi tutto, che per San Francesco è stata «la corona di tutta la sua vita» e che si è tradotta «in quel sentimento di abbandono e di fiducia in Dio, che ancora oggi contraddistingue la spiritualità del nostro popolo». L’eremita accogliente, subito dopo, che mentre «cercava la solitudine per coltivare la comunione con Dio», si poneva, nel contesto del suo tempo, come «un uomo dalle innumerevoli sensibilità», le quali trovavano il loro apice nella charitas, cioè nell’amore con il quale affrontava uomini e cose, fatti ed eventi. Ancora: il penitente umile ed austero. «Educato già in famiglia a vivere sobriamente, si è accontentato del necessario per vivere, in controtendenza con la cultura della classe agiata del tempo». A seguire, il profeta di conversione «convinto nella sua professione di fede, coerente nella pratica quotidiana». Ed infine, un protagonista della storia del suo tempo, che non si tirava indietro dinnanzi agli avvenimenti, ma dava responsabilmente il suo contributo, anche quando poteva rimanere tranquillo nella pace del suo eremo.
Un bell’esempio questo lasciatoci da San Francesco di Paola che spinge anche noi ad essere protagonisti del nostro sviluppo. La regione oggi ha bisogno di persone generose e disinteressate, che sappiano farsi carico dei problemi della gente e risolverli nel contesto di una progettualità aperta a quella speranza, che tiene conto delle reali possibilità di sviluppo. Nel nome di San Francesco, allora, lo sviluppo della Calabria è affidato alle nostre mani, alle nostre capacità, al nostro impegno, alla nostra onestà intellettuale ed operativa.
Teobaldo Guzzo
[1] La brochure di quest’anno conteneva un messaggio di saluto del presidente dell’associazione culturale “La Lanterna”, Stefania Vasta Iuffrida, di cui si riprendono i tratti più salienti: «L’attenzione verso aree di interesse generale nulla toglie alla ricerca delle tradizioni della nostra terra, aldilà dei malumori della politica attuale, dell’assopimento intellettuale della comunità e della scarsa partecipazione sociale dei più, l’associazione si propone ogni anno di stimolare l’attenzione su temi di rilievo sociale e riscoprire la tradizione di un territorio dimenticato, memoria di un popolo orgoglioso ma bistrattato… Ed è in questo spirito di riscoperta della tradizione, delle proprie origini, della propria cultura che il ricordo di Santo Fratello Ciccio lo Paolano, così era conosciuto in vita San Francesco di Paola, considerato dalla Chiesa cattolica il patrono della gente di mare, nel quinto centenario della morte, ci consente un percorso nel sacro che ci conduce per terre enigmatiche ed affascinanti».
San Francesco di Paola: dalla Calabria all’Europa, al Nuovo Mondo
Francesco di Paola, il figlio più illustre della Calabria, fondatore dell’Ordine dei Minimi, Patrono della Calabria e della gente di mare, è santo conosciuto, riverito, cercato, amato, la cui devozione e figura hanno oltrepassato i confini regionali, nazionali. Pur essendo eremita è stato sul palcoscenico del tempo e della storia, dinanzi all’attenzione degli uomini, piccoli e grandi, semplici e dotti, sudditi e potenti, in Italia e in Francia. Dopo la morte, il suo messaggio si è diffuso, attraverso la diffusione dell’ordine lungo cinque secoli. Francesco, con la sua vita e doni, proprio perché opera dello Spirito Santo, è un patrimonio che si propone come una autentica testimonianza evangelica ricca di valori umani e cristiani capaci di scuotere e incidere nella nostra società. Significativa è la coincidenza del quinto centenario della sua morte (1507–2007) con l’approvazione della IV Regola (26 luglio 1506) scritta da San Francesco per noi suoi frati.
Questa regola riveste un carattere particolare perché è assolutamente originale rispetto alle altre generalmente adottate dagli altri istituti religiosi. San Francesco è stato un maestro di vita spirituale, che ha tracciato un cammino autonomo di spiritualità (vita quaresimale), una proposta originale e forte che richiama alla essenzialità, alla sobrietà, alla semplicità, ma soprattutto a una solidarietà e condivisione col povero e bisognoso; una conversione, riconciliazione con dio comporta conversione e riconciliazione con l’altro. Il nostro Santo con la sua vita, povera e penitente, è stato un richiamo operativo per tutti al Vangelo: coscienza evangelica per il suo tempo.
Gli anni passati da San Francesco in Francia (1483–1507) sono stati densi di avvenimenti riguardanti la vita della chiesa e dell’Europa politica del tempo. Per alcuni di questi avvenimenti il paolano ha giocato un ruolo veramente eccezionale: forte è stato il contributo alla riforma della chiesa. Ma non si può dimenticare l’impegno profuso per scongiurare la venuta dei turchi in Italia (1480–1482), o per impedire la discesa di Carlo VIII in Italia (1494), la scoperta dell’America. Per quest’ultimo avvenimento, bisogna notare che il primo vicario apostolico nel nuovo mondo, salpato con Cristoforo Colombo al suo secondo viaggio è stato lo spagnolo Bernardo Boyl, da alcuni anni aggregato al movimento eremitico di San Francesco, dopo averlo visitato a Tours, dove si era recato come ambasciatore presso Carlo VIII, per conto del suo re Ferdinando V.
Aveva un profondo senso sociale: prediligeva i poveri e i deboli; dinanzi ai potenti Ferrante d’Aragona, re di Napoli e Luigi XI in nome del Vangelo ha alzato la voce. Dire San Francesco di Paola è: dire Paola, Calabria, Sicilia, Regno di Napoli, Meridione, Ordine dei Minimi, frati illustri, conventi; dire devozione, fedeli (committenza) che hanno stimolato nel tempo il campo della cultura e arte (letteratura, musica, architettura, pittura, scultura: Giordano, Mattia Preti, Guido Reni, Murillo, Tintoretto, Lilli, Sassoferrato, Ribera, Tiepolo).
Il quinto centenario è momento propizio per entrare in quel flusso e movimento di persone che fin dall’inizio si sono lasciati coinvolgere dalla vita, dal messaggio e dalla spiritualità di questo grande uomo e santo: «accorreva da lui numerose genti da tutte le contrade». E come allora anche noi si possa sperimentare benefica la vicinanza e la compagnia dell’uomo di Dio, per essere a nostra volta segno di speranza per la nostra società.
Vincenzo Arzente
San Francesco di Paola Maestro di vita spirituale
L’intento del presente scritto è quello di indicare alcune caratteristiche di San Francesco di Paola, colto nella dimensione della “paternità spirituale” esercitata verso i suoi religiosi e i fedeli laici.
1.La prima chiave per entrare nel cuore di Francesco di Paola come “maestro di vita spirituale”, è scritta dal suo discepolo anonimo: «austero con se stesso, era generoso e umano con gli altri». Dalla “pratica” di vita di Francesco di Paola è possibile ricavare una “teoria” che mira a realizzare un incontro autenticamente “spirituale” tra un discepolo, accolto nella sua concreta e particolarissima realtà, con “generosità” e “umanità”; da parte di chi, come Francesco, si impegna in una vita di effettiva “cura” per i valori dei quali intende farsi “maestro”. Nello stesso tempo, come ha bene osservato il Morosini, sul dono “naturale” della sua grande “umanità”, Francesco «costruisce la virtù teologale della carità nel suo aspetto orizzontale, cioè come apertura agli altri uomini» (G. Fiorini Morosini, Il carisma penitenziale di S. Francesco di Paola e dell’Ordine dei Minimi. Storia e spiritualità, Roma, 2000, p. 122).
2.V’è, poi, una seconda chiave che può aprirci il cuore di Francesco di Paola, nel suo concreto rapporto di maestro verso il discepolo. Apertasi la strada per farsi accogliere da una persona, Francesco ne leggeva il cuore. Un “dono” ricevuto dall’alto è la capacità di abituarsi a “leggere dentro” una persona, attraverso i segni diretti e indiretti che trasmette; non soltanto per riuscire a vedere la rettitudine di intenzione del discepolo, ma anche per scorgere ciò che egli stesso non è ancora in grado di conoscere in se stesso. Spesso Francesco vede veri e propri vizi radicati nel “cuore” dei suoi interlocutori, altre volte sono pensieri che rivelano imperfezioni meno gravi. Egli rivela l’“arte” di entrare con discrezione, ma con dolce forza, nell’intimo di un’anima, così da vederla come essa è agli occhi di Dio. Un’espressione ricorrente di Francesco si riferisce alla “purificazione della coscienza”, del “santuario” dove l’uomo incontra Dio.
3.Una terza chiave dell’“arte” di Francesco è l’accompagnamento spirituale. Francesco possiede la sensibilità di farsi prossimo per chi intraprende il viaggio all’interno di se stesso verso il Signore, lasciandosi coinvolgere da chiunque intravede in lui una persona in grado di aiutarlo a ricercare dio, senza distinzioni di classe sociale o religiosa, esercitando così la più alta “paternità spirituale”. Un anonimo francese scrisse: «Egli comincia a intrattenersi su quelle cose sante e divine da lui prima apprese alla scuola dello Spirito». Un “maestro” che comunica la propria esperienza spirituale coinvolgendo il discepolo in una esperienza vitale. I primi a godere della grazia di essere accompagnati spiritualmente furono i suoi compagni iniziali, per i quali dovette rivedere il suo primigenio disegno di coltivare la solitudine eremitica.
4.Un’eco diretta del rapporto “maestro–discepolo” con riferimento alle caratteristiche del Superiore: «Et quoniam experientiae defectu illi, qui prius tentationis bella expertus non fuerit vel discipulum non se noverit, corectoris onus subire congregationisque fratrum curam suscipere non expedit» (IV Regula, cap. IX, 39). Il “Correttore”, ovvero il “Superiore minimo”, è innanzitutto il padre spirituale della comunità, il quale avendo fatto “esperienza” del “combattimento spirituale” diviene “maestro spirituale”, secondo la tradizione monastica, in particolare benedettina, e di quella ancora più antica dei Padri del deserto.
Bene si addice a Francesco la seguente affermazione: «Esistono saggi e uomini illuminati capaci con la loro sola presenza di risvegliare negli altri l’interiorità, a tal punto che il soggetto si trova improvvisamente messo di fronte a se stesso e viene sedotto dalla vita interiore. Così avviene a volte la conversione, cioè il rovesciamento dell’essere» (M.-M. Davy, L’uomo interiore e le sue metamorfosi, Milano, 1995, p. 83).
Leonardo Messinese
San Francesco di Paola e le origini bibliche della spiritualità quaresimale
San Francesco di Paola si è distinto nel suo tempo come colui che ha ripreso la prassi penitenziale degli antichi Padri del deserto: imitatore dei “Prisci Patres” (Alessandro VI, Ad fructus uberes; bolla di approvazione della Terza Regola). In Francia fu paragonato a S. Giovanni Battista (Processo Turonense, t. 3.6).
La sua ispirazione trova le sue radici nei quaranta giorni passati da Gesù nel deserto (Mt 4,1–11, e parr.) e nella tradizionale spiritualità quaresimale proposta dalla Chiesa, la quale anch’essa si richiama all’esperienza di Gesù nel deserto.
La vocazione eremitica porta Francesco a ritirarsi in solitudine per stare solo con Dio solo. E’ un atteggiamento di amore totale espresso con ascesi, povertà e penitenza radicali. Ogni esigenza è ridotta al minimo perché prevale solo il desiderio di amare Dio «con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (cfr. Dt 6,4–5; Mc 12,28–34). E’ un modo di vivere con “maggiore penitenza” (cfr: IV Reg. 2) per esprimere e rafforzare la Carità verso Dio e verso il prossimo: la Charitas relativizza al massimo ogni altro tipo di bisogno. Tutto è concentrato sull’unico necessario: Dio. E’ la proposta di una vita sobria, semplice che oggi si contrapporrebbe al dilagante consumismo, rendendo l’uomo più aperto al trascendente e più disponibile verso il prossimo.
Il voto di “vita quaresimale”, lasciato da S. Francesco ai suoi frati, che consiste attualmente nell’astensione perpetua dalla carne, richiama tutto lo stile di vita che la Chiesa propone ai credenti durante il periodo di preparazione alla Pasqua: intensificare lo sforzo di conversione attraverso la preghiera, il digiuno–astinenza, e le opere di misericordia praticate in modo più forte. Tale stile è esteso a tutta quanta la vita. L’Ordine dei Minimi richiama il popolo di Dio, ogni uomo a considerare l’esistenza umana come una preparazione alla vita eterna. Come la quaresima annuale prepara alla Pasqua liturgica, così questa nostra vita è preparazione alla Pasqua ultima, all’ultimo “passaggio” con il quale Dio ci introdurrà nella pienezza della vita.
Lo stile di vita quaresimale è presentato come un progetto di vita che dà senso all’esistenza umana, orientando ogni scelta all’amore verso Dio ed il prossimo, portando l’uomo di oggi ad interrogarsi sul “senso” della propria vita, a considerare il valore della sofferenza, della morte e della stessa vita. Sono interrogativi che l’uomo di oggi evita, preferendo porre attenzione alle esigenze immediate, attuali, concentrarsi sul “qui” e “ora”: cosa mi interessa, di cosa ho bisogno adesso? Il riferimento al fine ultimo non è considerato.
La Carità che riempie il cuore di Francesco («chi è pieno di Carità, non può parlare se non di Carità», Anonimo, cap. VII) era fonte di serenità per sé e di consolazione per tutti coloro che lo incontravano: non c’era persona che si recasse da lui per chiedere consigli o per qualche afflizione, senza che tornasse confortato, lieto e soddisfatto per le risposte da lui ricevute… (Anonimo, cap. VII).
Pur vivendo un’ascesi radicale, egli era colmo di gioia, perché pieno della carità di Dio la quale produce serenità e pace, anche nelle avversità dell’esistenza.
La “Buona Notizia” del Regno di Dio («Il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo», cfr. Mc 1,15), ha come conseguenza sia una intensa gioia (perché Dio ci ama, e nel suo amore, anche se siamo peccatori, non ci punisce, ma ci salva), che un impegno radicale di conversione–penitenza per rispondere e collaborare con l’amore di Dio.
Questo Amore realizza le scelte più totali e le rinunce più forti, perché a chi ama Dio tutto è possibile (cfr. Leone X, Excelsus Dominus, Bolla di canonizzazione di S. Francesco).
Francesco Santoro
San Francesco di Paola agli occhi del popolo calabrese
La vita di S. Francesco di Paola – il futuro santo e il fondatore dell’ordine dei Minimi – si sviluppa tra Paola, dove nacque nel 1416, e Tours, dove si spense nel 1507. Canonizzato nel 1519 ed eletto patrono dei marinai nel 1943 ebbe già in vita onori e fama tra i potenti e tra gli umili. Voluto in Francia da Luigi XI, conobbe Carlo VIII e la vita di corte, ma non si lasciò mai incantare dagli orpelli e dall’oro; sapeva che la sofferenza e il dolore esistono dovunque, nei tuguri e nelle regge.
Non dimenticava però che Cristo cammina su questa terra sotto le vesti dei poveri, dei derelitti, dei carcerati, degli ultimi. E in essi ha cercato e trovato Dio e al loro fianco e al loro servizio ha vissuto. In un tempo di mutamenti epocali – basti ricordare la fine dell’impero di Bisanzio e la nascita dell’impero turco (1453), la scoperta delle Americhe (1492) l’inizio delle guerre tra Francia e Spagna per la supremazia in Italia, il Rinascimento etc. – e di superbia arrogante, difese i deboli dai forti, la giustizia dalla violenza, l’amore dall’odio.
Ma non è questo il S. Francesco che vorrei ricordare. Mi piace di più il Francesco santo come era visto dal popolo calabrese, almeno fino a quando i calabresi erano un popolo di contadini dalla vita amara, dai sentimenti forti, dalle passioni travolgenti che sapeva che l’esistenza terrena avanza e si snoda tra Dio e il diavolo, le debolezze della carne e la forza dello spirito. Con i santi da invocare al momento opportuno o che vengono da soli quando meno te l’aspetti, mentre dormi, come Francesco di Paola che conosce bene il demonio e i calabresi ed ha la medicina giusta per entrambi.
Le sue legnate arrivavano nel sonno precise ed implacabili. Ti svegliavi madido di sudore e ti accorgevi che le bastonate le avevi solo sognate. Ma il volto del picchiatore implacabile non svaniva nel nulla, anzi. Il recupero della lucidità si accompagnava alla individuazione certa di chi ti aveva bastonato: era lui, Francesco di Paola il cui sorriso sornione e beffardo era stampato nell’immagine che lo raffigurava e che pendeva da un quadro inchiodato alla parete della tua stanza da letto. Immagine tradizionale col saio, i sandali, la barba, il bastone.
Perché S. Francesco di Paola, al mio paese, mena. Mena sui diavoli e mena sui peccatori. Il suo randello pieno di santo zelo rompe le corna di Belzebù, fa maturare la coscienza del peccato e nascere il rimorso nei peccatori. Come “u pistapaniculu” che separa i chicchi del granturco dal tutolo.
Perché il santo di Paola conosce bene i calabresi e la loro testa dura e sa che per cavare il bene che tengono dentro bisogna lavorarli bene, a lungo, con forza, pestarli con cura, come il grano con la mazza per ridurla in farina dalla quale fare il pane.
I calabresi sanno tutto su San Francesco, i suoi miracoli, le sue ire, le sue denunce. Sanno che attraversa il mare sul mantello, che mette il diavolo al servizio di Dio. Ma sanno soprattutto che spezza una moneta di fronte al Re e quella moneta sprizza sangue: il lavoro, lo sfruttamento, la pena, le lacrime di una vita di stenti e di tante morti per fame e tasse, tasse e fame.
Una vita di dolore e di pena che spinge a bestemmiare, a rubare, a uccidere, a cedere al demonio. E’ allora che arriva lui, in carne e ossa, col suo bastone terribile, ostinato e implacabile. Sorridente e paterno perché un cristiano prega e perdona perché i potenti e i prepotenti che rubano ai poveri persino il sangue sono già condannati dall’ira giustiziera di Dio e dai miracoli dei suoi santi.
Saverio Di Bella
La pedagogia di San Francesco da Paola[1]
Gli uomini di Dio mostrano come i valori umani autentici sono in perfetta armonia con i valori eterni finalizzati alla realizzazione piena ed integrale della persona. In questo breve scritto si rileveranno tracce di carattere pedagogico nell’azione e nella predicazione di frate Francesco di Paola.
La sua vita penitente ispira anche la sua pedagogia, il cui principio basilare non ha nulla da invidiare alla moderna pedagogia: «Non bisogna cercare l’umiliazione del colpevole, ma la correzione e conversione».
Parlare di una peculiare pedagogia, a proposito del Paolano, non deve sembrare una stentata preziosità; gli elementi che il Correttorio offre sono di notevole rilievo e non hanno nulla da invidiare – non sembri eccessiva l’affermazione – ai principi della moderna pedagogia.
–Gli educatori: “lucerne accese”. I correttori, potremmo dire nel contesto pedagogico gli educatori, sono definiti “lucerne accese”. Infatti, come lucerne ardenti si sforzino di offrire a tutti segni di luce. «La persona umana, di qualunque autorità sia rivestita, ha un limite insuperabile: la propria natura finita, che rende relativo ogni suo comportamento, ogni suo giudizio, ogni sua pretesa di verità, soprattutto nei confronti dell’altro, specialmente nel momento in cui un provvedimento o giudizio può decidere del destino della persona. Gli educatori nel correggere usino prudentemente la verga con la manna, l’olio con il vino, cioè la giustizia con la misericordia e viceversa; anzi useranno tanta misericordia da non dividere da essa la giustizia. Le punizioni non debbono essere mai il frutto dell’ira e della vendetta. La punizione non è mai fine a se stessa, ma solo mezzo per ottenere il cambiamento».
Il principio pedagogico è il cambiamento della persona: Francesco usa il termine evangelico di emendatio. Le punizioni sono sempre medicinali. L’esemplare luminosità che viene emanata dagli educatori significa il primato di comportamento e di testimonianza etica, nonché l’essere trasparenza pedagogica, libro aperto e leggibile rivolto agli educandi.
–Per una pedagogia di umanizzazione. Il rapporto educativo di frate Francesco è posto in un contesto di bontà e di mitezza. Egli cercava di educare le persone ad avere il senso di Dio tra le vicende della vita, e a giudicare le medesime alla luce della fede. In una prospettiva cristiana si può parlare di pedagogia dell’Incarnazione. Nell’ottica antropologica di pedagogia di umanizzazione.
Emerge subito nelle Regole e nel Correttorio, scritti da Francesco di Paola, il grande rispetto per la persona umana. Il principio primo cui deve tendere l’azione pedagogica è per S. Francesco il cambiamento della persona. Un’annotazione che ritorna più volte in tutte le redazioni della regola e che nel correttorio assume, nell’annunciazione, la forma stessa di un assioma: “si deve ricercare l’emendazione e non l’afflizione dei confratelli”.
Il primato della persona nel campo pedagogico si sposa con il principio di uguaglianza. Cioè «non sono ammissibili preferenze o accezioni di persona, tuttavia la persona non è mai sacrificata alla legge». Il sabato è per l’uomo e non l’uomo per il sabato. Diceva Massimo D’Azeglio “Si può talvolta far cosa pienissimamente legale, ed essere al tempo stesso un solenne mascalzone”.
L’Eremita quando scrive che «a nessuno costituito in autorità è lecito umiliare e opprimere il fratello», sottolinea l’importanza del rispetto della persona.
Scrive Francesco di Paola nella Regola: «Tutti coloro che sono preposti al governo di quest’ordine dei Minimi non senza motivo vengono chiamati correttori: perché correggendo anzitutto se stessi, correggano i frati loro affidati, partecipando alla loro sofferenza (compassive), sicché piamente si rattristino (condoleant) per i difetti dei loro fratelli e cerchino insistentemente piuttosto la loro emendazione che la punizione».
Il commento di Morosini: «Non il freddo giudizio, quindi, di chi siede, giudice, ad analizzare il comportamento altrui in nome della legge, ma la partecipazione viva all’errore di chi sta di fronte non come condannato, ma come fratello, quindi parte di noi stessi – da redimere». Ma anche il valore della riabilitazione dell’errante viene sottolineato quando scrive che «si deve cercare l’emendazione, non l’afflizione del colpevole». Anticipa quel principio della distinzione tra errore ed errante che Giovanni XXIII mise in grande evidenza nella morale cattolica. Questo rende chiaro che ad ogni uomo bisogna dare fiducia, anche se ha sbagliato.
Sul piano pedagogico sappiamo che è di straordinaria importanza dare e ridare fiducia agli alunni che sbagliano consentendo loro di avere un’altra possibilità. Il perdono disciplinare unito però alla riparazione dei danni fatti a persone e cose. Dunque, perdono previa riparazione, ma che apra all’effettiva riconciliazione che avviene dalla cancellazione «interiore» dell’errore.
«Perdonatevi scambievolmente fino a dimenticare il torto ricevuto», scrive l’Asceta. «Il ricordo, infatti, della malizia dell’offesa è complemento di furore, è riserva di peccato, odio di giustizia, freccia arrugginita, veleno dell’anima, dispersione delle virtù, verme nella mente, distrazione della preghiera, lacerazione delle suppliche rivolte a Dio, alienazione della carità, chiodo fisso nell’anima, iniquità sempre desta, rimorso continuo, morte quotidiana. Siffatto vizio è su tutti gli altri tenebroso e detestabile. Allontanate, dunque, l’ira e spegnete il ricordo del torto ricevuto».
Un principio straordinario è la com–passione pedagogica in Francesco quando scrive che l’autorità «si rattristi per i difetti dei loro fratelli e cerchi insistentemente piuttosto la loro emendazione che la punizione».
Nella predicazione del Santo pedagogo possiamo estrapolare anche il concetto dell’auto–formazione, mediante lo studio e la cultura, come crescita dell’essere persona dell’educatore ed intellettuale. Scrive l’Eremita al teologo francese Jean Quintin: «Che poi vi rallegriate che io goda di uomini letterati e di studi, sappiate che non desidero altro se non di avere questi tali, purché all’investigazione degli studi sia uniti l’ardore dell’affetto e delle buone opere. E’ ciò che piace sommamente a Dio, perché l’uomo, attendendo alla perfezione di se stesso, per dottrina e buon esempio può essere utile a molti».
Pietro Baillebis, avvocato, dottore nelle arti e baccelliere in decreti della curia metropolitana di Tours che conobbe Francesco testimonia in maniera plastica la sua viva azione pedagogica affermando che egli aveva «parole ispirate, incoraggiando con esortazioni sante e illuminate, desunte da versetti dei salmi».
Una pedagogia ispirata che sa illuminare la vita delle persone, e l’Eremita calabrese modello per gli educatori chiamati ad essere “lucerne ardenti” che offrono “segni di luce”.
Filippo D’Andrea
La comunicazione di San Francesco di Paola[2]
In premessa bisogna precisare che il termine “Comunicazione” deriva dal latino “comunicatio – communicare”, che significa “mettere in comune qualcosa”. Nel Medioevo questo termine era strettamente legato alla ritualità cristiana, intendendo l’idea di contatto durante la mensa eucaristica, nella quale il fedele entra in contatto fisico con il corpo sacramentale del Cristo. Tuttora si dice che si è “comunicato”, chi ha preso l’ostia consacrata.
La comunicazione è relazione con il prossimo. Si comunica attraverso la parola, il timbro della voce, la postura, l’atteggiamento e il contesto, tutti moduli comportamentali che creano modelli d’interazione. Ognuno di noi crea una serie di messaggi interpersonali che ci rende unici in relazione agli altri. Francesco di Paola aveva un modo di comunicare semplice, essenziale ma profondo e chiarificatore. Moltissimi fedeli si recavano da lui per avere dei consigli, che potessero sollevare il loro animo e quello dei loro cari sofferenti.
Interessante, tra altro, risulta il linguaggio della giustizia, quello espresso in particolare di fronte al potere sia ecclesiastico che politico. «Passando per Assisi – scrive un suo discepolo – si recò a Roma per visitarvi i luoghi santi. Ivi s’incontrò per caso con un Cardinale, che andava accompagnato da un grande corteo e con grande sfarzo di abiti. Con innocente disinvoltura Francesco gli disse: Gli Apostoli di Gesù Cristo non andavano con tanto lusso». Il Cardinale ponderando la grande fermezza con cui il giovinetto diceva queste parole, gli rispose dolcemente: «Figlio mio, non te ne scandalizzare. Se non facessimo così, la Chiesa scapiterebbe alquanto nella stima dei secolari».
Da questo racconto notiamo la disinvoltura con cui il giovane Francesco si rivolgeva ai potenti. La caratteristica più evidente è la sinteticità che crea nell’atto comunicativo un messaggio diretto e fermo, che sottolinea la sua sincera e disarmante fede in Cristo già in età giovane.
Una disinvoltura giovanile che diventa con la maturità nettezza evangelica. E’ quanto si evidenzia nel suo atteggiamento di fronte al prelato inviato dal Papa per indagare sull’ortodossia di vita cristiana dell’Eremita di Paola fa testo in questa linea interpretativa. Quando il Canonico gli disse che solo un villano e rustico come frate Francesco poteva condurre una vita tanto austera. L’Eremita «se empio le mano de tizuni et brasa bene accensi et tendo dicto foco in mano se voltao a dicto Canonico dicendoli guardati se non fosi rustico non porria fare questo et li mostrava lo foco teneva in mano». Una frase breve, concisa, fortemente esplicativa: se non fossi “rustico” non potrei fare questo, ribalta in maniera plastica e decisa il concetto del prelato romano.
Di notevole importanza risulta il modo di Francesco di relazionarsi con il potere politico del tempo. Un esempio chiaro si ha ricordando il rapporto avuto con il re Luigi XI. Il re di Francia, ormai stanco di tutti gli inganni subiti da persone che si professavano sante e fedeli e non lo erano cercò di “tentare” in ogni modo l’Eremita per verificare la sua autenticità di uomo di Dio. Gli porse svariate volte in regalo oggetti preziosi e costosi, in oro e argento, ma Francesco li rifiutò sempre fino a quando all’ennesimo tentativo del Re, disse a voce alta, e «con un tono di voce come se si parlasse di sterco: “Sire restituite questi scudi d’oro a quelli che avete spogliato prima”».
Francesco non si preoccupa delle possibili conseguenze nel dire quella frase, è consapevole della sua veridicità e della confusione che genererà nella mente del sovrano. Ma quello che desidera è farlo riflettere sulle sue ingiustizie e sui valori realmente importanti della vita per la Vita Eterna. Si esprime con un periodo breve ed essenziale, unito coerentemente ad un atteggiamento di rifiuto verso quegli oggetti attrattivi.
Un episodio altrettanto significativo per la nostra analisi comunicologica è quello tramandato dalla tradizione e ripreso da P. Roberti: l’incontro di Francesco con il re di Napoli Ferrante d’Aragona. E’ la scena della moneta spezzata divenuta icona popolare del coraggio e del senso di giustizia dell’Eremita calabrese. Ferrante d’Aragona porge furbescamente un vassoio di monete d’oro al Poverello di Calabria, ma questi mentre spezza una delle monete da cui gronda sangue, pronuncia parole dure e di grande coraggio che resteranno nella memoria del popolo fino ai nostri giorni: «Ecco, il sangue dei tuoi sudditi che grida vendetta al cospetto di Dio!» Forse la risonanza che questo avvenimento ha avuto nell’animo della gente fu così forte che superò la necessità della documentazione scritta.
Il “linguaggio parlato” di frate Francesco viene fuori dal racconto dell’Anonimo e dai testimoni dei processi di canonizzazione. Esaminando attentamente gli scritti dall’Anonimo, si nota che l’Asceta calabrese parla di tutti con intenzioni positive, e non poteva essere diversamente da un uomo di Dio. La parola più presente nel suo lessico, e nella sua missione di vita, è “carità”. Utilizza le frasi “facciamo per carità”, “andiamo per carità” in tutte le sue azioni ed i suoi consigli. Sempre intese come invito alla preghiera, alla conversione e alla manifestazione della propria fede. Spesso questo concetto è accompagnato dalla frase “è la volontà di Dio”, come per sottolineare che i miracoli non sono azione di cui è soggetto, ma del Signore, e che lui, come umile frate, può semplicemente pregare. Nei Processi per la sua canonizzazione vengono riportate espressioni, che possono essere intese codice del suo atteggiamento spirituale, dette in situazione di richiesta di guarigione. Solo con il barone di Belmonte, che aveva una gravissima infezione alla gamba che nessun medico era riuscito a guarire, dice ripetutamente: «bisogna haver una grande fede al nostro Signore Jesu Cristo (…) Ser Jacobo habie fide grande al nostro Signor Jesu Cristo che spero nice donera la gratia», ed aggiunge ulteriormente «habbiati bona fede al Signore che ve fara la gratia…». Dunque, Francesco condivide la vita dei sofferenti, prega e spera con loro.
«Il Re di Napoli […] mandò un padrone di triremi con molti altri ad arrestare il buon Padre e condurlo alla sua presenza. […] Quando il suddetto padrone e i suoi dipendenti giunsero al nostro Convento di Paterno, dove era il buon Padre, quei Religiosi sgomenti, si recarono dal buon Padre, dicendogli: “Padre, scappate: vi cercano per arrestarvi e menarvi dal Re di Napoli!”. “Per Carità – rispose Francesco –; se questa è la volontà di Dio, mi prenderanno; se no nessuno ci potrà fare del male”. E si recò in chiesa. […] non riuscirono a scoprirlo. Eppure, egli era in chiesa, dove tante volte lo avevano cercato!».
Anche in questo episodio di pericolo e di forte tensione dei suoi confratelli, Francesco ha reagito, con parole di serenità e abbandono al volere di Dio; utilizzando, con tono calmo e pacato i paradigmi nominali: “Per carità” e “la volontà di Dio”.
Gli elementi essenziali con cui l’eremita tranquillizza i suoi frati, i fedeli, i malati e i sofferenti sono “carità”, la possibilità di una “grazia” divina, affidarsi tutto alla “volontà di Dio”, raccomandando al termine dei vari incontri di “essere un buon cristiano”.
“Il linguaggio scritto” di Frate Francesco si evidenzia nella Protoregola, nelle Regole e nelle Lettere.
Leggendo le Regole la prima cosa che emerge è che il linguaggio è “parlato”, ciò ne risulta che sono state prima dette, ovvero formulate oralmente, comunicate verbalmente e solo in un secondo momento scritte.
Un altro elemento da sottolineare, non scontato, è che l’eremita, in particolare nella Protoregola, utilizza il “noi” e non il “voi”. Infatti, sottolinea i sacrifici da praticare ed i comandamenti da osservare, includendo il suo impegno, identificandosi pienamente nella dimensione comunitaria del suo piccolo gruppo di fraticelli.
Possiamo aggiungere, anche, che il linguaggio scritto, utilizzato dall’Asceta calabrese nelle Regole, è molto descrittiva: impartisce istruzioni dettagliate e concrete sui compiti assegnati e sulle eventuali punizioni inflitte a chi, entrato nella sua congregazione, non si comporta fedelmente.
Dalla struttura comunicativa della Protoregola si evince il bilinguismo. Francesco di Paola utilizza, anche nello stesso periodo, frasi in latino ed in italiano. Il Latino è utilizzato come lingua per chiarire meglio i concetti espressi, riportando anche frasi dal Vangelo o dai Profeti. Forse l’Eremita pensa a destinatari ecclesiastici che, suppone, conoscano il latino e le Sacre Scritture. Infatti, le citazioni sono concetti, esempi, o esplicitazioni attraverso il testo biblico.
Nella comunicazione non conta solo il significato di quello che diciamo, ma anche i gesti, i movimenti, lo spirito e il trasporto che mettiamo nel dirlo. Frate Francesco comunicava molto anche con i silenzi. Spesso si isolava per lunghi periodi di digiuno e preghiera, senza parlare con nessuno, neanche con i suoi fratelli. Comunicava la sua intensa e umile fede in Dio. Infatti, la prima caratteristica della comunicazione è che non è possibile non attuarla. La testimonianza di Francesco trasmetteva emozione e un sentimento profondo di fede e abbandono nelle mani di Dio. E’ il “linguaggio del silenzio”, del silenzio contemplativo.
Chiara D’Andrea
L’orizzonte politico di San Francesco da Paola[3]
Ci si limiterà a rilevare solo alcune suggestioni di natura politica – intesa nel suo senso ampio di coscienza civica – trovabili nella testimonianza e spiritualità di frate Francesco di Paola, ritenute significative, nonostante siano passate oltre cinque secoli, per la vita politica contemporanea.
–La giustizia principio primo della politica. «La giustizia è … quell’ordine in cui l’uomo può sussistere come persona», scrive Romano Guardini. Francesco di Paola testimoniò questo principio in diversi momenti. Forse il più alto, come narra la tradizione, quando davanti al re di Napoli, Ferrante d’Aragona, spezzò la moneta che gli era stata offerta dicendo: «Questo è il sangue dei poveri che grida vendetta al cospetto di Dio». E in una lettera del 1447 scrive: «Guai a chi regge e mal regge, guai ai Ministri dei tiranni e alle tirannie, guai ai Ministri di giustizia, che è ordinato loro di amministrare la giustizia e invece fanno il contrario».
Un paolano si recò da Francesco per la guarigione di un terribile ed insistente mal di schiena e l’Eremita colse l’occasione per esortarlo a perseguire non solo i propri interessi con l’attività lavorativa, al punto da danneggiare gli altri, ma a tenere presente la giustizia, e quindi a calmare il suo atteggiamento egoistico e predatorio. Il valore sociale del lavoro e dell’impresa.
Il re Carlo VIII aveva acquistato un pezzo di terra a Tours per farvi costruire un convento per Francesco ed suoi i frati. Il venditore un giorno andò a trovare il frate calabrese, il quale gli domandò con insistenza se fosse stato soddisfatto dalla somma datagli dal re. Racconta questo episodio lo stesso venditore. Un fatto che testimonia l’alto senso della giustizia che alberga nell’animo dell’Asceta calabrese. Francesco si rivolge al re di Francia Luigi XI con grande coraggio: «Maestà restituite questi scudi d’oro a quelli che avete spogliati prima».
–Carità e verità fondamenti della legalità pubblica. In frate Francesco è forte il senso di saggia giustizia dell’Autorità politica ed il senso della cosa pubblica. E in una sua lettera, in cui si sposano verità e giustizia, scrive: «Io non dico che debbano essere evase le tasse alla maestà del re, perché sarebbe frode. Vorrei però che la discrezione si accompagni alla pietà e che la santa carità fosse presente nei ministri dello Stato, e non la malvagità, che usano continuamente verso i poveri: vedove, orfani, storpi e altri miserabili». L’Eremita per un verso presenta il senso della cosa pubblica per la sua contrarietà all’evasione fiscale, per l’altro pone la saggezza come principio base della giustizia dell’amministrazione politica.
In un certo senso Francesco dice: il discernimento sapiente dei politici e della pubblica amministrazione rafforza nei cittadini il senso della legge e dello Stato. Nella realtà qualche volta si spaccia con astuzia il legalismo per legalità, cercando di nascondere corruzione e soprusi verso i deboli, i senza–protettori, chi non ha santi in paradiso. Sono i metodi che fanno diventare favori i diritti. Sistema che origina clientele e quindi servilismo collettivo, sottomissione del territorio ai poteri reali, ridimensionamento della libertà e svilimento della dignità dell’uomo.
–La partecipazione politica. Il valore della partecipazione si evidenzia sia nel suo periodo calabrese, che in quello francese. Frate Francesco partecipa ai problemi quotidiani, sociali, familiari della gente calabrese, vessata dall’esosità tributaria del re di Napoli, a cui si univano i soprusi dei baroni. Egli alza la voce a difesa della gente indifesa. La sua partecipazione è verso singoli, famiglie, società nel suo complesso. Esprime la capacità di convincere a partecipare alla costruzione dei luoghi di culto e dei conventi che diventano riferimenti sociali di solidarietà materiale e morale, a partire da Paola e Paterno.
Ma anche la sua stessa scelta di vita eremitica è stata convincente al punto da attrarre alla condivisione tanti giovani come lui, formando il primo nucleo di eremitismo condiviso al romitorio di Paola. Circa 10–12 ragazzi che lo seguirono con entusiasmo nell’avventura dello spirito nel silenzio della collina di Paola.
In Francia la sua partecipazione è sul piano della diplomazia internazionale. I pontefici e Ferrante d’Aragona incaricano Francesco di risolvere rilevanti questioni politiche con il re di Francia Luigi XI. Problemi politici e diplomatici, fino a riguardare i rapporti tra le nazioni e la pace in Europa vedono la partecipazione di Francesco, con estrema discrezione, ma con grande finezza unite ad una dimensione spirituale unica. I suoi frequenti incontri con Luigi XI e poi Carlo VIII, con gli uomini della corte, erano certamente di significato religioso ma toccavano inevitabilmente problemi aperti e difficili della gestione del potere politico.
–La sobrietà per la civiltà del sufficiente. Frate Francesco vestiva un saio, si cibava di erbe crude e legumi bolliti, viveva in una grotta, una capanna, una celletta e dormiva su una pietra, oppure su un pagliericcio. Certamente la sua era scelta estrema di povertà, ma si potrebbe estrapolare da questa scelta così radicale un valore vivibile obiettivamente oggi, ed estremamente necessario: la sobrietà esistenziale. Il messaggio di questo rivoluzionario dello spirito del Quattrocento calabrese ed europeo, in una società con un notevole decadimento morale del clero e non solo, è di vivere nell’oggi un valore determinante per restare persona nella società dei consumi, del mercato, del superfluo. La sobrietà è difficilissimo da trasmettere soprattutto tra i giovani ma è indispensabile per il futuro. Se si parla di produzione e ambiente sostenibile, distribuzione mondiale delle ricchezze, diffusione nelle aree povere dei mezzi di produzione, si deve parlare di cultura ed educazione alla sobrietà, nell’orizzonte della civiltà del sufficiente come formulò uno degli uomini più illuminati del novecento, il gesuita P. Pedro Arrupe.
Radicale è frate Francesco quando indirizza nella Regola ai suoi frati: «Pertanto non tolleriamo che le nostre dimore suscitino ammirazione: tanto le case come le chiese siano modeste e umili, e tali che dappertutto risplenda la santa povertà».
Filippo D’Andrea
Martolilla e non D’Alessi il vero cognome di Francesco di Paola
Nell’anno delle celebrazioni per il quinto Centenario della morte è stato anche ricostruito il vero cognome di San Francesco di Paola. Sarebbe Martolilla e non D’Alessi, come spesso si è sentito dire.
La provocazione (se tale si può chiamare) arriva dalla stessa Curia Generalizia dell’Ordine dei Minimi, che nel Duemila ha dato alle stampe il volume di Giuseppe Fiorini Morosini, Superiore Generale, Il carisma penitenziale di San Francesco di Paola e dell’Ordine dei Minimi. Storia e spiritualità, nel quale è riportata la notizia della scoperta del nuovo cognome (pagine 16 e 17 e nota 52 del libro).
Padre Rocco Benvenuto, lo storico dell’Ordine dei Minimi, avrebbe infatti ipotizzato l’attribuzione al Santo del cognome Martolilla sulla base di un atto notarile rinvenuto nell’archivio del Santuario di Paola. Il notaio Andrea Marchese il 29 ottobre 1503 avrebbe rogato a Paola un atto con il quale «Brigida di Martolilla, figlia della defunta Vienna, –si legge nel volume di Morosini– dona al convento di Paola la quarta parte di un possedimento ubicato tra Torano e Lattarico». La donna altro non è che la sorella di San Francesco e viene indicata con il cognome di Martolilla. Di questo atto parla anche Giuseppe Perrimezzi in Vita San Francisci de Paula et dissertationibus illustrata (vol. II, diss. V, pag. 98–99), pubblicato nel 1707.
Anche nel processo di Cosenza quando si fa riferimento al papà di Francesco lo si indica con il cognome di Martolilla. Infatti, si legge che nella stessa terra di Paola è nato «Giacomo Martolillla, padre di frate Francesco».
Ma non solo. Anche nella bolla di canonizzazione, il padre di Francesco di Paola viene indicato con il cognome di Martolilla: «…Constat siquidem in Regno Neapolitano, inter Brutios et Lucanos, Paule oppidum situm esse quod itinere unius diei a Cusentia, illus provincie metropoli, distat; inde originem trait Iacobus Martolilla, illi proximum et castrum Folschaud, ubi nata est Vienna. Ex hoc matrimonio beatus Franciscus de Paula procreatur» («Si consta infatti che nel Regno Napoletano, fra i Calabresi e i Lucani, vi sia una città chiamata Paola che dista da Cosenza per un giorno di cammino; ivi ebbe i natali Giacomo Martolilla, non meno distante da Paola si trova Fuscaldo, ove nacque Vienna. Dal matrimonio di Giacomo e di Vienna nacque Francesco»).
Ora una domanda sorge spontanea: come mai a San Francesco di Paola venne attribuito il cognome D’Alessio? La risposta non è tanto semplice. Ma argomentando si arriva a qualche conclusione. L’unica cosa certa, infatti, è che il cognome D’Alessio sarebbe appartenuto al cognato di San Francesco (il marito della sorella Brigida), il cui figlio, Andrea D’Alessio, sarebbe stato mandato al servizio del re di Francia.
Comunque sia, il cognome Martolilla (trasformazione di Bartolillo, cioè figlio di Bartolo) i biografi del tempo già lo conoscevano. Il problema è che sarebbe stato ritenuto un soprannome utilizzato per distinguere il padre di San Francesco da un altro parente. Un errore quindi? Forse sì, forse no. Oggi si è pronti a cambiare gran parte delle biografie del Santo. Anche se qualcuno vi ha già provveduto. Basti pensare che su Wikipedia, l’enciclopedia libera più in voga su internet, il cognome del padre di Francesco non risulta erroneamente D’Alessi, ma correttamente Martolilla. Nell’era della comunicazione informatizzata bisogna stare al passo con i tempi. Non è vero?
Luigi Mariano Guzzo
[1] Questo contributo era stato edito in forma molto più ridotta per esigenze tipografiche.
[2] Nel 2007 questo contributo era stato edito in forma molto più ridotta per esigenze tipografiche.
[3] Questo intervento era stato escluso dalla brochure del 2007 sia perché arrivato fuori tempo massimo, sia perché la sua lunghezza esulava troppo dai ferrei limiti imposti, sia perché l’Autore aveva già inviato un altro pregiato intervento (cfr. supra).
Anno 2008
Specchio della storia: le migrazioni mediterranee da nord a sud[1]
Gli italiani in Egitto
La comunità italiana in Egitto al culmine della sua presenza, alla fine degli anni Venti del XX secolo, ammontava a 60–70 mila unità. Gli italiani avevano cominciato a emigrare in Egitto all’inizio del XIX secolo per ragioni politiche. Dopo la sconfitta di Napoleone e il fallimento dei primi moti rivoluzionari del 1820–1821 e 1831, un primo gruppo di italiani arrivò in Egitto per sfuggire alla restaurazione dei vecchi regimi e alla persecuzione politica. Lo stesso accadde nel 1849 dopo la sconfitta nella prima guerra di indipendenza.
A questo primo gruppo appartenevano molti giovani, studenti e professionisti, che cominciarono a collaborare ai progetti di modernizzazione del governo di Mohammed Ali. Come ingegneri e architetti, medici e ufficiali, o come semplici artigiani e operai, essi contribuirono alla nascita dell’esercito egiziano, alla ricostruzione delle città, all’organizzazione del sistema postale e del catasto. Bastino due esempi: all’inizio del XIX secolo un architetto italiano costruì la piazza dei consoli ad Alessandria e alla fine del secolo un professore dell’Università italiana fu invitato a riorganizzare il sistema finanziario dell’Egitto.
Da questo primo gruppo di emigranti deriva una delle caratteristiche della comunità: la presenza di numerose logge massoniche italiane, che all’inizio del XX secolo erano ben 11 nella sola Alessandria. La ragione di questo fenomeno è da ricercare nelle organizzazioni segrete presenti in Italia e nel sistema capitolare vigente in Egitto.
Un’altra caratteristica che merita di essere sottolineata è la presenza tra gli italiani di una forte componente ebraica. Se in Italia gli ebrei erano meno dell’uno per cento della popolazione in Egitto rappresentavano circa il dieci per cento. Le leggi razziali del 1938 danneggiarono gravemente la comunità privandola del contributo ebraico alle istituzioni benefiche.
La seconda ondata migratoria fu essenzialmente di natura economica e iniziò alla fine del XIX secolo e continuò fino agli anni successivi alla prima guerra mondiale. In questo periodo, insieme a una maggioranza di persone oneste, molti avventurieri raggiunsero l’Egitto creando problemi alle autorità consolari italiane. Oltre a lavorare nell’industria delle costruzioni o come impiegati nella Compagnia del Canale, i nuovi emigranti aprirono negozi, ristoranti, alberghi e iniziarono a lavorare come impiegati presso le imprese italiane e straniere. Negli anni Venti la maggior parte degli italiani erano impiegati di alto o basso livello. Al livello più alto c’erano i professori dell’Università del Cairo e i giudici dei tribunali.
A causa del sistema capitolare i rapporti con la madre patria non erano interrotti e molti giovani presero parte alla prima guerra mondiale. Solo i pochi ricchi e gli impiegati delle istituzioni nazionali tornavano in Italia per le vacanze. Gli altri restavano in Egitto dove guadagnavano il doppio di quanto avrebbero guadagnato in Italia, non pagavano tasse, ed erano assistiti dalle società di beneficenza locali.
Dal punto di vista politico, la comunità, dopo una prima resistenza, fu quasi completamente fascistizzata. D’altra parte le capitolazioni rendevano possibile l’espulsione degli elementi indesiderati come accadde, ad esempio, a coloro che negli anni Venti organizzarono i primi scioperi dei tipografi e dei tranvieri o appoggiavano il movimento nazionalista egiziano. Una situazione completamente diversa da quella degli altri paesi di emigrazione anche in nord Africa.
Marta Petricioli
[1] Quasi tutti i contributi raccolti quest’anno, per esigenze tipografiche, erano stati pubblicati in forma molto ridotta. In questa occasione li presentiamo nella forma integrale inizialmente inviataci dagli autori.
Processi migratori nel Mediterraneo
Il Mediterraneo è tornato ad essere il laboratorio d’Europa e dei paesi terzi, luogo paradigmatico dove hanno luogo macro–processi che hanno sconvolto e sconvolgono il suo l’equilibrio. L’impatto destrutturante della globalizzazione economico–finanziaria e quello della rivoluzione dell’informazione e della comunicazione incidono radicalmente sia sulle società della riva nord che su quelle della riva sud di questo mare: dall’economia alla demografia, dalla sociologia all’antropologia culturale, dall’ecologia allo sviluppo sostenibile.
Tra i mutamenti impressionanti che hanno luogo in quest’area, ci limitiamo ad evidenziare due macro–processi: la demografia e le migrazioni, processi questi che sono causa ed effetto dell’inevitabile incontro–scontro delle persone migranti e delle loro culture. La minaccia della cosiddetta “bomba demografica”, in forza dell’abnorme differenziale di crescita delle popolazioni tra le due rive, è un dato di fatto; basta ricordare che negli anni Cinquanta la riva nord aveva i 2/3 dell’intera popolazione del bacino mentre oggi i rapporti si stanno rapidamente invertendo. Secondo le previsioni statistiche della World Bank e del CNRS di Parigi la situazione si capovolgerà radicalmente verso il 2025 se l’attuale trend demografico continuerà (uno scarso 3% al nord contro un 30–50% al sud), e il divario del livello di vita tra le due sponde crescerà. Di conseguenza il fenomeno delle migrazioni diventerà sempre più esponenziale nel Mediterraneo, confermando che esso è uno degli aspetti centrali della nostra civiltà postmoderna. E’ l’epoca di the people on the move: oltre 250 milioni nel mondo! E’ l’Europa della rivoluzione industriale che ha dato l’avvio a questi macroscopici processi migratori: ad esempio, oltre ottanta milioni d’europei sono emigrati negli altri continenti e sulle coste del Mediterraneo; tra cui l’emigrazione italiana è stato il caso più paradigmatico: nell’arco di un secolo (1876–1976) ha esportato oltre 28 milioni di emigranti. Oggi la storia si è capovolta: l’Europa è diventata terra d’immigrazione, includendo a partire dagli anni Settanta e Ottanta, anche i tradizionali paesi d’emigrazione come l’Italia, la Spagna, il Portogallo e Grecia. Le nostre società stanno diventando multietniche e multiculturali: nuovi simboli e segni s’impongono nella nostra realtà quotidiana, dalla parlata alla gastronomia, dalla foggia dell’abbigliamento alla way–of–life, insomma, incontri di culture, di religioni, di lingue diverse che sconvolgono la nostra quotidianità; e con essi nuove problematiche che ci interpellano e ci condizionano.
Non passa quasi giorno che sulle nostre coste sbarcano i disperati della speranza con tutto il loro carico di problemi e per noi e per loro, come ce li fanno vedere i mass media nella loro cruda immediatezza, suscitando i più disparati sentimenti che vanno dalla pietà alla xenofobia. Ma questi processi migratori ci devono far ricordare i nostri antenati che nell’Ottocento e all’inizio del Novecento facevano il percorso in senso inverso, diretti verso la vicina Tunisia o gli altri porti mediterranei alla disperata ricerca di un pezzo di pane e di speranza, come testimoniano i giornali e la documentazione dell’epoca. Allora come oggi, vi troviamo le stesse barche della disperazione e della speranza.
L’emigrazione è fisiologica, nessun muro o filo spinato la fermerà finché saranno i poveri ad andare verso il pane, e non viceversa! In quest’ottica forse noi dobbiamo chiederci: il Mediterraneo, di cui una costante caratteristica è stata la mobilità delle sue genti nei secoli, è sempre quell’espace–mouvement di civiltà e culture che dialogano ed interagiscono visto da Fernand Braudel o lo stiamo trasformando in un metaforico muro d’incomunicabilità dove si contrappongono pregiudizi, fondamentalismi e barriere d’ogni tipo?
Considerate le difficoltà politico–economiche operanti oggi in questo mare, bisogna puntare sul “dialogo interculturale” cui finora si è dato poca importanza per la reciproca ignoranza e i pregiudizi. Oggi si parla di confidence building measures: occorre realizzarle con la conoscenza e il dialogo tra culture e civiltà. Sono processi di apprendimento reciproco in tempi non brevi ma necessari, se si vuole creare un ecosistema di nuovi rapporti economici, politici e socioculturali nel Mediterraneo per sapere come dialogare gli uni con gli altri e quindi accettarsi, collaborare ed interagire nel rispetto delle proprie identità e valori. Proprio per contrastare la preoccupante affermazione di S. P. Huntington: «the next war will be a war between civilizations», si deve promuovere la reciproca conoscenza e comprensione tramite l’interculturalità: sviluppare i legami culturali e sociali esistenti tra le civiltà compresenti nel Mediterraneo e farle dialogare aldilà delle barriere etniche, culturali e religiose. Il dialogo euromediterraneo non è più un optional: è una necessità come dimostra la problematica realtà dell’immigrazione attorno a noi.
In quest’ottica, il Mediterraneo può ripensare se stesso, riappropriarsi delle sue risorse umane e materiali, elaborare un paradigma intersocietale ed interculturale a misura delle sue diverse culture e civiltà, corroborato da una prassi interattiva tra persone e culture che tendono verso un progetto sociale di emancipazione e coabitazione democratica e di stato di diritto, verso un patto di nuova cittadinanza, memori del monito di F. Braudel: «Il Mediterraneo è ciò che ne fanno gli uomini».
Michele Brondino
La prima emigrazione maghrebina in Italia (1917–1918)
Mentre dalla sponda meridionale alla sponda settentrionale del Mediterraneo l’emigrazione dei lavoratori in età contemporanea ha una storia piuttosto lunga – quasi secolare (soprattutto a partire dalla prima guerra mondiale) ad esempio in Francia –, l’Italia ha conosciuto solamente a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso il fenomeno nella sua dimensione continua. C’è stato tuttavia un episodio, che può essere definito come la prima emigrazione di lavoratori maghrebini in Italia, svoltosi negli anni 1917–1918, circoscritto nella sua dimensione temporale ma di non indifferente portata quantitativa (esso interessò più di cinquemila persone), che vide spostarsi dalla Libia verso le zone industriali italiane una manodopera “indigena” destinata a sostituire quella “nazionale” impegnata nel grande massacro della guerra di trincea ai sacri confini o negli altri teatri del conflitto.
Poco conosciuta o studiata, questa prima emigrazione fu voluta dagli organismi di governo italiani e coloniali, e aveva tra i suoi scopi non solamente quello di offrire, soprattutto alle industrie manifatturiere del nord, una manodopera a buon mercato e sottomessa – tra l’altro sottoposta alla legislazione di guerra e militarizzata –, ma anche di sottrarre alla colonia una quantità di diseredati potenzialmente pericolosi: come ebbe a dire il governatore Ameglio all’inizio dell’operazione, «tanti uomini si manderanno in Italia […] e tanti fucili di meno si avranno contro [in Libia]».
In poco più di un anno, dal luglio 1917 all’agosto 1918, giunsero in Italia 23 scaglioni di manodopera libica, per un totale di 5.480 uomini: circa 1.500 di essi provenivano dalla Libia orientale, mentre il resto, la maggior parte, partì dalla Tripolitania. Erano destinati quasi totalmente alle industrie della Liguria, del Piemonte e della Lombardia, ma alcuni scaglioni furono inviati al lavoro nei cantieri di Castellammare di Stabia, in Campania, e anche in Sicilia e in Calabria.
La documentazione che permette di ricostruire la vicenda non è molto ricca: alcune tabelle statistiche riprodotte in bollettini ufficiali di istituzioni governative, pochi carteggi d’archivio degli organi di controllo locale, soprattutto delle prefetture e degli uffici di polizia, qualche immagine fotografica… Non sono conosciuti documenti che permettano, se non di vedere, anche soltanto di intravedere la vicenda con gli occhi dei lavoratori che emigrarono dalla Libia. Una lontana eco della loro voce ci giunge attraverso il filtro dei funzionari di governo e delle società industriali che dovevano controllarli: sono spesso voci di malessere e di protesta (abuso di alcolici – forse l’unico strumento di evasione –, malcontento creato dall’obbligo del lavoro anche nei giorni di festa religiosa, dalla durezza del controllo e dalla poca libertà di spostamento…). Mancandoci la loro voce, e fino ad ora anche la voce dei lavoratori italiani che li avvicinarono, non sappiamo quali furono le relazioni che stabilirono con i loro compagni, soprattutto nelle fabbriche. Si può immaginare che le barriere di separazione fossero troppo alte, e che il tempo dell’esperienza fu troppo breve perché fosse possibile superarle o abbatterle: a parte quella del controllo militare e della residenza (una delle prime preoccupazioni delle autorità locali fu quella di tenerli lontani dalle donne italiane, per evitare a queste un contatto ritenuto «degradante»), la barriera della lingua fu probabilmente una delle più difficili da sormontare, come forse quelle della razza e della religione.
Un’esperienza analoga e contemporanea, ma di ben più vasta portata storica e di maggiore dimensione spaziale e temporale, stavano vivendo i lavoratori algerini che il governo francese aveva fatto emigrare verso le fabbriche della madrepatria per sostenere la produzione di guerra: tra questa prima avanguardia operaia maghrebina in Francia comincerà più tardi a germogliare l’idea della liberazione dal giogo coloniale e dell’indipendenza. Forse lo stesso sentimento, della possibile emancipazione da una o più schiavitù, avrebbe potuto nascere tra i lavoratori libici in Italia se fossero rimasti per un periodo più lungo (ricordiamo che tutti furono fatti tornare ai loro luoghi di origine entro i primi mesi del 1919). Più difficilmente avrebbero potuto sviluppare un sentimento di ammirazione per una disinteressata società superiore «che non pensa affatto allo sfruttamento delle colonie per depauperarle, ma invece […] vuole provvedere al miglioramento di esse» e che le avrebbe ammesse «a godere delle nostre conquiste nel campo del lavoro», come si legge in una relazione ministeriale… Ma sono illazioni, e non sappiamo nulla di storicamente preciso sull’esperienza dei lavoratori libici in Italia negli ultimi anni della prima guerra mondiale, né sugli eventuali sviluppi intellettuali e politici generati da questa esperienza tra coloro che la vissero.
Federico Cresti
Mediterraneo: mobilità, identità, integrazione[1]
Il Mediterraneo è oggi un’area di frontiera estremamente complessa, frontiera di scambi, di squilibri, nel vortice della globalizzazione e della rivoluzione dell’informazione. Le ricadute di questa complessità in continua evoluzione si riassumono in tre parole chiave: mobilità, identità, integrazione.
La mobilità è l’elemento maggiormente sconvolgente. Perché non si tratta solo di mobilità delle persone nello spazio (oggi si valuta che 250 milioni di persone sono migranti nel mondo); ci sono, certo, le persone in cerca di un posto migliore al sole e che nessuno fermerà finché gli squilibri di sviluppo saranno cosi acuti, ma si aggiungono a questi migranti /emigrati che conoscevamo già, altri tipi di mobilità.
La mobilità professionale, gli emigrati colti, gli ingegneri, i chimici, gli informatici… che arrivano già formati, sempre più numerosi dall’India, dall’Est, e che hanno un’altra visione della loro integrazione, la mobilità legata al moltiplicarsi delle transazioni, al lavoro, al turismo di massa che ha sostituito quello di élite.
E quando non ci si muove fisicamente, c’è la mobilità virtuale: ci si sente e ci si vede da un estremo all’altro del mondo con modica spesa e senza limiti di tempo, si naviga su internet per conoscere realtà altre e frugare nell’informazione; per non parlare della mobilità del sapere che ci costringe, nelle scuole a rivedere i nostri metodi. E anche senza muoverci, né fisicamente né virtualmente, senza andare verso l’Altro, verso il diverso, è l’Altro che arriva. Lo spaesamento quindi è reciproco, quello di chi parte, quello di chi accoglie.
Ma questa mobilità, che da occasionale sta diventando essenziale, sta trasformando profondamente i cittadini del XXI secolo e tutti i rapporti infrapersonali. Siamo di fronte ad una mutazione antropologica.
Non c’è più tra individuo e territorio una linearità una volta indiscussa. Stiamo tutti, volenti o nolenti, anche se a livelli diversi, diventando nomadi, cioè spinti a spostarci in altri mondi, in altre culture. Dobbiamo ripensare il nostro rapporto al mondo locale e globale perché siamo condannati a vivere in una società mista, meticcia, al plurale.
Questa diversità culturale non può essere subita, va gestita. E lì inizia il difficile perché tutto o quasi resta da inventare. Vari approcci sono stati tentati negli ultimi decenni per gestire la diversità, da quando la mobilità era solo emigrazione.
Il modello anglo–sassone è il cosiddetto multiculturalismo, il quale garantisce la convivenza di vari gruppi etnici ma favorisce pure la formazione di ghetti che non sono altro che una giustapposizione, un allinearsi delle differenze sotto una pesante tutela normativa, senza giungere ad una forma di comunicazione in grado di risolvere le profonde disparità e le violenze che ne derivano.
La Francia invece, portatrice di altre tradizioni filosofiche e giuridiche (i Lumi, l’universalismo, la Repubblica) ha cercato di mettere in opera un approccio totalmente diverso. La convinzione che soltanto l’assimilazione degli emigrati ad un modello di civiltà nazionale, ritenuto universale, potesse funzionare, è stato severamente smentito dai risultati e dal fallimento della Repubblica che ha educato i figli dei suoi emigrati ai principi di Liberté, Egalité, Fraternité senza riuscire a garantirne l’applicazione e ad evitare la discriminazione (vedi la crisi delle banlieues).
Non si tratta più di integrare il diverso, si tratta ormai di trovare una sintesi di coabitazione.
Abbiamo bisogno di nuovi modelli, di nuove sintesi, di una nuova intelligenza dei rapporti con l’Altro. Dagli errori si impara, ma anche dal ripensare concetti che credevamo fissi e che non lo sono più: primo fra tutti l’identità, alla quale inevitabilmente tentiamo di aggrapparci quando la diversità che ci circonda, ci sembra troppo aggressiva. Ma è proprio il considerare l’identità come perno il pericolo maggiore. Ogni identità, come ogni cultura è il risultato di una sedimentazione, dell’amalgama di più culture. L’Occidente ha inventato la modernità: questa straordinaria capacità di amalgamare in una cultura fatta sua, una miriade di apporti diversi, e di pensare la cultura in continua evoluzione. Oggi, è sempre l’Occidente ad aver messo in moto la globalizzazione tendente a creare un’economia di matrice, la quale però non può escludere la libera circolazione degli uomini, dopo aver scatenato la libera circolazione delle merci, dei modelli, delle informazioni, delle culture.
Per questo stiamo vivendo una svolta epocale: la modernità è passata, la postmodernità va oltre e ci chiede di fare un altro salto: quello dell’interculturalità, quello dell’invenzione di nuove sintesi che facciano emergere una società in cui la rivoluzione della comunicazione sia al servizio della coabitazione, perché questo è il destino dell’umanità. Ma non sappiamo ancora fare coabitare le differenze, anzi i governi spesso ne esaltano i rischi per imporre la pace attraverso l’annientamento dell’Altro.
Fortunatamente le grandi organizzazioni internazionali hanno recepito il messaggio: nel 2005, l’UNESCO ha dichiarato la diversità culturale patrimonio dell’umanità e la Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale è stata firmata da quasi 200 paesi ad esclusione degli USA .
Bisogna però passare dalle parole e dalle dichiarazioni ufficiali ai fatti.
Tutto questo funzionerà se si capirà che l’interculturalità richiede che io mi rimetta in questione insieme all’altro, che non basta la conoscenza dell’altro, ma che serve interrogarsi pure sulla nostra identità, su i suoi valori irrinunciabili e sugli spazi di mediazione.
Il Mediterraneo, luogo per eccellenza di mediazione e di scambi, non può rischiare di non sapere coabitare con il diverso. Ci vuole buona volontà, generosità certo, ma i tempi della buona coscienza sono addirittura superati, ci vuole soprattutto intelligenza, perché non c’è scelta.
Yvonne Fracassetti Brondino
Un sguardo sulla Piccola Sicilia di Tunisi[2]
Aurelio De Montis, tranquillo direttore della tipografia tunisina Saliba, diventa lo scrittore Cesare Luccio il giorno in cui legge quell’insieme di quadretti della vita tunisina pubblicati con il titolo Le Prince Jaffar (1° ed. 1924, 2° ed. 1932), opera dello scrittore ed accademico di Francia Georges Duhamel il quale non esita a malmenare gli italiani portatori “di pulci fameliche”. Da quel momento, tutti gli sforzi dello scrittore italo–tunisino saranno volti ad un unico obiettivo: riabilitare gli italiani agli occhi dei francesi. Il periodo storico in cui prende corpo la parte più notevole della produzione letteraria di Cesare Luccio – gli anni Trenta del Novecento – è attraversato dai sussulti che, con la seconda guerra mondiale, scompagineranno l’assetto sociale della Tunisia coloniale. Il decennio che ci interessa è socialmente strutturato secondo modalità che paiono ormai ben stabilizzate: da una parte i colonizzatori francesi che hanno da poco festeggiato (1931) i cinquant’anni dalla firma del Protettorato, dall’altra i tunisini colonizzati in cui serpeggiano e vanno via via prendendo forma le istanze indipendentistiche. Fra loro, nel complesso panorama sociale in cui si contano maltesi, greci, russi fra gli europei ed ebrei e musulmani fra gli autoctoni, domina il gruppo degli italiani in gran parte immigrati dal sud Italia, che si lascia sempre più conquistare dalla tenace propaganda fascista. E’ proprio negli anni Trenta che la question italienne si pone alle autorità francesi in termini di pericolo, vuoi per l’attività fascista sempre più ramificata e intensa, vuoi per il numero stesso degli italiani che a stento, proprio in quegli anni, si assesta appena al di sotto di quello dei francesi.
In questo particolare contesto si pone l’opera di Cesare Luccio, animata dalla necessità costante di testimoniare la vita di un gruppo sociale tenuto a debita distanza dalla cultura egemone. Come dirà alcuni anni più tardi Mouloud Feraoun, «si on assume cette tâche d’écrire, ce ne doit être qu’avec crainte et respect, par devoir, respect pour son semblable, crainte de lui nuire en le défigurant; espoir surtout de le comprendre, de le faire connaître et aimer, de plaider pour la commune condition». E’ con questo stesso spirito che Luccio, inconsapevole precursore di quella letteratura etnografica che fiorirà alcuni decenni dopo, affronta la scrittura. Con l’umiltà e la pazienza dell’artigiano, lo scrittore fa emergere un mondo di piccoli eroi della lotta quotidiana per la sopravvivenza. Grazie alla precisione etnografica che caratterizza quella scrittura, si anima davanti ai nostri occhi il quartiere della Piccola Sicilia di Tunisi («Cinq mille siciliens pauvres y vivaient entre eux dans des maisons basses, surchauffées ou humides suivant les saisons, habitant à trois ou quatre familles dans des patios d’autant de pièces réunies par une cour commune donnant sur la rue…», Une Vendetta, in La Kahena, Ag.–sett. 1937, p. 12), con i suoi abitanti sempre a rischio di saltare il pasto («Un vendredi l’épicier refusa tout crédit; Donna Sarina, habituée à ces taquineries de la vie, s’en fut avec Clorinda dans les champs de Mélassine et le soir elle porta sur la table une grande marmite d’herbes bouillies», Paolo, fils de Luciano Amato, in La Kahena, aprile 1935, p. 4); con le demolizioni e le trasformazioni del quartiere che obbligano a riformulare i propri progetti di vita come fa il barbiere don Totò che trasforma il buio negozietto in lavanderia («… un jour, au mépris de la dignité masculine, il vendit les deux fauteuils et céda la boutique à sa femme qui accrocha à la porte une petite ardoise d’enfant sur laquelle elle avait écrit simplement: Blanchisserie du Bonheur», La Blanchisserie du Bonheur, in La Kahena, dic. 1936, p. 11). Ma prima degli stravolgimenti che daranno un volto moderno al quartiere con l’eliminazione di tutte quelle casupole così felicemente descritte da Luccio, prende vita tutto un brulichio di personaggi nelle novelle raccolte in La Sicile à Tunis (1934), strutturate in modo che le vite degli uni s’intreccino abilmente con quelle degli altri (è sufficiente infatti attraversare la strada per passare da una storia all’altra), quasi a sottolineare il comune destino di tutti gli abitanti del quartiere. Personaggi diversi per carattere e passato si ritrovano uniti dalla lotta quotidiana per la sopravvivenza e da un forte senso dell’onore e del rispetto reciproco. Così tre famiglie non imparentate abitanti l’una accanto all’altra nello stesso patio inscenano abilmente la fuga di due fidanzati per evitare le spese della festa di nozze (Carruzzedda). O una famiglia benestante di pastai accoglie un orfanello che impara rapidamente il mestiere e sposa la figlia del suo benefattore (Peppe u Fissa). Non ci sono solo sofferenze nei racconti di Luccio, soprattutto negli ultimi apparsi nella rivista La Kahena dal 1935 al 1938. Ci sono i momenti di festa («Vers 9 heures, les pianos mécaniques sortirent de chez le loueur et s’égrenèrent dans le quartier; le patio des Miccicchè étant de tous les environs le plus vaste et le mieux dallé, c’est chez eux que depuis plusieurs années, quand il faisait beau le samedi soir, la jeunesse se réunissait pour valser», Une Vendetta, p. 13). Ci sono anche i sogni come quello di Luciano Amato assolutamente intenzionato a far studiare il figlio maggiore e a questo obiettivo piega tutta la sua vita e quella della famiglia (Paolo, fils de Luciano Amato). C’è Leonida Baffi, professore di musica come il padre garibaldino, che condanna le figlie a noiose e interminabili lezioni di pianoforte nella vana speranza di farne delle virtuose (Le triste destin de Leonida Baffi, in La Kahena, maggio–giugno 1938).
Tutto un mondo di uomini e donne con le loro tribù di bambini viene messo in scena senza compiacimenti pittoreschi ma con tratti precisi e delicati. Accanto alla descrizione fotografica della quotidianità, sono abilmente messe in risalto le sfumature psicologiche che danno forza al carattere dei personaggi. Da Donna Sarina, disperata per le scelte incongrue del marito ma a lui sottomessa (Paolo, fils de Luciano Amato) ai bambini discoli di don Totò che risolvono alla loro maniera una delicata questione di vicinato (La Blanchisserie du Bonheur), dal vecchio e rassegnato don Michele beffato dalla vita per l’ennesima volta (La dernière farce) alla giovane Filomena che si vendica astutamente di un poliziotto troppo zelante (Une Vendetta), da Clorinda, sposa ossessionata dal tradimento del marito (L’Opera di li Pupi) al giovane Nardo, angosciato dai sintomi di una misteriosa malattia (La malaria de Nardo): sfilano davanti ai nostri occhi uomini e donne con le loro tribolazioni e le loro lotte quotidiane. Nonostante l’umiltà con cui Luccio si pone, la sua opera rimane fondamentale nel contesto della letteratura italo–tunisina, non solo per la piacevole lettura, ma proprio perché riesce a dare spessore ad uno spaccato di vita reale altrimenti destinato all’oblio.
E’ tuttora viva la speranza che l’opera omnia di questo autore, i cui racconti sono ancora in parte sparpagliati fra le numerose riviste culturali tunisine degli anni Trenta, possa essere raccolta e pubblicata, oltre che tradotta in italiano.
Marinette Pendola
Non sappiamo dove andiamo, ma possiamo scoprire da dove veniamo
L’Unione Europea ha proclamato il 2008 “Anno dell’interculturalità” e sono state realizzate molte iniziative per promuovere un atteggiamento di maggiore apertura mentale nei confronti del cosiddetto “diverso”.
Il fenomeno dell’interculturalità, in effetti, nasce da un fenomeno ben più antico che è quello dell’emigrazione. Se riflettiamo, ci rendiamo conto che nel Mediterraneo si è sempre fatta intercultura sin dai tempi dei greci, sin da quando i flussi emigratori coinvolgevano paesi diversi e terre lontane. Il popolo italiano, come altri del bacino mediterraneo, è un popolo di emigranti e, ancora oggi avviene che le nostre “menti” migliori emigrino verso paesi che offrono condizioni e mezzi migliori per poter realizzare i loro progetti.
La nostra emigrazione ha raggiunto dimensioni enormi verso la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento ed ha coinvolto tutta la penisola, dal nord al sud. Bisogna, infatti, sfatare il luogo comune che vede come stereotipo l’emigrante meridionale: non è affatto così. Ci fu un periodo in cui la percentuale degli emigranti di origine veneta, ad esempio, era ben più alta di quella degli emigranti di origine meridionale. Ma di fronte alle difficoltà e alla solitudine tutto questo passava in secondo ordine; l’importante era cercare fortuna e, soprattutto, trovare “l’America”, concetto molto più vasto e complesso di quello legato solo al danaro. In realtà, ciò voleva dire trovare un’opportunità di vita migliore, riuscire a realizzare sogni ed ambizioni e aver riconosciuto rispetto e dignità.
Purtroppo non era sempre così. In America, ad esempio, dopo l’umiliante “selezione” tra coloro i quali godevano di buona salute e coloro i quali erano di salute cagionevole, e la prevista “quarantena”, si iniziava una vita che prevedeva lavori umili ed alloggi a dir poco indecenti. La strada della “riuscita” fu lunga e dolorosa e non tutti ce la fecero. Molti tra coloro che non trovarono fortuna, non tornarono più a casa, e di alcuni non se ne seppe più nulla. Tutto, tranne il fallimento e la disillusione, probabilmente pensavano quegli immigranti italiani appena arrivati e “parcheggiati” a bordo del piroscafo sotto l’ombra falsamente accogliente della Statua della Libertà, col timore di essere rispediti al proprio paese d’origine come “indesiderati”. Tutto, tranne la resa, e così arrivavano perfino a gettarsi nelle acque gelide davanti a Manatthan per lasciarsi morire e non dover ritornare.
Triste è la storia degli emigranti italiani ma, in tutta coscienza, possiamo affermare con certezza che quella dei nostri immigrati sia diversa? La memoria storica serve e ci aiuta ad essere migliori. Non dimentichiamolo. E proprio per non dimenticare, l’associazione culturale Vivarium ha voluto rappresentare in teatro questo fenomeno, sottolineando soprattutto ciò che l’emigrazione implica per coloro i quali, ieri come oggi, sono costretti a lasciare la propria terra per affrontare l’ignoto. La sera del 12 luglio 2008 a Pentadattilo si è realizzato un piccolo miracolo. La platea, silenziosa ed attenta, ha “vissuto”, in maniera corale, l’emozione e la fatica di quegli uomini che rappresentano il nostro passato ma anche il nostro presente. La musica, le immagini, le danze e le voci hanno dato corpo a quel fenomeno che solitamente viene presentato in conferenze ed interviste. Tutto è apparso straordinariamente vero. Questo era l’intento dell’associazione: riflettere e rendersi conto che tutto ciò è talmente vicino a noi da indurci a ricordare come eravamo, a pensare che la storia si ripete e, quindi, alla necessità di essere più aperti e rispettosi nei confronti dei nuovi emigranti.
La strada dell’integrazione e dell’interculturalità è lunga e difficile. Cosa fare? La conoscenza e il rispetto della diversità deve essere la strada maestra, perché solo con il rispetto reciproco di usi e costumi diversi, al di dentro del sistema di leggi del paese ospitante, è possibile una pacifica convivenza e si può giungere ad un autentico stato di diritto dove la democrazia, quella vera, ha come obiettivo finale l’uomo.
Rosaria Mazza
Migrazioni Mediterranee: tra diplomazia, religione e arte
La Calabria è figlia prediletta del Mediterraneo. Dalle sue coste sono partiti e ri–approdati santi, condottieri, intellettuali, artisti. Senza timore, senza paura, ma con il cuore ricco di speranza. Perché il Mediterraneo è mare che non tradisce e non inganna. E’ colmo di migrazioni. Tre fra tutti.
Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, monaco, statista, intellettuale, nato a Squillace tra il 485 e il 490 e morto nel suo paese natale intorno al 583, attraversò il Mediterraneo per motivi di riconciliazione e di pace. «Modello di incontro culturale e di dialogo» lo ha definito Benedetto XVI nell’Udienza Generale del 12 marzo 2008. Da poco nell’Arcidiocesi di Catanzaro–Squillace si è aperta, per volere di Mons. Antonio Ciliberti, l’istruttoria diocesana De cultu recognoscendo per verificare se esistano gli elementi per elevarlo agli onori degli altari. Dalla terra di Calabria si recò a Costantinopoli. Era il 551 e la guerra gotica–bizantina per il dominio del suolo italico si faceva sempre più cruente. Eccellente diplomatico della corte gota, Cassiodoro volle incontrare di persona l’imperatore Giustiniano e la moglie Teodora per convincerli a deporre le armi. La storia andò poi diversamente. Cassiodoro decise di ritirarsi a vita privata, di tornare nella sua Squillace e condurre vita monastica.
Prodigioso poi è il passaggio di Francesco, il monachello di Paola, sullo Stretto che unisce la Calabria e la Sicilia. La storia vuole che Francesco, sprovvisto di denaro, avesse chiesto ad un certo Pietro Coloso, padrone di una barca carica di legname che stava per fare vela su Messina, di far salire lui e due suoi confratelli sull’imbarcazione. Il rifiuto fu netto: «Se non avete denaro da pagarmi io non ho barca da portarvi». Il santo non si scompose. Benedisse il mare, vi distese il mantello e issando il lembo superiore sul bastone, a mo’ di vela, vi salì sopra, riuscendo ad attraversare lo Stretto. Così il Mediterraneo è stato al centro di uno dei miracoli più sorprendenti di Francesco da Paola, che gli valsero la fama di taumaturgo e, una volta proclamato Santo, il titolo di “Patrono dei marinai”. Le acque del Mediterraneo quindi come un secondo lago Tiberiade, sulle acque del quale aveva, una quindicina di secoli prima, camminato il Divino Maestro, andando, così, incontro ai suoi apostoli.
Il Mediterraneo non solo luogo per sedare conflitti o strumento di azione divina salvifica, ma anche custode di arte e cultura.
Molti artisti tra le sue acque hanno trovato rifugio per cercare fortuna in terre non distanti dalle nostre. Uno per tutti Mattia Preti (1613–1699), il Cavaliere Calabrese come è stato soprannominato. Quella di Mattia Preti è la storia di un pittore che in Calabria non riusciva a trovare consenso intorno alla sua arte. Visse tra Napoli e Roma, finché, creato “Cavaliere di Grazia” dell’Ordine Gerosolimitano di Malta, non decise nel 1661 di recarsi a La Valletta, proprio sulla piccola isola mediterranea. Ma la nostalgia tra il 1672 e il 1674 lo spinse nuovamente a Taverna. Il tempo di regalare qualche tela alla sua città e capire che in Calabria non ci sarebbe stato posto per la sua arte. A malincuore ripartì per la “sua” Malta, dove anni prima gli si erano aperte le porte dell’Europa e dove aveva trovato fortuna. Non farà più ritorno nella sua terra. Le sue spoglie mortali sono ancora oggi custodite in terra maltese. Bagnate da quel mare, quello stesso mare, che si infrange sulle spiagge lunghe e bianche della Calabria. Nostro vanto e nostra ricchezza.
Luigi Mariano Guzzo
[1] Questo contributo è stato pubblicato in forma ridotta nella brochure del 2008.
[2] Il testo è stato pubblicato in forma abbreviata nel 2008 per esigenze tipografiche.