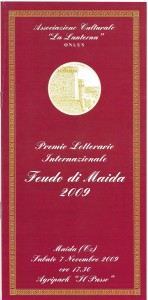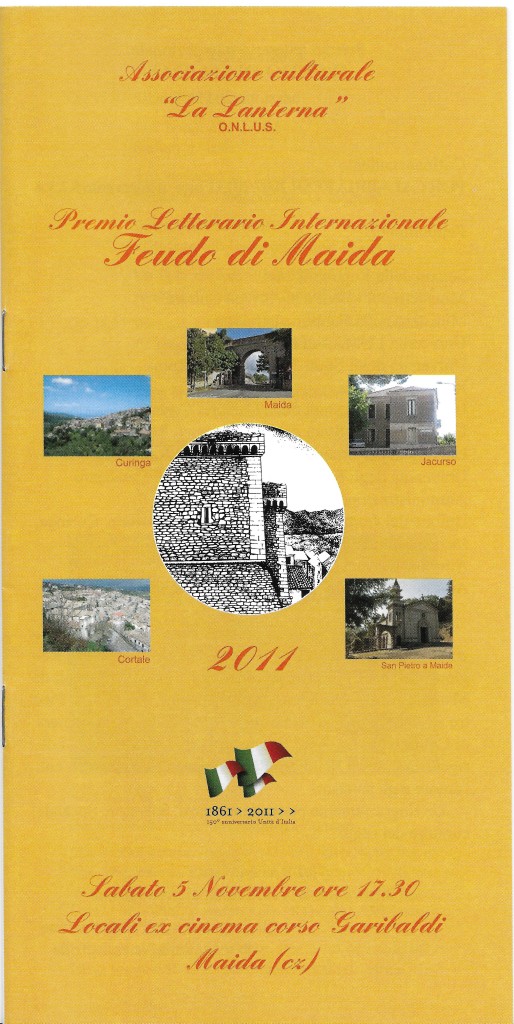Anno 2009
Specchio della storia: le migrazioni mediterranee da sud a nord
Il mondo in casa nostra: 103 nazioni e 191 lingue
Vederli per le vie, la mattina presto in attesa di essere caricati nei furgoni dai caporali, incontrarli agli incroci a mezzogiorno intenti a vendere solite mercanzie, guardarli camminare a braccetto di un anziano in un pomeriggio di sole, osservarli fin’anche la domenica sera dentro bazar illuminati da lanterne rosse, incrociarli a sera tarda, in luoghi isolati, in attesa di vendere il proprio corpo, imbattersene anche di notte ad un distributore di benzina, leggerli quotidianamente nelle pagine della cronaca nera, tutto ciò dà una vaga idea della presenza capillare, multietnica, multireligiosa degli immigrati in piccoli centri ed in grandi città d’Italia e della Calabria.
Basta la definizione “immigrati”, o “extracomunitari” per rendere la complessità e la diversità che Maida come tutti i comuni d’Italia, che la provincia di Catanzaro come le altre della regione, testimoniano ogni giorno? Semplificare significa appiattire i mille e mille “io” che ogni mattino si affacciano sulle nostre strade, in un generico “loro”, macchiato di un colore cupo e inquietante.
Contro quest’ottica azzerante bisogna ricordare che in Italia vivono immigrati provenienti da ben 103 nazioni diverse e parlanti ben 191 lingue. Certo, molti di loro sono extracomunitari: statunitensi, canadesi, marocchini, albanesi…; molti però provengono dall’UE: rumeni, polacchi, lituani, sloveni… Solo che prima di dare dell’“extracomunitario” al compagno di scuola canadese ci si pensa due volte, cosa che non avviene con il compagno rumeno. Il senso della parola si è trasformato diventando il simbolo di una barriera più dura da infrangere dei veri confini.
Chi e quanti sono allora gli immigrati? Una loro fotografia è fornita dai dati ufficiali dell’ISTAT, della Caritas Migrantes e del Ministero dell’Interno che comprendono: provenienza, dislocazione, età, sesso, religione e status. Purtroppo, essi si riferiscono solo agli immigrati residenti o già cittadini italiani ed escludono tutti i clandestini che cercano di vivere nel nostro paese.
Leggendo quelle statistiche si capisce che quel 6% circa d’immigrati rispetto alla popolazione totale ha senso solo se si fanno degli importanti distinguo. In Calabria, ad esempio, la percentuale d’immigrati ufficialmente registrati è intorno al 3%, ben più bassa di quella nazionale. Inoltre, mentre le presenze maggiori nel paese sono date da rumeni (15%), marocchini (11%) e albanesi (11%), le presenze più rilevanti in Calabria sono date da marocchini (25%), ucraini (13%) e albanesi (7%).
Nella provincia di Catanzaro, la situazione è diversa da quella delle altre province. Qui le comunità maggiori in ordine decrescente sono: marocchina, ucraina, polacca, rumena, senegalese, cinese e albanese. Ufficialmente sono meno di 10.000, ma il loro numero, si sa, è molto superiore. Di tutta la provincia gli immigrati prediligono il Lametino dove vivono più immigrati che nel capoluogo. Dopo Lamezia Terme e Catanzaro la loro presenza, in ordine decrescente, è registrata a: Gizzeria, Falerna, Sellia Marina, Soverato, Davoli, Botricello, Guardavalle, Montepaone, Maida e S. Pietro a Maida. Segno evidente che essi si distribuiscono dove il mercato del lavoro lo richiede, la fatica è maggiore e il guadagno è scarso.
«Tutto il mondo è paese», si dice, ma è bene aggiungere che ogni paese è un mondo a parte che racchiude un mondo intero. Ci si augura che i contributi che seguono aiutino a comprenderlo.
Salvatore Speziale
Immigrazione e Cittadinanza[1]
Facendo nostra l’affermazione di Cicerone in merito alla cittadinanza romana: «Universus hic mundus una civitas est communis deorum atque hominum estimanda» (questo mondo deve essere considerato come un’unica città comune agli dei e agli uomini), riteniamo che l’Unione Europea e quindi l’Italia la debbano assumere come principio nella gestione del problema “immigrazione”.
La rivoluzione dell’informazione e della comunicazione mette in contatto civiltà e culture “altre”, in un processo vorticoso che provoca scompensi e pregiudizi sul piano dei valori e dell’identità quando non si è sostenuti da una reale conoscenza dell’“Altro”. Da qui è facile che questo incontro–scontro di civiltà e culture si trasformi nel clash of civilisations, previsto da S. Huntington che si riferisce in primis alla situazione odierna della regione euro–mediterranea dove flussi migratori dal sud al nord hanno rimpiazzato le tradizionali correnti migratorie europee.
Il pianeta terra è divenuto il “villaggio globale” dove però democrazia rappresentativa, stato–nazione e cittadinanza sono in crisi. S’impone una rimessa in questione di questi concetti verso nuove visioni dell’uomo, considerato nella sua dimensione locale e planetaria.
Oggi si parla di una nova civitas per la costruzione della “Città dell’Uomo” a dimensione universale, un nuovo essere del cittadino che deve “pensare globalmente ed agire localmente” secondo un progetto di educazione politica che contempli una palingenesi dei nostri criteri democratici in crisi. «Ai nostri giorni – scrive H. Cox in La città secolare – la metropoli secolare costituisce, a un tempo, il modello della nostra convivenza e il simbolo della nostra concezione del mondo… Il mondo è divenuto compito e responsabilità dell’uomo: l’uomo contemporaneo è divenuto il cosmopolita, il mondo è divenuto la sua città e la sua città si è estesa fino a includere il mondo». Ecco perché è necessario rifondare il concetto di cittadinanza a misura planetaria, traducendolo nella prospettiva della piena humanitas dell’uomo nella grande comunità umana, evidenziato già nel 1967 nell’Enciclica Populorum progressio dove si prospetta lo “sviluppo umano integrale”.
S’impone perciò l’educazione alla cittadinanza responsabile come educazione finalizzata allo sviluppo della democrazia partecipativa, poiché costruire “la città dell’uomo” significa appunto partecipare alla vita della comunità intesa come luogo comune dei diritti e dei doveri garantiti a tutti e accettati liberamente e consapevolmente da tutti, dove ogni individuo, nel suo percorso formativo, ha il diritto–dovere di acquisire competenze sociali, relazionali e civiche. Emergono quindi nuove istanze di gestione delle diversità etnico–culturali, soprattutto nelle nostre società europee, divenute ormai multiculturali e multietniche. L’Europa deve aprirsi verso l’accoglienza solidale degli immigrati nella costruzione di nuove realtà sociali e politiche.
All’Europa e al Mediterraneo, antichi luoghi di scambi con l’Altro, tocca in particolare “inventare” nuove formule di convivenza, proporre modelli di interculturalità in grado di garantire una maggior armonizzazione della diversità culturale e una maggior giustizia e pace sociale, imparando e insegnando a costruire il rapporto con l’alterità. Nel saggio Razza e Cultura, Claude Lévy–Strauss afferma che ogni progresso umano è un coacervo di forze diverse che cercano una sintesi, mantenendo tuttavia le proprie diversità nell’apertura verso le altre culture. C’è quindi una domanda di fondo che tutti dovremmo porci: vogliamo noi offrire un futuro comune agli immigrati per costruirlo insieme in un’Italia multiculturale e multietnica, in marcia verso l’unità europea ed aperta al mondo? L’Italia del terzo millennio, terra d’immigrazione crescente, deve darsi politiche d’accoglienza e d’inserimento tali che i suoi cittadini immigrati si possano sentire parte viva della nuova comunità liberamente acquisita, consapevoli e responsabili dei diritti e dei doveri che la cittadinanza italiana, ispirata ai valori della Costituzione, richiede indistintamente a tutti i suoi abitanti nel quadro più ampio della costruenda cittadinanza europea.
Michele Brondino
Immigrati e sicurezza[2]
L’immigrazione, prima di essere un problema, è un dato. Che ha le sue conseguenze positive: su una demografia pericolosamente squilibrata, sul mercato del lavoro (svolgendo lavori di cui c’è richiesta, sostenendo con i contributi il pagamento delle nostre pensioni e badando ai nostri vecchi che le percepiscono), sul prodotto interno lordo. E ha i suoi costi: culturali e sociali. Pagati dagli immigrati, in termini di sfruttamento, di difficoltà di inserimento, a volte di discriminazione e razzismo. E pagati dalla società: in termini di danni oggettivi (aumento dei reati, nuovi bisogni da soddisfare, o meglio vecchi bisogni di persone nuove), di paure soggettive, di trasformazioni sociali e di mentalità, che sono anch’esse difficili e costose. Costi che si traducono in conflitti e incomprensioni. Spesso transitorie, peraltro, e già vissute all’inverso ai tempi della nostra emigrazione: ma accorgersene presuppone una capacità di distanza critica che non appartiene all’emotività del presente.
L’immigrazione ha i suoi costi, dicevamo. Ma qualcuno ci guadagna. Gli immigrati che ce la fanno. Coloro che beneficiano del loro lavoro. Quelli che li sfruttano, speculando sul loro bisogno di casa o lavoro, o comprandone il corpo. E quelli che lucrano sulle paure che inducono. Tra questi, gli imprenditori politici della paura. Che, non a caso, sotto elezioni alzano la voce e moltiplicano le iniziative “esemplari”, tra ronde e delazioni. Il pacchetto sicurezza da poco approvato ne è la manifestazione più evidente, da offrire in pasto ad un elettorato ossessionato dalla sicurezza, ad opera degli stessi che poi gli offrono risposte pronte all’uso: inefficaci – ma che importa – ma facilmente spendibili ed incassabili come rendita elettorale immediata.
Il travestimento “culturale” di questo coacervo di barbarie legislativa è quanto meno concettualmente zoppicante: come quel «sì alla società multirazziale, no alla società multietnica» invocato da molti. Che, tradotto, vuol dire: pazienza se l’immigrato è negro o cinese – in ogni caso, purtroppo, non possiamo farci niente. L’importante è che non pretenda di essere alcunché che non sia culturalmente omologato; omologato a chi, visto che anche gli autoctoni sono tra loro molto diversi, è un problema ulteriore.
Tra le tante norme discutibili prodotte di recente, spicca quella sul respingimento degli immigrati. Problema annoso. Che improvvisamente, sotto elezioni, diventa merce da mettere in pasto ai cittadini opportunamente impauriti dagli stessi che poi offrono facili e illusorie soluzioni, travestite da sano pragmatismo.
L’immigrazione clandestina è un problema oggettivamente grave e non facilmente risolvibile. In Italia la percentuale di clandestini è più alta perché è più facile vivere clandestinamente, grazie al peso maggiore dell’economia in nero. Il primo problema è lì: e precede l’immigrazione, non la segue. Troppo facile, anche se elettoralmente comodo, scaricarlo sull’ultimo anello della catena.
Detto questo, c’è un evidente problema pratico. Che fare dei clandestini? Lasciarli sbarcare, si dice, non si può più. Dietro di loro c’è del resto un ignobile traffico, che è giusto voler stroncare, alla pari del traffico di droga e di armi. Qualcosa, quindi, bisogna fare. Ma siamo sicuri che l’unico modo per risolvere il problema sia il respingimento al limite delle acque territoriali? Cominciare dalla fine non è per nulla il metodo migliore. E ha delle conseguenze su di noi, prima ancora che sugli altri. Ci cambia, ci sporca, prima ancora di fermare loro. Dobbiamo costringerci a comprendere che bisogna fare un ulteriore passo in avanti, ed andarci ad occupare di quei paesi e di quei problemi. La soluzione del problema non sta nella chiusura, delle frontiere e delle coscienze, ma in una loro maggiore apertura: solo, in altro modo.
L’alternativa? Prepararci a mettere altri sacchi di sabbia alla porta, e a predisporre i nostri fucili, rimpinguando nel frattempo le nostre scorte. Non l’arrivo dei barbari, ma il nostro imbarbarimento, è già cominciato.
Stefano Allievi
Immigrati di seconda generazione: integrazione dei giovani e responsabilità degli adulti[3]
Degli immigrati in Italia si parla molto, più o meno con criterio, ma in maniera indifferenziata, per lo più, senza le necessarie distinzioni di età e di sesso, che pongono problematiche diverse. Sarebbe il caso di soffermarsi ad osservare, ad esempio, chi siano veramente quegli adolescenti che giungono nei Centri Territoriali Permanenti, scuole rivolte a studenti fuori dall’obbligo scolastico, per chiedere di conseguire la licenza media. Immigrati di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia, provengono da esperienze di ripetuti fallimenti nella scuola ordinaria, nella quale gli ostacoli maggiori, ascoltando le loro storie, pare non derivino dalle possibili difficoltà linguistiche, che chi cresce e studia in una stessa comunità di parlanti riesce facilmente a superare, ma principalmente da tre fattori il cui livello di adeguamento determina il loro destino scolastico e non solo: la condizione socio culturale della famiglia d’origine, il livello di integrazione di questa nel nostro paese, l’accoglienza del gruppo dei pari.
Sebbene siano tanti gli immigrati seriamente preoccupati dell’istruzione dei figli, che riescono a seguire anche affidandoli ad insegnanti privati, tuttavia essi costituiscono solo una nicchia. Spesso in possesso di titoli di studi superiori, questi genitori sognano per i loro ragazzi una carriera scolastica e quindi professionale di successo, che possa conseguire quel riscatto sociale cui l’orgoglio ferito di immigrati “qualificati” ambisce più di ogni cosa.
Ma i ragazzi che giungono ai CTP non provengono da questi contesti; la maggior parte di loro, cinesi e bengalesi, arabi e indiani, ritrova tra le mura di casa un ambiente povero di stimoli nonché di quella attenzione famigliare che il più delle volte sa determinare l’applicazione e l’impegno nel giovane allievo. Arrivano con profonde ferite e qualche complesso dovuto in particolare a quella zona d’ombra, di confine, nella quale sentono di vivere, sbattuti tra due mondi che in ogni caso non riconoscono come del tutto propri. Per loro, difatti, il bilinguismo, la convivenza in se stessi di due universi culturali non riesce ad essere, come dovrebbe, una potenzialità, un punto di forza, un arricchimento sul piano umano ed intellettuale, bensì un ostacolo alla definizione di una identità. Così che la capacità di parlare più lingue non è veramente tale, giacché conoscono della lingua dei genitori solo il lessico familiare, molti di loro solo nella comprensione orale. Mentre i padri e le madri, specie cinesi, nonostante la permanenza nel nostro paese, non conoscono l’Italiano e usano i figli come le sole vie d’accesso alla decodificazione di un realtà esterna che in gran parte non accettano. Se poi è vero che, attraversando le ribellioni adolescenziali, questi ragazzi rifiutano provocatoriamente di parlare la lingua paterna, cambiano i loro nomi esotici con nomi italiani d’invenzione, si tingono i capelli e ricalcano visibilmente modelli occidentali del tutto sconosciuti in casa, come si comunicherà all’interno di queste famiglie? Cosa si diranno genitori e figli? E come? A questo, infine, si aggiunge l’abisso che li separa nella definizione del loro futuro; l’ansia del conservatorismo degli immigrati che vorrebbero trattenere i loro figli il più possibile sotto la sfera d’influenza di una tradizione che vedono dissolversi, senza essere abbastanza competenti e credibili per farlo, e il desiderio di chi in un’età delicata desidera omologarsi al gruppo soprattutto quando apparentemente meglio rappresentato e convincente. Ma non è solo la crisi dell’età, spesso ci si mettono anche diversi diffusi estremismi da parte degli adulti quando si tratta della vita affettiva e relazionale dei figli.
Quello dei matrimoni combinati e spesso tra parenti è prassi diffusa tra indiani e pakistani, bengalesi e cinesi, islamici ed indù, con serie ripercussioni nel rapporto con i figli, cui viene in molti casi proibito di partecipare alle feste di compleanno dei compagni di scuola o di frequentare liberamente amici ed amiche italiani. Certo fra le tante cicatrici che questi adolescenti si portano addosso c’è senz’altro anche quella procurata dalla brutalità di qualche coetaneo italiano insensato, da cui saranno stati canzonati, provocati, anche malmenati. Ma sebbene questo resti una triste costante tra giovani, arginabile tramite l’educazione e l’informazione, per altri versi è tipica di un’età evolutiva nella quale l’apparentamento coi pari troverà sempre qualche ostacolo, anche quando non si hanno genitori stranieri; dovrà farsi piuttosto premura delle madri, che in questi contesti di transizione sono punti di sutura insostituibili, comprendere come il miglior aiuto da offrire alla realizzazione innanzitutto esistenziale dei figli, sia la loro personale prioritaria integrazione.
Davide Vespier
L’immigrazione dal sud al nord
Bisogna premettere che la migrazione in seno ai popoli è un fenomeno antico: sempre hanno avuto luogo nuovi insediamenti di gruppi etnici in cerca di esperienze varie o sospinti da motivazioni ambientali.
Anche oggi risulta in aumento l’immigrazione, dal sud, in particolare dall’Africa, verso l’Europa in vista di condizioni migliori di vita.
I barconi si sono susseguiti nel Mediterraneo dall’Albania e dalla Tunisia e tuttora si susseguono in partenza dalle coste libiche: molti sono approdati a Lampedusa.
Con la nuova legge si adottano – in verità in modo indiscriminato – i respingimenti; tuttavia i tentativi non mancano di poter toccare terre accoglienti in quanto la vita di somali, di eritrei e di altre popolazioni in patria è resa impossibile per l’estrema miseria o per i governi autoritari e liberticidi.
In Europa vige la “tolleranza zero” e in certa misura anche in Italia, verso i “diversi”, verso questi immigrati. Si dimentica che anche l’Italia è stata un popolo di emigranti.
Recentemente ha suscitato panico la tragedia dei 73 uomini, tra eritrei e somali, finiti in mare per mancanza di soccorso, nonostante le invocazioni di aiuto. Così è come procurare la morte all’uomo, all’umanità. La Chiesa, alla luce del Vangelo, reclama il rispetto del diritto di questi “disperati che cercano asilo” ad essere accolti, valutando in seguito da parte dei Responsabili la loro situazione. È risaputo che il Vangelo esiga l’amore verso il prossimo, specialmente se ha bisogno di aiuto. Ogni persona è stata creata ad immagine di Dio e secondo il filosofo Rosmini «è diritto umano sussistente». Non può mancare in chi governa la responsabilità ma neanche può mancare la solidarietà.
Vincenzo Rimedio
Le catene dell’indifferenza
Il 29 giugno 2009 si è concluso l’anno Paolino, tempo dedicato a Paolo di Tarso che tutto il mondo riconosce come il primo e più eccezionale esempio di emigrante.
Uomo colto, cittadino romano, profondamente legato al suo mondo ebraico ma cresciuto anche a contatto della cultura greca, percorre migliaia di chilometri di strade che collegano i più distanti punti dell’Europa continentale all’Africa del nord e al Medioriente.
Con la fermezza che solo un profondo convincimento può dare, egli continua a “viaggiare” affrontando difficoltà ed avversità. Fu persino naufrago e, pensate un po’, fu proprio Malta ad accoglierlo ed aiutarlo a proseguire il suo “cammino”.
A chiunque, oggi, indipendentemente dalla propria fede religiosa, appare quasi stridente ricordare questi eventi in un momento storico in cui l’emigrante è visto quasi come un “nemico”. Proprio in questi giorni la possente voce dell’ONU in persona di Navi Pillay, Alto Commissario per i diritti umani, si alza al di sopra di beghe burocratiche e di rimbalzi di responsabilità tra le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo che tentano di nascondere la verità: l’immigrazione è una realtà ineluttabile e, per alcuni, scomoda.
L’ONU denuncia i respingimenti e le discriminazioni nei confronti degli immigrati; barche cariche di esseri umani vengono lasciati ad affrontare pericoli e morte come se fossero cariche di “rifiuti pericolosi”. Il diritto internazionale viene violato ma ancor più vengono violati i principi fondamentali dell’etica umana, il rispetto della vita e della dignità, che per molti e per molto tempo, hanno rappresentato lo scopo di una vita dedicata alla lotta all’uguaglianza e alla libertà.
Gli immigranti che giungono in terra italiana, o europea in genere, sono prigionieri; sì prigionieri della loro disperazione e della loro condizione di povertà o di perseguitati. In virtù di ciò l’atteggiamento delle autorità, ma prima ancora del semplice cittadino, deve essere di accoglienza. Certamente ogni comportamento illecito deve essere giustamente giudicato, ma prima di tutto viene l’uomo.
Se non teniamo conto di ciò, come potremmo alzare lo sguardo verso le acque del mare, senza pensare che possa diventare il baratro dove sprofonda ogni speranza di vita di migliaia di esseri umani?
Forse non tutti sanno che sorge, in terra di Lampedusa, un monumento dedicato ai migranti che hanno perso la vita in mare. Si tratta di una porta di ceramica realizzata da Mimmo Paladino, alta cinque metri e larga tre e vi sono rappresentati volti, mani, scodelle, pesci. E’ un doveroso riconoscimento dovuto alle loro sofferenze e il suo significato è consegnare alla memoria quest’ultimo ventennio che ha visto migliaia di migranti morire in mare in modo disumano nel tentativo di raggiungere l’Europa. Le cifre sono impressionanti: dal 1988 ad oggi[4] sono morte più 12.000 persone di cui più di 4.000 dispersi lungo le frontiere europee (Osservatorio sulle vittime dell’immigrazione).
Tutto ciò deve farci riflettere: il fenomeno della migrazione fa parte della nostra vita e tutti dobbiamo affrontarlo, ognuno per ciò che gli compete. Le autorità regolamentino e il cittadino accolga. L’Italia è un paese aperto ed ospitale che, nel corso degli anni, ha dato dimostrazione di grande civiltà (non dimentichiamo che la Puglia fu candidata al Premio Nobel della pace per l’esempio di alta civiltà nel periodo della grande emigrazione albanese).
L’Europa quella vera, civile e non solo politica, la costruiamo tutti noi, passo dopo passo, assumendoci la responsabilità di “Cittadino Europeo” perché questo è l’obiettivo che ci può assicurare un futuro democratico e libero.
Rosaria Mazza
Reggio Calabria: il sud che accoglie il sud
Il fenomeno migratorio che coinvolge uomini, donne e bambini provenienti da ogni parte del mondo, si configura oggi, essendo aumentato il divario tra nord e sud del mondo, come un flusso spontaneo da un sud sempre più povero, i cui confini si allargano progressivamente, e un nord opulento, le cui coordinate geografiche non sono più chiaramente definibili.
Un esempio di ciò è rappresentato da Reggio Calabria, città che ha ospitato, inizialmente in modo inconsapevole, una comunità islamica il cui nucleo iniziale proveniva dal Marocco (costituito essenzialmente da uomini) in cerca di lavoro e che, man mano radicatosi nel territorio, ha costituito una comunità che ha voluto invece consapevolmente costruire una propria storia in questa città. Infatti, grazie ai ricongiungimenti familiari, a Reggio è nato il Centro Culturale Islamico più grande della Calabria.
Oggi la comunità è composta da individui provenienti dal Nordafrica, principalmente dal Marocco. La città di Reggio rappresenta uno dei primi insediamenti di immigrati dove sono ormai presenti nuclei familiari di terza generazione. Tuttavia, nonostante l’elevata presenza numerica, la comunità islamica non ha sviluppato dei rapporti stabili con la società e le sue istituzioni. Gli immigrati vedono la città come un punto d’ingresso verso un nord più ricco ed organizzato, dove spesso sono attesi da parenti già inseriti nel mondo del lavoro. I luoghi d’incontro sono abitazioni private, la macelleria islamica, il Centro Culturale (al cui interno è stata ricavata una moschea), luoghi in cui gli immigrati tendono a perpetuare le abitudini e le tradizioni delle loro terre e della loro religione. Ma se questo è un dato importante, ancora di più lo è il fatto che con il tempo e con la convivenza quasi nessuno fra loro considera l’Italia, e dunque anche Reggio, un territorio ostile nei confronti della religione musulmana.
Dall’altro lato, la popolazione reggina non guarda gli immigrati musulmani con sospetto, anzi è mossa da sentimenti benevoli e da atteggiamenti mirati ad approfondire la conoscenza di una religione “altra”. Tuttavia, sono attestabili soltanto pochi casi di conversione all’islam. Questo succede perché il fenomeno migratorio non è più concepito come un qualcosa di temporaneo ed eccezionale, ma un cambiamento di vita radicale attraverso il quale non si perde la propria identità ma la si integra e la si completa dandole una connotazione e una giustificazione nel territorio in cui ci si ritrova a vivere.
Sempre di meno si considera che sia possibile l’applicazione integrale del diritto islamico in Italia, ma giustamente si chiede insistentemente che le legislazioni internazionali tengano conto delle esigenze giuridico–religiose delle comunità musulmane. A questo proposito mi piace concludere con le parole di Muhammad, un immigrato reggino, che ha colto il senso della civile convivenza attraverso questa sua opinione «seguo il diritto italiano e la religione islamica poiché quando si è in un paese diverso dal proprio devo rispettare sia le leggi che i miei doveri islamici senza problemi».
Maddalena Di Prima
L’immigrazione, un fiore di loto nella terra di Calabria
Nelle ultime settimane dalla Libia ottanta clandestini hanno tentato il viaggio della speranza su di un piccolo gommone. Cinque di loro ce l’hanno fatta. Per gli atri 75 il destino è stato più crudele: i loro corpi sono stati gettati dai compagni nel Mediterraneo, ormai un vasto e grande cimitero senza nomi e senza croci.
Questi sono solo gli ultimi protagonisti di una tragedia silenziosa e terribile che non conosce limiti. L’emigrazione dal sud del Mondo verso i Paesi dell’Europa occidentale è un fenomeno purtroppo che ha raggiunto numeri stratosferici. Basti ricordare che nel 2009 sono già 500 le persone che hanno perso la vita nel canale di Sicilia per la disperata, straziante e angosciosa ricerca di un futuro migliore. Nel 2008 erano state 1250. Dati resi ancora più atroci dal fatto che i numeri si riferiscono anche a donne incinte e bambini. E’ una vera e propria strage degli innocenti.
L’Italia dagli anni Novanta del secolo scorso in poi, è uno dei Paesi maggiormente colpiti dal fenomeno dell’immigrazione. Terra di emigrati prima, terra di immigrati adesso.
Il nostro Paese però, pur avendo ratificato molte convenzioni internazionali e recepito le relative direttive dell’Unione Europea, non possiede ancora una normativa organica condivisa da maggioranza e opposizione. Eppure per l’Italia, aperta alla globalizzazione e agli scambi internazionali, il tema dell’immigrazione rappresenta una delle materie centrali della politica nazionale.
Il diritto d’asilo, ad esempio, è uno dei principi fondativi della Repubblica Italiana perché garantito dall’articolo 10 della nostra Carta Costituzionale. Solo nel 2008 le richieste pervenute alle commissioni territoriali per il diritto d’asilo sono state 31.097. Solo 11.849 hanno avuto esito positivo sulle 21.933 richieste esaminate.
Un ruolo importante potrebbe essere svolto anche dalle regioni che, nell’ambito della loro potestà legislativa, avrebbero la possibilità di sostenere interventi di sostegno e di protezione per i rifugiati.
L’esempio virtuoso arriva dalla Calabria. Su proposta della Giunta, il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità, lo scorso 29 maggio, una legge sull’accoglienza per promuovere l’inserimento degli immigrati nel territorio e coniugarlo allo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.
Il provvedimento trova le sue radici nella positiva esperienza della Locride, in cui i rifugiati, a partire dagli anni Novanta del Novecento, hanno ripopolato borghi quasi desertici e abbandonati.
In molte piccole contrade ai piedi dell’Aspromonte la vita è ripresa, e l’economia pure, grazie alle attività agricole e artigianali svolte dalle nuove popolazioni.
Un vento rinnovatore e carico di fiducia è iniziato a soffiare sull’intera regione, grazie all’impegno di gente che sul gommone della speranza, tra le acque del Mediterraneo, non l’ha data vinta alla morte. O meglio, dalla morte questa gente è rinata. E con essa sta rinascendo, a piccoli passi, la Calabria.
Come un variopinto fiore di loto che splendidamente spunta dalla melmosa fanghiglia!
Luigi Mariano Guzzo
Aspetti linguistici del fenomeno migratorio dalla sponda sud alla sponda nord[5]
L’ondata migratoria che dalla sponda sud del Mediterraneo, arriva in Europa presenta, pur nella diversità delle nazionalità coinvolte (tunisina, marocchina, etc.), una indubbia unità linguistico–culturale. Gli immigrati provenienti da quest’area hanno infatti come comune denominatore la lingua araba, che è non solo la lingua ufficiale (cioè la lingua dell’amministrazione, dell’istruzione e dei media) dei loro paesi ma anche la lingua della cultura di cui sono portatori. E se relativamente alla lingua parlata e della comunicazione informale si possono distinguere, a seconda della regione di provenienza, varietà diverse (arabo marocchino, arabo tunisino, etc.) o addirittura lingue diverse (il berbero, per molti marocchini, ad esempio), la lingua scritta e della comunicazione formale è fondamentalmente una: sia nello spazio, che comprende tutto il Nordafrica e i paesi arabi del Vicino Oriente; sia nel tempo, andando dalla poesia preislamica ai romanzi contemporanei e passando per tutta la produzione scientifico–letteraria dell’epoca medievale e moderna, naturalmente con tutte le evoluzioni stilistiche e lessicali che ogni lingua conosce con il passare dei secoli.
L’apprendimento di questa lingua letteraria non avviene però in maniera spontanea (non è infatti la lingua materna di nessun parlante arabo) ma necessità di studio e quindi di un insegnamento strutturato all’interno delle istituzioni scolastiche: ma chi se ne dovrà fare carico? L’istituzione del paese di accoglienza, nell’ottica di garantire il diritto a non perdere la lingua e la cultura di origine? Oppure le istituzioni dei paesi di origine con l’apertura di scuole arabe? E in che modo? Attraverso insegnamenti extra–curriculari e opzionali riservati agli alunni arabofoni? Oppure attraverso insegnamenti curriculari che offrano la possibilità anche agli alunni italiani o di altre nazionalità di imparare l’arabo così come si imparano altre lingue straniere? Il dibattito è aperto in tutta Europa, con soluzioni e proposte differenti a seconda dei paesi.
Intanto l’interesse per la lingua e la cultura araba in Europa è in continua crescita e la richiesta di corsi di arabo in Italia è notevolmente aumentata: nelle Università si sono moltiplicati gli insegnamenti di Lingua e Letteratura araba, corsi di arabo sono stati istituiti in alcune scuole secondarie, nei centri di educazione degli adulti e nelle Università della terza età oltre che in istituti di lingue pubblici e privati o presso associazioni che operano nell’ambito dell’intercultura. Ciò ha portato anche alla pubblicazione di nuovi testi e manuali per imparare l’arabo, di diverso valore e utilità pratica, ma comunque sintomo della curiosità nei confronti di questa lingua e di questa cultura.
E il desiderio di conoscenza è il primo passo sulla via dell’eliminazione del pregiudizio e della paura del diverso, in vista della costruzione di rapporti di convivenza basati sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione dell’altro.
Barbara Airò
Migranti nel Mediterraneo e rispetto della dignità umana[6]
Mediterraneo è parola che evoca antiche suggestioni storiche, ma è pure parola che incupisce il cuore dell’uomo contemporaneo, gettandolo in uno stato di angosciosa tristezza. Riporta in mente avventure di mitici naviganti, Ulisse ed Enea tra tutti, e storie di feroci pirati e temuti corsari. Nitide rimangono le gesta di Scipione Cicala, imparentato con i Principi cinquecenteschi di Tiriolo, divenuto Sinan Capudan Pascià, e del contemporaneo Giovanni Dionigi Galeni “Occhialì” di Isola Capo Rizzuto. Ed ancora: il Mediterraneo ristora la mente ed il cuore quando narra di approdi felici lungo le coste dei Paesi del Vecchio Continente; smorza il sorriso quando registra egoismo, odio, intolleranza. Lo hanno conosciuto gli apostoli Pietro e Paolo e una folta schiera di santi missionari, impegnati a portare l’amore di Cristo negli sperduti villaggi afro–asiatici. Questo è il Mediterraneo, il Mare Nostrum per i Romani, il Mare di Mezzo per gli Arabi.
In effetti, il Mediterraneo è un mare racchiuso tra tre continenti, Europa, Africa e Asia. Attraverso lo Stretto di Gibilterra ha una porta aperta sull’Atlantico; il Bosforo lo collega al Mar Nero e dall’artificiale Canale di Suez raggiunge il Mar Rosso. Culla di antiche civiltà, ha legato il suo nome al clima e alla dieta. Le due locuzioni “clima mediterraneo” e “dieta mediterranea” sono grandemente utilizzate dal linguaggio comune. Con riferimento al clima, il Mediterraneo è un ottimo serbatoio termico; in relazione alle coltivazioni, l’olio, il vino e gli agrumi vengono raccomandati per una alimentazione sana, leggera, nutriente.
Mare piccolo, ma dal cuore grande. Una riserva d’acqua dai confini talvolta labili, ma sempre molto appetibili e ricercati. Un vero scrigno di popoli e di culture non sempre in dialogo tra di loro.
Ma il Mediterraneo è altro ancora. Dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, è solcato in lungo e in largo dalle rotte della migrazione clandestina. Rimane la “porta della speranza” per migliaia di uomini, donne e bambini che dall’Africa anelano di raggiungere l’Europa. Solo 275 chilometri separano la Libia da Pantelleria ed appena 113 chilometri la Tunisia da Lampedusa.
Migliaia di migranti, dicevamo, quasi tutti irregolari e clandestini. E sono noti gli sforzi fatti per accoglierli, perché almeno a parole tra il fenomeno migratorio e la dignità della persona umana c’è un nesso inscindibile, un rapporto interdipendente. Purtroppo non sempre tale rapporto viene tenuto in debita considerazione. I riflettori mediatici si annebbiano quando il Mediterraneo assume l’aspetto dell’arcigna matrigna, che travolge, nell’impeto delle onde, indifesi migranti e la speranza che si portano dietro. Il mare, si sa, pretende di essere solcato da navi e traghetti sicuri, giammai da imbarcazioni di fortuna, che non sempre riescono a concludere il viaggio.
Quanti sono gli annegati nel Mediterraneo? Oltre ottomila dal 1988 al 2007. Sono morti nel Canale di Sicilia tra la Libia, l’Egitto, la Tunisia, Malta e l’Italia o lungo le rotte che vanno dal Marocco e dall’Algeria verso la Spagna. Anche lo specchio d’acqua dell’Adriatico ha inghiottito centinaia di disperati provenienti dall’Albania diretti in Italia. Più di quattromila salme non sono state recuperate, senza che nessuno se ne sia curato più di tanto.
Che il loro sacrificio sia di monito per tutti. E’ giunta per davvero l’ora che la coscienza dell’uomo contemporaneo cominci a riconsiderare il rapporto tra il fenomeno migratorio ed il rispetto della dignità umana!
Teobaldo Guzzo
[1] Il contributo è stato inserito in forma abbreviata nella brochure del 2009.
[2] Questo contributo è stato pubblicato nella brochure in forma piuttosto ridotta per motivi di spazio.
[3] Questo contributo è stato pubblicato nella brochure in forma piuttosto ridotta per motivi di spazio.
[4] N.d.C. Il testo si riferisce all’anno 2009.
[5] Questo contributo non è stato pubblicato nella brochure di quell’anno in quanto è giunto al curatore oltre il tempo massimo per la stampa.
[6] Anche questo contributo è giunto fuori tempo massimo per la brochure e quindi viene edito per la prima volta.
Anno 2010
L’Unificazione italiana: nuovi scenari e prospettive
L’italiano: cemento dell’unità nazionale ieri ed oggi
La lingua italiana è stata uno dei fattori aggreganti, se non il principale, che ci ha uniti soprattutto con l’avvento della Repubblica nella riconquistata libertà e democrazia rappresentativa poiché essa è al contempo memoria storica e progetto in divenire della nostra società civile. E’ questo secondo l’assunto gramsciano che la lingua contiene «gli elementi di una concezione del mondo e della cultura del popolo che la parla»: è il sistema che contiene tutti i valori, le scelte, i meccanismi, i processi che portano alla formazione di una società e quindi di una nazione. Quale collante linguistico–letterario della frantumata realtà storico–politica e socio–culturale della penisola italiana dal “300, l’italiano da lingua delle élites colte s’impone all’avvento dell’unità, tra mille difficoltà (dalle scelte manzoniane all’approccio culturale del glottologo Graziadio Ascoli, fino alla politica linguistico–culturale del II dopoguerra), quale strumento di comunicazione dell’intera popolazione. Il miracolo socio–economico dell’Italia anni Cinquanta–Sessanta s’accompagna a quello linguistico–culturale sovente sotteso al primo: l’italiano sconosciuto a oltre i due terzi degli italiani diventa la lingua della nazione grazie alla “rivoluzione” dell’alfabetizzazione delle masse popolari (cfr. De Mauro T., La cultura degli italiani, Laterza, Roma-Bari, 2004). Ricordiamo qui solo due aspetti cruciali di questo sorprendente processo: i corsi CRACIS nelle scuole serali e tra le reclute dell’esercito, e la scuola serale della televisione; valga per tutti, il corso Non è mai troppo tardi di A. Manzi.
Oggi però, di fronte ai macroprocessi della globalizzazione, anche il nostro sistema Italia è in crisi, soprattutto dopo la fine della I Repubblica con Tangentopoli (1992–93). Lo sperato avvento della II Repubblica si trascina in una lunga transizione che ha generato fermenti antiunitari di cui il leghismo è l’espressione più ottusa, cui s’affiancano manifestazioni antipolitiche e populiste. All’Italia del “pensiero e azione” si contrappone la visione riduttiva dei dialetti e culture locali, che vanno invece percepiti quali vitali affluenti del grande fiume della lingua e cultura nazionale, come affermava il filologo B. Migliorini. L’attuale critica situazione italiana dovrebbe ispirarsi all’art. 5 della Costituzione: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali». Ecco espresso lapidariamente il nostro comune progetto d’avvenire verso i valori nazionali, oggi allargatisi alla dimensione europea, nell’approfondimento stimolante delle molteplici radici delle nostre culture e parlate locali. Questo compito spetta a ognuno di noi, dal Capo dello Stato al semplice cittadino, tanto più oggi di fronte ai “nuovi italiani” dell’immigrazione. E in quest’ottica, vale sempre il monito gramsciano a proposito della lingua: «Ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la questione della lingua significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare–nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale». Processo questo quanto mai urgente nell’attuale degrado della società nazionale, vista la pochezza politica, culturale e morale dei nostri governanti.
Michele Brondino
Cavour e l’Unità nazionale
Il bicentenario della nascita di Cavour – 10 agosto 2010 – è caduto in una congiuntura in cui ricorrono le manifestazioni celebrative in vista del centocinquantesimo anniversario dell’Unità nazionale. Eppure Cavour tra Gli uomini che fecero l’Italia – per riecheggiare il titolo di un fortunato libro di Giovanni Spadolini – è forse il più misconosciuto. Non sono mancati gli studi sul grande statista, primo – in ordine di importanza – Cavour e il suo tempo, l’opus magnum di Rosario Romeo. La responsabilità dell’offuscamento dell’opera di Cavour non è nemmeno ascrivibile soltanto alle strumentalizzazioni del processo unitario che caratterizzano il dibattito pubblico e alle requisitorie – tanto veementi quanto penosamente vacue – contro i protagonisti del Risorgimento che giungono da parte leghista, dai neoborbonici e, ancora, dai nostalgici del potere temporale della Chiesa.
Certamente il degrado del dibattito pubblico contribuisce a confondere i termini della questione, in un contesto in cui si registra lo svilimento del ruolo dello storico di professione a vantaggio di una pubblicistica priva di quell’outillage metodologico indispensabile all’attività di ricerca. Forse il limite maggiore, però, è individuabile nel fatto che la storiografia – quella italiana in particolare – dagli anni Ottanta si è concentrata quasi esclusivamente sulla storia sociale e degli apparati amministrativi degli stati preunitari ed ha trascurato la storia politica.
Ciò ha lasciato spazio alla riproposizione della screditata tesi di Denis Mack Smith secondo cui l’opera di Cavour avrebbe soffocato i fermenti democratici ed avrebbe dato luogo a uno stato unitario recante in nuce quei germi di autoritarismo poi emersi compiutamente nel ventennio fascista.
Solo parzialmente gli importanti studi sulle forme organizzative del movimento risorgimentale e sugli aspetti simbolici della cultura nazional–patriottica condotti nell’ultimo quindicennio da Alberto Mario Banti, Jean–Yves Frétigné e da altri ancora, hanno costituito un argine all’interpretazione teleologica di Mack Smith, peraltro reiterata da alcuni dei suoi epigoni sino a tempi assai recenti. Come hanno rilevato Gaetano Arfè e Walter Maturi, difettava in Mack Smith quella più matura capacità di inserire gli eventi italiani nel più ampio contesto internazionale.
Al contrario Rosario Romeo, pur essendo ben consapevole delle debolezze dell’edificio unitario proprio per la materia “fortemente eterogenea” con cui era stato costruito – come ribadiva in un’intervista a Guido Pescosolido apparsa nel marzo 1985 su «Mondoperaio» e ripubblicata in volume recentissimamente dalla casa editrice Le Lettere (Cavour, il suo e il nostro tempo) –, sottolineava l’inscindibilità in Cavour di «nazione e liberalismo», mentre «il fascismo nacque da una serie di cause strettamente legate alla prima guerra mondiale» e «germinò da tronchi politico–culturali chiaramente distinti da quello liberale».
Salvatore Bottari
La Nazione oltre confine: gli italiani in Tunisia
«After the red–rose–bordered hem» (dietro lo strascico di rose rosse orlato) scrive W.B. Yeats in una poesia dedicata all’Irlanda, raffigurando la nazione come un’elegante signora amata e rispettata. È indubbio che sentimenti analoghi abbiano animato anche i combattenti per l’unità d’Italia. L’evento, in effetti, fu salutato con esultanza persino oltre confine, come nella vicina Tunisia, all’epoca provincia ottomana.
La Tunisia, in realtà, non era stata affatto estranea alle vicende del Risorgimento italiano. Nella prima metà dell’Ottocento Tunisi era conosciuta come Parigi di Barberia o Versailles islamica per l’accoglienza concessa ai profughi mazziniani, e persino a Giuseppe Garibaldi nel 1834. A Tunisi gli operosi esuli politici fondarono un comitato della Giovine Italia e, in occasione dello sbarco dei Mille in Sicilia (11 maggio 1860), organizzarono una spedizione di armi per i picciotti.
Nondimeno, paradossalmente, la Tunisia ospitava anche quanti non erano disposti a sacrificare la vita per la patria. I renitenti alla leva erano, infatti, così numerosi nella Reggenza che nel solo mese di settembre del 1863 ne furono rimpatriati una cinquantina (rapporto del console Gambarotta, Tunisi 21/09/1863).
L’Italia unificata ambiva naturalmente a occupare un alto posto di prestigio accanto alle potenze europee, un posto di prestigio che la conquista di nuovi territori avrebbe senz’altro coronato. Di fatto, appena pochi anni dopo, approfittando di una situazione di instabilità nella Reggenza (la rivolta del 1864), il governo italiano predispose una spedizione militare proprio in Tunisia. Napoleone III, infatti, non sembrava affatto contrario a un’occupazione parziale del paese – a oriente del fiume Medjerda – da parte dell’Italia, in cambio della rinuncia alla soluzione della questione romana. L’atteggiamento ostile della Gran Bretagna fece recedere dalla progettata azione il governo italiano (De Leone E., La colonizzazione dell’Africa del nord, Cedam, Padova, 1957).
La rivalità con la Francia, che occupò la Tunisia nel 1881, fu una costante nella storia della comunità italiana che si arroccò nella fiera difesa dell’italianità, un’idea ambigua che rinvia tanto agli interessi economici quanto all’identità culturale. Attraverso la creazione di istituzioni a impronta nazionale (gli istituti scolastici, la Camera di commercio e arti, i teatri, la stampa con più di cento testate, etc.), la comunità italiana mantenne una solida identità nazionale in un paese prevalentemente arabo–musulmano sottoposto alla civilisation francese.
Per quanto sia ridotta numericamente, ancora ai giorni nostri, la comunità coltiva l’appartenenza nazionale attraverso, per esempio, la celebrazione di ricorrenze quali il bicentenario della nascita di Garibaldi (2007). Nel processo di ri–appropriazione della storia non mancano però accostamenti originali all’eroe del Risorgimento (Bettino Craxi e altri politici espatriati) che difficilmente raccolgono il consenso unanime della nazione.
Daniela Melfa
Nuove e vecchie questioni sul cosiddetto “brigantaggio” nell’Italia postunitaria.
Nel quinquennio 1861–1865 nel Mezzogiorno italiano una drammatica lotta vide contrapposti l’esercito del Regno e i renitenti alla leva: contadini, miserabili e delinquenti, a volte organizzati e condotti da ex soldati borbonici o agenti pontifici. Le cause dell’insurrezione sono, com’è noto, imputabili in parte alla centenaria storia di arretratezza, miseria e ingiustizia cui furono soggette le masse contadine e il popolo minuto. Le aspettative destate dal passaggio di Garibaldi furono disilluse dal governo del nuovo Regno d’Italia; ulteriori disagi derivarono dalla promulgazione delle leggi piemontesi a tutto il territorio.
Queste leggi infrangevano secolari equilibri: la leva era del tutto sconosciuta ai siciliani; con l’introduzione del libero mercato fiorenti attività economiche non ressero alla competizione con le concorrenti del nord e l’abolizione del patrimonio ecclesiastico tolse ai lavoratori stagionali il lavoro legato alla gestione di chiese, conventi, ospedali. Queste e altre cause diedero origine alla lotta armata nell’ex Regno delle Due Sicilie, che qualcuno ha visto come una guerra civile, altri come una vera e propria rivoluzione contro uno stato invasore. Queste interpretazioni superano certamente la riduttiva definizione di “brigantaggio”, coniata da quei militari che non compresero le peculiarità del Mezzogiorno. Si tratta di studi che hanno reso dignità e giustizia a quei tanti disperati cui la storia non aveva dato un volto ma che, a volte, rivelano una scarsa contestualizzazione degli eventi. La condanna della brutale repressione include, in alcune di queste letture, la stessa scelta dell’unità italiana, che sarebbe stata attuata sulla violenza e la rapina delle popolazioni meridionali.
Si trascurano però, da questa prospettiva, i dati oggi in nostro possesso relativi al tentativo di costruzione di uno stato moderno ed efficiente nei primi decenni dell’unità italiana: i numeri relativi alla costruzione di strade, ponti, ferrovie nella sola Sicilia del 1861–76 indicano uno sforzo finanziario e organizzativo considerevole. Altri fondamentali provvedimenti furono la fondazione di camere di commercio, la costruzione o la ristrutturazione dei porti nelle principali città costiere, l’istituzione di scuole e d’istituti di assistenza, di ospedali, di una rete di poste e telegrafi efficiente, di un apparato fiscale capillare, necessario allo Stato per far fronte a tutte queste spese.
Inoltre, la fragilità della congiuntura politica interna e del quadro internazionale rendevano urgente porre rimedio all’insicurezza imperante in molte contrade meridionali.
Ribaltando l’interrogativo, cambia la prospettiva e cadono molte delle critiche mosse alla Destra storica: se i borbonici ed i pontifici avessero vinto questa guerra e raccolto i frutti della vittoria, avrebbero quei contadini diventati briganti, ottenuto le terre e quelle migliori condizioni di vita a cui aspiravano?
Forse avrebbero ricevuto lo stesso premio che ebbe l’armata sanfedista a ricompensa per la lotta alla Repubblica Napoletana del 1799: il poter tornare all’ignoranza e al sonno della ragione.
Luca Platania
Briganti e stranieri nell’Italia postunitaria
Nell’ambito della letteratura e della storia della Calabria e dell’Italia meridionale postunitaria può essere certamente interessante mettere a confronto testi di scrittori stranieri dai quali il fenomeno del brigantaggio postunitario emerge attraverso la diaristica, i memoriali, note cronistiche o altro.
Il diario di Josè Borges è fra questi uno dei più rappresentativi. Al momento della cattura del generale spagnolo, cui segue la fucilazione nel dicembre del 1861, sono rinvenuti dei taccuini, in cui Borges aveva annotato i novanta giorni della sua avventura nel Meridione d’Italia, e dai quali traspare il vano tentativo di irreggimentare la truppa del famoso brigante Carmine Crocco per portare a termine l’impresa della riconquista del trono da parte della corte borbonica. I taccuini di Borges hanno fin da subito una notevole diffusione in quanto il famoso cronista di regime, lo svizzero francese Marc Monnier, li allega alla pubblicazione del suo libro Notizie storiche documentarie sul brigantaggio nelle province napoletane dai tempi di fra Diavolo sino ai nostri giorni aggiuntovi l’intero Giornale di Borges finora inedito pubblicato in francese ed in italiano nel 1862.
L’anno successivo lo stesso Monnier da alle stampe, in entrambe le lingue, La camorra, notizie storiche e documentate, in cui definisce la camorra una seconda forma delinquenziale rispetto al brigantaggio, prevalentemente urbana, ma ugualmente pericolosa. Nei testi relativi al brigantaggio Monnier, tenta di fornire un’analisi, con metodo scientifico, delle condizioni politiche sociali dell’Italia meridionale, retta dalla convinzione della legittimità della causa italiana, senza lasciarsi pervadere da pennellate romanzate come Alexandre Dumas. Il padre dei tre moschettieri, infatti, alle cronache brigantesche da ampio spazio nelle pagine del giornale postunitario l’Indipendente, riprendendo una tematica a lui già cara, in quanto briganti e masnadieri avevano già occupato le scene di molti dei suoi romanzi. Anche in quelle cronache, laddove si registra un tono paternalistico, traspare comunque la sua indiscussa indole di romanziere.
Un altro memoriale scritto da uno straniero che era andato di sua volontà ad ingrossare le fila dei briganti, è quello di Ludwig Richard Zimmermann, pubblicato a Berlino nel 1868 con il titolo Erinnerungen eines ehemaligen Briganten–Chefs, ovvero Memorie di un ex capo brigante. Lo scrittore tedesco fornisce una prospettiva di lettura diversa del fenomeno. Uno dei fini principali dell’autore, sembrerebbe quello di contrastare, attraverso la lettura del memoriale, quell’immagine truce e feroce del brigante trasmessa dai cronisti dell’epoca per diffondere un monito tra i lettori.
Ma Borges e Zimmermann non sono gli unici stranieri che riportano le loro esperienze vissute tra le truppe irregolari dei briganti. Emile Theodule De Christen, giovane colonnello alsaziano, volontario in difesa del Regno delle Due Sicilie ed in seguito prigioniero dei Piemontesi, pubblicherà nel 1866 in Francia, Journal de ma captivité suivi du récit d’une campagne dans les Abruzzes, tradotto in lingua italiana molto più tardi con il titolo Diario di un soldato borbonico nelle carceri italiane. In seguito ad un viaggio di piacere a Roma, decide di apportare il suo contributo a sostegno della causa di Francesco II e, dopo varie vicissitudini tra i briganti abruzzesi fra cui, capeggia il capobrigante Chiavone, si reca alla volta di Napoli dove viene arrestato come cospiratore. Condannato a dieci anni di prigione, De Christen viene rilasciato dopo solo due anni ed il suo diario, in cui racconta le angoscianti vicende delle carceri italiane, a volte tedioso da rendere poco interessante la lettura, è comunque una preziosa testimonianza del sistema penitenziario post–unitario.
Un altro diario di prigionia merita sicuramente di essere annoverato: quello redatto dall’inglese William J. C. Moens. Questa volta però la reclusione del protagonista avviene ad opera dei briganti e non dell’esercito. Durante il viaggio di nozze Moens e sua moglie si recano a Paestum in compagnia di un’altra coppia di inglesi nel 1865 ma il piacevole e romantico viaggio viene interrotto ben presto dal sequestro dell’uomo. Nel suo diario intitolato English Travellers and Italian Brigands edito a Londra nel 1866, lo sfortunato viaggiatore racconta la sua esperienza tra i briganti. Il tono dell’opera – diversamente da quanto si possa immaginare – non è quello drammatico di chi ha vissuto nel terrore, poiché Moens riporta tutto con freddezza scientifica, come se conducesse un’indagine sociologica. Egli descrive le fattezze dei suoi carcerieri e le loro interazioni quotidiane in modo tale che la natura “criminale” del brigante si attenui per lasciare il posto ad un’indole più umana e solidale.
La produzione dei testi redatti dagli stranieri nelle turbolente circostanze del primo periodo postunitario, così permeata di storia e cultura del sud Italia, costituisce senza dubbio un importante contributo per una lettura a più voci del fenomeno del brigantaggio nelle sue diverse espressioni, anche perché, oltre a validi riferimenti a fatti e personaggi storici, spiccano interessanti osservazioni di carattere sociologico.
Teresa Malara
Unità d’Italia e origini della mafia
1861: gli staterelli della penisola italiana raggiungono una tappa importante del processo risorgimentale di unificazione nazionale. Nasce (o rinasce dopo quasi un millennio) il Regno d’Italia: nel Meridione, il brigantaggio in parte è represso militarmente e in parte diventa arcipelago di associazioni mafiose. La repressione del banditismo (fenomeno extra–statuale e anti–statuale) appartiene alla storia; la metamorfosi del banditismo in mafia (fenomeno filo–statuale che diventa anti–statuale solo nei rari casi in cui esponenti dello Stato si oppongono alla seduzione e alle minacce) appartiene alla cronaca, sinora attuale, del Paese. Nel 1876 Franchetti, in esplorazione sociologica in Sicilia, intuisce l’essenziale e lo sa dire in maniera lapidaria: i mafiosi non sono disperati ai margini della società che attaccano le istituzioni, ma calcolatori assetati di potere e di denaro che vi si vogliono infiltrare per gestirle. Non sono avventurieri senza progetto strategico, ma «facinorosi della classe media». Quello che Franchetti vedeva con lucidità, contemporanei e successori hanno stentato a vederlo per circa un secolo: bisognerà attendere Mario Mineo prima, Umberto Santino dopo, per sentir parlare di “borghesia mafiosa” (non nel senso che tutti i borghesi siano mafiosi né che tutti i mafiosi siano borghesi, ma nel senso che l’“industria della violenza” nasce perché alcuni borghesi accettano di entrare in società con alcuni proletari desiderosi di imitarli).
Per lunghissimi decenni, l’etichetta “mafia” è servita come passepartout: i governi nazionali l’hanno adoperato per bollare come barbari, incivili e anarchici gli oppositori; salvo, poi, a vedervi innocui residui di folclore locale ogni qual volta sono riusciti a patteggiare e a servirsi di loro e dei loro amici per ottenere voti. Sino ai nostri giorni: alcuni esponenti della maggioranza governativa possono dichiarare, di aver messo la mafia alle corde; altri che, se un mafioso resta tale e decide di non collaborare con la magistratura, è “un eroe”. E’ interessante notare che questa strumentalizzazione ideologico–politica della mafia, a seconda dei rapporti (conflittuali o solidali) fra classe dirigente nazionale e classi dirigenti regionali, sembra risalire ai primissimi tempi della storia unitaria italiana. Nel volume Della segreta e operosa associazione. Una setta all’origine della mafia (Sellerio, Palermo, 2000) Amelia Crisantino ricostruisce in che modo la mafia diventa – nell’immaginario collettivo – un’associazione segreta. Nel 1878 venne celebrato un processo contro l’associazione degli stuppagghieri di Monreale, accusati di delitti e reati vari. Il questore di Palermo si convince che questa associazione criminale esista e debba essere scoperta e debellata. Le indagini procedono dunque in una certa direzione, ma con i paraocchi: non ci si avvede, infatti, che la mafia esiste, senza identificarsi però con quattro delinquenti di provincia. Essa è piuttosto un sistema di potere costituito da ricchi possidenti, da rappresentanti del nuovo Stato unitario, da monsignori di curia e dai “guardiani delle acque” che gestiscono, per conto della “Mensa arcivescovile”, l’irrigazione degli agrumeti della Conca d’Oro.
Augusto Cavadi
La repubblica di Filadelfia (1870)
Represso il brigantaggio con ogni genere di rappresaglie e la criminalizzazione d’intere comunità, il malcontento delle popolazioni non scomparve poiché rimasero le cause che lo avevano determinato.
Un ultimo sussulto di protesta contadina e di opposizione al governo piemontese fu la repubblica di Filadelfia (1870). Nei giorni 6 e 7 maggio 1870 in un’ampia zona che abbracciava i comuni di Maida, Cortale, Curinga e Filadelfia e altri centri vicini dei distretti di Nicastro e di Monteleone, scoppiò un moto rivoluzionario con evidenti risvolti bakuninisti. Lo scopo era quello di instaurare la repubblica secondo l’ideale dell’Alleanza repubblicana universale, creata dal Mazzini, che aveva trovato rapida diffusione nell’Italia meridionale.
La rivolta fu organizzata, appunto, da uno di questi comitati, guidato dall’avvocato Giuseppe Giampà, già garibaldino, direttore del giornale d’ispirazione repubblicana “La luce calabra”, sottoposto a numerosi sequestri per l’arditezza delle sue idee contro il re e la monarchia. Capo supremo delle forze repubblicane col titolo di generale era il figlio di Garibaldi, Ricciotti, il cui operato, insieme a quello degli altri intellettuali mazziniani che guidarono il movimento, non fu certamente all’altezza della situazione.
La rivolta ebbe come epicentro Filadelfia, con massiccia partecipazione contadina e operaia. Abortì però sul nascere per il tempestivo intervento dell’esercito regio (8 maggio) che sparò anche contro gente inerme tra cui i fedeli che rientravano dalla messa mattutina celebrata nella chiesa di S. Teodoro. Ci furono dei feriti (tra cui 7 donne) e anche due morti: un muratore di 43 anni (Michele Serraino) e un contadino di 19 anni (Vincenzo Dastoli). Altri contadini furono arrestati insieme con il Giampà.
Si parlò immediatamente di tradimento di quei notabili locali di matrice garibaldina che avevano promesso il loro appoggio ma che si tirarono indietro appena compreso che lo spirito dell’insurrezione, proprio per la larga partecipazione contadina e operaia, avrebbe messo in discussione i loro consolidati interessi e soprattutto il diritto di proprietà, anche se nel proclama firmato da Giampà si sostenevano il rispetto e la conservazione dell’ordine, la tutela della libertà, dell’onore, della vita e della proprietà di ciascuno.
Il moto fallì per varie cause: approssimativa preparazione politica, equivoche intese con circoli ed esponenti filoborbonici, capi che non riuscirono a pervenire ad una chiara impostazione dell’azione. Tuttavia, anche se fallì sul piano pratico e pur rimanendo circoscritto nella sola zona di svolgimento, il moto repubblicano di Filadelfia contribuì certamente a scuotere la stagnante rassegnazione e a favorire una prima presa di coscienza del proprio ruolo da parte di operai e contadini, dopo secoli di passiva accettazione del proprio destino. Da questo punto di vista i tre giorni dell’effimera repubblica di Filadelfia non furono certamente, come sosteneva il generale Sacchi, un episodio di malandrinaggio mascherato da moto insurrezionale politico.
Vincenzo Villella
Il 1860 in Calabria: illusioni e delusioni
Salvato il trono a Ferdinando IV nel 1799 con il Ruffo, e battutasi, tra il 1806 e il 1812, contro Giuseppe Bonaparte e Murat, la Calabria non ricevette segni di particolare riconoscenza; come del resto tutti i borbonici che, per il re, avevano perso beni e carriere. La convenzione di Casalanza, il compromesso con i murattiani, non rese questi fedeli alla monarchia, e scontentò gli altri. I Borbone protessero con la legge le terre di Chiesa arraffate sotto i francesi.
La Calabria – in utopia palingenetica, vecchio vizio: se piove, non apriamo l’ombrello, indiciamo convegni sul futuro clima – fornì a Garibaldi volontari per il fugace Esercito meridionale; e invano ne sperò restituito il demanio usurpato. Un secondo sbarco garibaldino in Calabria non incontrò i paciosi borbonici ma la buona mira di Pallavicini. Il regime unitario tutelò gli interessi del nord. E mentre Fazzari trasformava Mongiana in palazzo, la Calabria, da regione ad alta densità industriale, si avviò all’attuale ultima d’Europa.
Anche noi avemmo gli insorti “ingiuriati” come briganti; e lo spagnolo Borjes, per assumere il comando delle bande, iniziò qui la breve e infelice avventura. Diversa e non opposta, la “repubblica” di Filadelfia. «Così ci governa chi venne tra noi col nome di padre? Le nostre donne non hanno più orecchini e anelli, perché una mano, che mai non si chiude, li ha tutti raccolti. I nostri figli coltivano i nostri poderi per un padrone che non conoscono, poiché tutti i nostri frutti sono degli uomini che vennero a salvarci, e su i tetti e nelle nostre porte si asside la miseria con le vesti lacere e sozze. […] a che mandare in esilio i nostri re, se dovevano visitare le nostre soglie uomini che si levarono quello che i re ci avevano lasciato?»: così si esprimeva Domenico Mauro, già incarcerato dai Borbone! Il paternoster dei liberali calabresi sotto la pressione degli ingenti tributi in dicembre 1867 è il lamento di Antonio Martino, pure lui ex detenuto. Un Bruzio Cleambico vergò per timore con pseudonimo parole durissime. E mastro Bruno, piange quando scrive «simu Taliani, gridamma lu Sessanta», ora che «cu’ pota si nda scappa a Nova Yorca».
Ma il meglio è: «…mi duole il constatare […]i che la sospirata unificazione d’Italia, ahi, troppo più formale che sostanziale, non ha recato alcun profitto nei rami più importanti della convivenza calabrese; e in molti anzi imprimeva un regresso: come certo nell’agricoltura, nell’emigrazione, nella criminalità, nella proprietà, nell’economia, nella morbidità, nella nuzialità, nei morti precoci, nelle scuole; mentre i vantaggi più apparenti che reali, più di vernice che di sostanza, perché o precoci, o inadatti, o insufficienti come le ferrovie, le scuole, i giornali e le rappresentanze politiche divennero nuove fonti di disagio e di criminalità, accumulando a danno degli umili ed a profitto di troppo pochi gli inconvenienti della civiltà insieme a quelli della barbarie». Parole non di un “brigante”, ma di mostro sacro risorgimentale, Cesare Lombroso, quello dei crani misurati per mostrare che i meridionali siamo criminali, e bisognosi di liberazione piemontese.
Ulderico Nisticò
La Calabria e l’Unità d’Italia
Centocinquanta anni e la storia di un’Italia finalmente unita: un viaggio nel tempo emozionante ed affascinante.
Siamo ad una ventina di chilometri da Reggio Calabria. Precisamente a Melito di Porto Salvo: 11.000 anime ed un passato leggendario. L’abitato si erge su una collina che dolcemente degrada verso lo Jonio: il punto più estremo dello stivale italiano. Le acque che toccano Melito sono scrigno geloso di ricordi e cimeli che segnarono non solo la vita della cittadina reggina, ma pure episodi gloriosi del nostro Paese. E così davanti a quel cristallino mare il presente si stringe al passato in un amplesso che pare non conoscere vincoli di sorta, temporali o spaziali. Perché spazio e tempo in quelle acque diventano un’evanescente illusione. Quest’anno (2010) il mare di Melito ha fatto un regalo all’Italia intera, all’Italia unita. Dalle sue acque è riaffiorato il relitto del piroscafo Torino con cui Garibaldi sbarcò in Calabria il 19 agosto 1860.
I Borboni in quegli anni non avevano il favore della popolazione locale. La monarchia appariva cieca rispetto ai reali problemi del paese. La rivoluzione francese e il dominio napoleonico, da un lato, la rivoluzione industriale, dall’altro, avevano cambiato ormai il corso della politica e dell’economia del vecchio continente. L’utopia della libertà, lo spirito democratico, il sentimento nazionalistico, l’ideale dell’uguaglianza rappresentavano tutti nuovi fattori che si erano affacciati sullo scenario europeo ed anche calabrese. Quando, dopo il governo francese, Ferdinando di Borbone ripristinò nel Meridione gli antichi privilegi feudali, ai borghesi e agli intellettuali non rimase che aderire ai movimenti carbonari, miranti a rovesciare le monarchie assolute e a garantire forme rappresentative di governo. Benedetto Musolino e Luigi Settembrini (calabrese di Pizzo, 1809 – 1885, il primo; napoletano, 1813 – 1876, il secondo, con un’esperienza di docenza a Catanzaro), sono soltanto due dei tanti illustri e importanti rivoluzionari, che in Calabria, con entusiasmo diffusero, le idee democratiche.
Quel 19 agosto quindi Garibaldi non ebbe alcun problema ad approdare a Melito. La monarchia borbonica non riuscì ad opporsi alle forze garibaldine che conquistavano la Calabria. Pochi mesi ancora e l’Italia fu davvero unita, sotto la monarchia dei Savoia, «per grazia di Dio e volontà della Nazione». E’ il 17 marzo 1861.
L’annessione della Calabria fu una delle pagine più importanti della storia della nostra regione. Sicuramente dopo la proclamazione del Regno ci furono notevoli difficoltà. Per gli errori commessi dai nuovi governanti piemontesi la Calabria ancora sta pagando un caro prezzo alla causa dell’Unità. Ma l’Italia unita è stata ed è la forza trainante di una rinascita culturale, prima ancora che industriale, del nostro paese e della nostra regione.
I centocinquant’anni dell’Unità d’Italia devono spronare noi calabresi a guardare il futuro con occhi di speranza e di fiducia. «Utta a fa juornu c’a notti è fatta», ci ricorda il poeta conterraneo Leonida Repaci. E’ vero: la notte, la nostra notte, contiene già, l’albore del nuovo giorno. In questa Italia unita!
Luigi Mariano Guzzo
Anno 2011
L’anno che viviamo, il tempo che verrà
Il 2011 segna una doppia ricorrenza. Una che tocca l’intimo del nostro spirito associativo, i 15 anni del Premio letterario Feudo di Maida e della sua brochure; l’altra che segna l’intimo della nostra coscienza collettiva, i 150 anni dell’Unità del paese. L’una e l’altra ci spingono a seguire due paralleli percorsi a ritroso nella nostra memoria per ripensare e rilanciare il nostro futuro come associazione e come cittadini italiani.
Certamente, 15 anni di storia possono sembrare pochi rispetto ad altri premi, ad altre manifestazioni, ad altre più prestigiose periodiche pubblicazioni. Eppure, quanti successi, quante difficoltà, quanti entusiasmi, quanti ricordi, volti, sorrisi, emozioni! Quanti splendidi cammei incastonati nelle pagine della nostra brochure siglati da studiosi locali, nazionali e internazionali: un vero e proprio caleidoscopio di argomenti, personaggi e problemi con al centro, sempre, la Calabria e il Mediterraneo!
Se è praticamente impossibile ricordare qui tutti gli oltre cento autori che hanno collaborato – ci proponiamo di farlo con una edizione collettanea di tutti i 15 anni di contributi – è invece possibile ricordare i temi trattati: il territorio, le personalità laiche e religiose, l’identità storica, le relazioni mediterranee, la santità, la donna, la pace e la guerra, integrazione e intercultura, la battaglia di Maida, San Francesco di Paola, l’emigrazione verso l’Africa, l’immigrazione dall’Africa e, infine, l’Unità del paese.
Su quest’ultimo tema abbiamo voluto soffermarci anche quest’anno, proprio perché l’ abbiamo ritenuto di importanza chiave per la memoria storica collettiva e per il futuro del nostro giovane paese. La risposta sentita, ricca e immediata conferma pienamente i nostri intendimenti. Differenziandosi nettamente dai contributi precedenti, quelli di quest’anno toccano una gamma di tematiche di sicuro appeal: dal forte accostamento tra i briganti e i “bantiten” del periodo della resistenza del Di Bella alle mire sulla Sicilia attraverso la corrispondenza manoscritta di Napoleone esaminata da Currò; dalla rigogliosa stampa calabrese postunitaria, densa di speranze ma anche di spirito critico sintetizzata da Criniti all’estenuante salasso migratorio maidese messo in luce da Paone per tutto il periodo unitario; dalla cruenta sconfitta della battaglia delle Grazie del 1848 tra i borbonici del Nunziante e i rivoltosi dello Stocco, tratteggiata da Gullo, al contributo e alle pene sofferte dei volontari albanesi di Vena per le imprese militari di Calabria, redatto da Giordano; dall’adesione di patrioti curinghesi alle imprese garibaldine di Monteleone ai ritratti di due delle più importanti figure del Risorgimento dell’Italia meridionale, Carlo Pisacane e il già nominato Francesco Stocco, dipinti rispettivamente da Cannataro e Guzzo.
Anche se 150 anni sono decisamente pochi per un paese, le nostre antiche carte trasudano letteralmente di storie, di ideali, di slanci e di sacrifici che, in momenti difficili, come quelli in cui viviamo, possono servirci da monito, da stimolo e da guida. E se il premio e questa brochure vanno sempre avanti nonostante le difficoltà, che anche il nostro Stato vada avanti nonostante tutto e, forse, malgrado se stesso!
Salvatore Speziale
Giuseppe Garibaldi tra Briganti e Banditen
Giuseppe Garibaldi, il più grande guerriero italiano degli ultimi secoli e uno dei più grandi di tutti i tempi, indica nel brigante il combattente che incarna il decoro e l’onore militare del soldato italiano. L’eroe dei due mondi conosce bene il potere e la rivolta contro il potere; sa che quando la sete di giustizia e l’amore della libertà spingono all’insurrezione – contadino senza terra o sfruttato dai mille mestieri di una città ostile – il nome che gli tocca è quello di brigante. Il potere e chi lo detiene lo bollano così come nemico. Un nemico al quale non dare tregua e per il quale non c’è pietà. Neanche dopo la morte. Il popolo degli oppressi, dei senza terra e senza pane, degli esclusi, dei senza diritti dà altri giudizi e opera in maniera opposta.
Il brigante vive tra le sue fila come un pesce nell’acqua. Ne condivide i sogni, ne giustifica i delitti: sono la vendetta di chi non ha giustizia, sono la giustizia di chi è escluso dal governo dello stato e non accetta la confisca del diritto di essere uomo, intuito e vissuto come intangibile e inalienabile ben prima che i dotti ne codificassero il concetto. Garibaldi sa che ogni brigante, ribelle perché vindice di offese inflitte alla famiglia d’origine o al gruppo sociale di appartenenza, è un guerrigliero. E che un guerrigliero è un combattente che anticipa una rivoluzione, la precorre, la aspetta, ne diventa un soldato. Le doti di audacia, di astuzia, la padronanza del territorio, i legami con i concittadini, il coraggio temerario, il preferire la morte alla resa, la lotta alla quiete del sottomesso, la spada alle catene e il non contare i nemici che ha di fronte in battaglia; il sapere tener testa a un cavaliere nemico anche quando si combatte appiedato per la scelta di vivere tra forre e boschi è per Garibaldi la personificazione dell’eccellenza del fante. Anche perché il brigante si nutre di poco, e quel poco lo trova da sé quando non può fruire dell’aiuto della popolazione. È cioè un combattente veloce, frugale, coraggioso, resistente, forte, deciso. Quello che ci vuole in guerra per vincere e per difendere la propria terra e la propria libertà. Passano i decenni. Arriva l’8 settembre ‘43. Tutti a casa. Tranne coloro che per tetto scelgono le stelle, per letto le grotte o le baite di montagna, o le pietre e l’erba perché hanno preferito scegliere la lotta per la libertà, la guerra contro le viltà dei potenti in fuga e dei forti che occupano la patria. Ricevono un nome che dovrebbe bollarli con infamia: banditen.
Il potere nazi-fascista li condanna a morte e cerca di coprirli d’infamia criminalizzandoli. Il popolo li riconosce come i propri figli, i propri campioni, i propri paladini. Vivono come pesci nell’acqua. Anche i loro cadaveri rimangono insepolti, quando catturati vengono processati e uccisi. Popolazioni intere – Marzabotto per tutte – vengono sterminate per isolare i banditen. Guerriglieri, partigiani, senza paura e senza pietà verso il piede nemico che preme crudele e cinico, sul cuore della patria. Che appartiene al popolo. Foreste, montagne, burroni sono ancora il regno dei ribelli in attesa di vittoria.
Saverio Di Bella
La nuova stampa calabrese tra Risorgimento e Unità
Con il raggiungimento dell’Unità, la stampa calabrese, nonostante il diffuso analfabetismo caratterizzante il panorama regionale, assunse una sua spiccata rilevanza. Nel quadro di ritrovata libertà, difatti, i periodici diventarono l’unico strumento di formazione ed informazione di quella fascia di popolazione che, pur circoscritta, pesava (esercitando il ristretto diritto di voto) sulle scelte nazionali e su quelle amministrative.
A Cosenza nacquero Il Monitore Bruzio (1860), Il Calabrese (1861), soppresso nel 1844 già dopo la spedizione dei Bandiera, ripreso da Mariano Campagna, Luigi Valentini, Bonaventura Zumbini, Francesco Martire e Ferdinando Balsamo (tutti già ne Il Monitore Bruzio), Il Bruzio (1864) di Vincenzo Padula, Il Corriere di Calabria (1865) di Martire e La Libertà (1866) di Zumbini.
Anche Catanzaro conobbe un giornalismo legato ai grandi temi risorgimentali. La Media Calabria (fondata nel 1864 da Vincenzo Gallo Arcuri, Cristiano Garzya e Luigi Tamburini) fu l’organo della Società del Plebiscito e con La Calabria (1865, che sostenne il Consorzio nazionale e una sottoscrizione per la statua al D’Azeglio) e il Cittadino Calabrese (fondato nel 1864 da Vincenzo Bona, poi Il Nuovo Periodo) animò un intenso dibattito sui problemi dell’area centrale della regione, specie dinanzi all’imperversarvi del brigantaggio. La Luce Calabra (1869) si distinse invece per l’orientamento democratico del suo ideatore, Giuseppe Giampá (mazziniano e fondatore del movimento repubblicano catanzarese), patendo la censura già nelle prime uscite.
Reggio Calabria ebbe La Fata Morgana nel 1838, soppresso dopo i moti cosentini del ’44, ma il primo vero periodico unitario fu L’Amico della Libertà (1860) di Achille Canale. Su posizioni antigovernative furono L’amico della Verità (1867) diretto da Domenico Spanò Bolani e Bruno Rossi e L’Artigiano (1869), mentre accenti antistatali distinsero i periodici di Filippo Caprì, cattolico intransigente, fondatore, tra gli altri, de L’Albo Bibliografico e Albo Reggino (1864).
Animati da uno spirito a tratti messianico, i giornalisti calabresi, pur tra difficoltà economico-logistiche e spesso censurati, guidarono le improvvisate redazioni puntellando, non senza toni critici, il sentimento di partecipazione al nuovo Stato, coinvolgendo i lettori su questioni amministrative e nazionali, in un quadro che tra il 1890 e il 1915 avrebbe visto la nascita di ben 217 periodici calabresi. Dopo le restrizioni patite sotto i Borbone, il rigoglio di testate fu segno di volontà di riscatto per l’opinione pubblica della regione e se, in seguito, gran parte di quei periodici avrebbe assunto toni antigovernativi, quando non antistatali, ciò sarebbe dipeso proprio dalla frustrazione per il tradimento delle speranze riposte nell’Unità. Speranze ben vive nelle province calabre, già ricche di forze intellettuali che avrebbero trovato nelle redazioni dei giornali la loro palestra ideale.
Nicola Criniti
Lettere sulla Sicilia
1806, linguaggio scarno. Napoleone ha di fronte il Mediterraneo; il Mezzogiorno viene ad esserne inghiottito. Non esistono altre vie. L’idea è presto tormento: sistemare quanto dovuto a Napoli e alle porte del Regno, estendere la conquista, «surtout ne perdez pas un moment, […] pour tàcher d’enlever la Sicile». S’incrociano velieri inglesi diretti a Venezia. Bastimenti partono da Tolone verso Portici. L’inverno è alle spalle, gli spazi della negoziazione si sono chiusi, stagioni più miti non aspettano: si è nelle condizioni di puntare Messina. Napoleone sente di essere «maître de Naples et de la Sicile». La violenza piegherà qualunque sacca di resistenza: «J’attends de savoir […] le nombre de révoltés dont vous avez fait bonne justice. Faites fusiller […] des chefs des rebelles».
Si occupano allora le città e le campagne che si allungano dalla Sila all’Aspromonte. Il controllo della regione significherà presenza salda sullo Stretto. Ma il 1807 è «l’époque critique de mon armée de Naples», ed è inaccettabile pensare al nemico col piede ancora sul continente: «Mais, parbleu! Ne souffrez pas la honte d’avoir les Anglais à Reggio et à Scilla; c’est une ignominie sans égalè». Eppure l’entrata in guerra dello Zar a fianco di Bonaparte dirotta verso l’oceano buona parte dei britannici. È ora di agire. Raggiunta l’isola, sarà una formalità trarre il dado: «Cette expédition est fondée sur ce seul principe: avoir Scilla et le Phare». I movimenti di cavalleria, d’artiglieria, di marina sono regolati simmetricamente. Il Mediterraneo, del resto, freme: Zante, Corfù, Taranto, Costantinopoli non hanno pace. Il Tirreno vive di continui sussulti. Ma i francesi marciano ancora verso Sud: «Ce plan est calculé sur le principe que vous êtes maître de Scilla, le point plus important du monde». L’attesa diventa impaziente. Muovere verso Reggio: «Je compte que l’expédition […] réussira». 1808: l’ordine è finanziato. Milano e Firenze verseranno i denari necessari alla campagna. Il comando in Calabria, però, è sotto pressione.
I mesi scorrono, la reazione borbonica non si scompone: «Faites fortifier le fort de Scilla, car il n’est impossible que l’ennemi fasse des efforts pour reprendre ce point». Intanto, Giuseppe va a Madrid; Napoli accoglie Gioacchino. Tutto sembra doversi riscrivere da capo. Ma il re abbraccia la causa. L’immagine del Mediterraneo come trama di percorsi, di fantasie e principì rimane intatta. Murat è l’erede diretto della rivoluzione e di questa sensibilità. Così, se lo spettro delle incursioni corsare non si disperde, la stabilizzazione dell’Adriatico settentrionale dà nuovo vigore all’iniziativa: «la possession de Trieste sera d’un bon résultat pour ce qui regarde la Sicile, qui désormais n’aura plus aucun contact direct avec l’Autriche». E tuttavia, Gioacchino deve affrontare miseria, briganti, identità differenti. La materialità della resistenza e l’intransigenza del corso. Un urto che conferma la centralità dell’isola nella geopolitica di Bonaparte e, allo stesso tempo, il cedimento e le future divergenze: «Écrivez-lui qu’il a tort de parler ainsi de mes projets sans mon autorisation». La misura è colma: «je suis fort surpris».
Ma i tempi stanno mutando. I dubbi scalzano le certezze. Napoleone cede alla rassegnazione. Quando Gioacchino prova la sorte, l’imperatore è già su posizioni diverse. Il Mediterraneo è un mare di speranze e di naufragi. Spettacolo terribile, drammatico e, nonostante tutto, grandioso.
Placido Currò
La battaglia delle Grazie – 27 giugno 1848
… quel fanciullo, consumate le munizioni, non si volle arrendere, ma si slanciò con il pugnale sguainato e si difese a tutt’uomo, fin quando un fendente di sciabola gli mozzò la testa e cadde sui cadaveri nemici…
Un flash. Un’icona. Un ricordo. Si gusta il sapore argomentativo della “Piccola vedetta lombarda”. Ma non è così. Di sicuro è un atto di vero eroismo, seppur disconosciuto: nella storiografia ufficiale sentir parlare di Risorgimento calabro è rarissimo. Eppure un Risorgimento calabro esiste. Ce lo dicono le numerose condanne a morte, le persecuzioni, i saccheggi e gli 84 secoli di carcere inflitti ai nostri patrioti; ce lo dice l’eroismo di uomini che si sono votati alla morte per amore della Patria; ce lo dice il sangue versato sui campi di battaglia; ce lo dice il grido straziato di quel fanciullo decapitato nella battaglia delle Grazie. Si, la battaglia delle Grazie, che per la mole dei soldati impegnati, 7.000 borbonici e 5.000 volontari, rappresenta un importante scontro bellico del Risorgimento italiano.
Correva l’anno 1848, quando sbarcava a Pizzo con 2.000 soldati, il generale borbonico Nunziante. Giungeva in Calabria, su ordine del re Ferdinando II per reprimere i turbamenti rivoluzionari che si erano diffusi in tutte le province, soprattutto nel nicastrese, dove gli sviluppi bellici ebbero una coerenza ed una consistenza più evidente, dove il movimento patriottico ebbe la fortuna di avere una sola guida, Francesco Stocco, e di ritrovarsi unito intorno alle idee mazziniane. Queste ultime erano ben radicate in tutto il distretto e in particolare nei territori dell’ex feudo di Maida, grazie al lavoro di alcune vendite carbonare, dal “Trionfo della Giustizia e della Libertà” di San Pietro a Maida alla “Perfetta Concordia” di Maida, e grazie anche all’impulso degli ufficiali dello Stocco: Bevilacqua, Aiello, Fabiani, De Vito, Cefaly e Boca.
Un simile afflato liberale facilitò il compito dello Stocco, che fu il primo a muoversi alla notizia dello sbarco. Nel giro di 48 ore il generale era già in marcia con migliaia di volontari verso Maida. Qui convenne anche la compagnia di San Pietro a Maida, con più di 100 volontari, guidati dal capitano Aiello e da Grassi. Trascorsi alcuni giorni, un contingente di 3.000 nazionali, guidato dal tenente Griffo, si trasferì al campo di Filadelfia. La battaglia ormai era vicina. Infatti, il 27 giugno il Nunziante con 4.000 uomini sferrò l’attacco presso il ponte delle Grazie, dove trovò lo Stocco con i suoi 400 volontari. Di lì a poche ore “… principiò la zuffa. Nella foresta sibilavano incessanti le bombe, schiantando i rami …”.
Gli insorti rispondevano al fuoco costringendo il Nunziante al ritiro. I patrioti, felici, inneggiavano al trionfo, quando purtroppo arrivò il maggiore Grosso. Lo Stocco, accerchiato, tentò di resistere, speranzoso dell’aiuto del Griffo. Ciò, purtroppo non avvenne, per cui lo Stocco fu costretto a rifugiarsi sulle alture di San Pietro a Maida. Terminava così la battaglia delle Grazie, con una sconfitta, certo, ma l’eroico slancio di quel pugno di volontari resta una pietra miliare del Risorgimento ed un fulgido esempio d’impegno a difesa della patria e degli ideali di libertà e di democrazia.
Pietro Gullo
Gli albanesi di Vena di Maida ed il Risorgimento
Gli albanesi di Calabria condividevano gli ideali e i principi di libertà e uguaglianza che infervoravano gli animi dei patrioti risorgimentali. A questi aggiungevano motivazioni proprie.
Essi desideravano: migliori condizioni economiche e sociali (le terre loro assegnate erano le più povere); abrogare le disposizioni reali atte a disperdere la comunità albanese in agglomerati distanti tra loro al fine di distruggerne la potenzialità offensiva; opporsi efficacemente ai tentativi del papa di portare le comunità religiose bizantine ad abbracciare il rito latino; integrarsi con le popolazioni dei luoghi vicini e nello stesso tempo conservare la cultura, la lingua e le tradizioni nella consapevolezza che, non potendo costituire lo stato dell’Arberia, l’ideale più realistico era la creazione di uno stato unitario dove fossero rispettate le diversità dei popoli coinvolti.
Negli scontri, nelle rivolte, dove c’era da organizzare e da combattere, furono spesso presenti. Gli albanesi di Vena, agli ordini di Francesco Stocco diedero il loro contributo nei campi di Maida, di Filadelfia, di Nicastro, nello scontro alle Grazie, nella spedizione dei Mille, al Volturno.
Per le loro imprese furono condannati a lunghi anni di carcere. Questi i nomi e le imputazioni della gran Corte criminale di Catanzaro: Francesco Comità, sacerdote, Carlo Boca, proprietario, Giovanni e Giuseppe Saraceno, proprietari, accusati di provocazione, di reati contro la sicurezza dello Stato al fine di distruggere e cambiare il Governo e di attentati contro la sicurezza dello Stato con arruolamenti di bande armate; Domenico Peta fu Gaetano, di anni 28, accusato di attentato contro la sicurezza dello Stato, di ferimenti, di ingiurie, di percosse; Gaetano Boca, proprietario, di anni 32, accusato di attentati contro la sicurezza dello Stato con arruolamento in banda armata al fine di distruggere e cambiare il governo.
Quest’ultimo, capitano comandante la milizia agli ordini di Stocco, condusse al campo di Filadelfia una forza di circa 100 uomini che combatterono alle Grazie il 27 giugno del ’48 contro il generale Nunziante e il 27 agosto 1860 contro il generale Ghio.
Contro di loro la gran Corte criminale emise le seguenti condanne: oltre ad una malleveria di ducati 100 per tre anni e spese di giudizio, Comità, Saraceno e Peta furono condannati a 25 anni di ferri e Boca a 7 anni (forse per la giovane età). Le condanne ai venoti ammontavano complessivamente a 132 anni, 50 dei quali furono realmente scontati nel carcere di Santo Stefano sull’isola pontina di Ventotene.
Né gli anni di carcere, né le conseguenze sociali e le ripercussioni economiche li distolsero dal riprendere le armi ed a seguire Garibaldi nella spedizione dei Mille e sul Volturno. Qui, nel corso della battaglia, Garibaldi ebbe modo di verificare l’impeto guerriero dei discendenti di Scanderberg e li qualificò “prodi e valorosi”.
Dopo il favorevole esito plebiscitario, Vena, dal 1839 assegnata come frazione al comune di Maida, esultò alla proclamazione del Regno d’Italia. Nella toponomastica cittadina ancora oggi una via porta il nome di Umberto I e la piazza principale il nome di Vittorio Emanuele.
Giuseppe Giordano
Curinghesi nel Risorgimento italiano
Giuseppe Garibaldi sostò a Curinga fra il 28 e il 29 agosto 1860, ospite della famiglia Bevilacqua. La sosta fu determinata da ragioni di strategia militare: forse Garibaldi voleva evitare uno scontro con le truppe del generale Ghio, accampate a pochi chilometri di distanza dal bivio da cui si diparte, subito dopo il ponte sul torrente Turrina, la strada che dall’attuale ss 19 porta a Curinga. La deviazione per Curinga poteva poi servire a dare nuovo entusiasmo ai patrioti della zona. Appena il giorno prima, infatti, circa 500 uomini partiti da Curinga avevano tentato uno sfortunato attacco alle truppe borboniche nei pressi del ponte sul torrente La Grazia, più o meno nello stesso punto in cui il 27 giugno 1848 c’era stato uno scontro fra un gruppo di Nazionali e l’esercito borbonico. È il caso di ricordare che protagonista di quest’ultimo episodio era stato Francescantonio Bevilacqua, mentre alcuni suoi figli, in particolare Giacinto, avevano combattuto nel secondo scontro sulla Grazia. È lecito pensare che in casa Bevilacqua Garibaldi aveva buoni motivi per sentirsi in un ambiente fidato; e questo fa capire lo stato d’animo con cui il generale lasciò Curinga, indossando il “cappello conico dalle lunghe fettuccine di velluto” che aveva avuto da un contadino in cambio del suo.
Poco dopo la partenza di Garibaldi, si mosse da Curinga, guidato da due dei fratelli Bevilacqua, Giacinto e Bonaventura (entrambi con il grado di capitano), un gruppo di volontari che combatté nella battaglia del Volturno:
Calvieri Domenico (sergente),
Ceneviva Domenico, Ceneviva Domenico sr, Cirianni Tommaso, De Sando Antonio, Funaro Pietrantonio, Giampà Vincenzo, Lorusso Salvatore,
Marinaro Giuseppe, Monteleone Pietrantonio, Riccio Giov. Battista, Pizzonia Giuseppe, Santo Orlando, Senese Agostino, Sestito Vincenzo, Summa Bruno.
Manca, in questo elenco, che conosciamo grazie al lavoro di Gaetano Boca, il nome di Vincenzo Losco, il quale pure fu certamente tra i garibaldini. Tale assenza potrebbe spiegarsi con il fatto che Losco aveva raggiunto i Mille prima che questi sbarcassero in Calabria, dopo avere attraversato lo Stretto di Messina, come attestato da fonti orali che trovano conferma nell’epigrafe posta sulla tomba eretta nel cimitero di Curinga, per additare ai posteri la memoria di “un’anima eletta” che “la giovinezza consacrò alla patria/sospirando combattendo/nelle epiche/campagne garibaldine/da Milazzo a Mentana”. In sostanza, Losco non compare fra i volontari reclutati nel mese di settembre perché egli era già da tempo nell’armata garibaldina e probabilmente con essa continuò il suo viaggio verso Napoli. Il fatto che poi si sia ritrovato ancora a Mentana con Garibaldi indica un’adesione consapevole e matura ad un ideale si può ben definire ‘amore per la patria’.
E’ quasi certa la presenza a Curinga di un gruppo di persone che, ancora negli anni 80 del XIX secolo, avevano come riferimento le figure di Cavour, di Mazzini e di Garibaldi, come si evince dalla lettura degli atti della cerimonia commemorativa organizzata dal Comune dopo la morte di Garibaldi. Era sindaco, in quell’anno, Giacinto Bevilacqua, lo stesso che aveva guidato i volontari curinghesi al Volturno, dove si era conquistato i gradi di maggiore.
Pietro Monteleone
Carlo Pisacane e i federalisti del risorgimento
Napoletano, figlio cadetto dei duchi di San Giovanni, Pisacane nacque nel 1818 cioè al principio della restaurazione borbonica. Come tutti i rampolli dell’aristocrazia venne educato nell’Accademia della Nunziatella e all’interno del mondo dorato e compassato della corte borbonica, realtà che, ben presto, gli sembrò angusta e poco in linea con le sue aspirazioni culturali.
Di questo personaggio, fin ai primi degli anni 80’ del Novecento, fu pressoché ignorato lo spessore ideologico formatosi nei circoli parigini, laddove conobbe Blanc e soprattutto nella Londra in fermento per l’affermarsi del liberalismo egalitario della scuola di Manchester. Quelle idee di solidarietà internazionale per cui il benessere di un popolo era condizione di quello di un altro e la prospettiva di un superamento dello scontro tra le classi sostituito da un più proficuo confronto, rappresentavano, per Pisacane, la spinta per una nuova e definitiva rivoluzione nazionale. L’Italia, scriveva, era una terra dalle grandi tradizioni ma dalla poca coscienza degli errori del passato; la sua idea di rivoluzione era però così eroica, così sfrontatamente ideale che prescindeva da ogni preventivo intervento didattico a favore del popolo: il terrore e la speranza sarebbero stati i “maestri” della rivolta.
La spedizione di Sapri e il suo tragico epilogo rappresentano l’aspetto più conosciuto della sua storia, il sistema federale quello più interessante e moderno.
La struttura portante del suo federalismo era comune a quella degli appartenenti al filone ed era costituita dalla consapevolezza che la storia d’Italia era sempre stata la storia delle sue città, la novità introdotta da Pisacane fu la trasposizione dal piano culturale a quello politico di questa consapevolezza. L’analisi rivelava un preciso piano politico di valorizzazione degli elementi positivi del passato della penisola senza dimenticare che all’interno di quelle realtà sopravvivevano i privilegi della borghesia che limitavano l’espressione del popolo intero.
Il suo modello si inseriva nell’ambito della questione nazionale che, negli ambienti della sinistra democratica, corrispondeva con la questione della libertà e dell’indipendenza dallo straniero. Tali presupposti non permettevano, al repubblicano Pisacane, di accettare alcun compromesso né con i murattiani, né con chi, come Ferrari, auspicava l’intervento diretto della Francia in favore della questione italiana. Nessuna contaminazione esterna doveva mortificare la storia della penisola cioè quella delle sue città. Quello di Pisacane fu dunque il primo progetto comunale dell’epoca. Lo schema appare oggi, certamente, poco maturo ed embrionale per via della mancanza di adeguate mediazioni istituzionali tra Stato e libera espressione popolare all’interno dei singoli comuni o per la totale mancanza della definizione di confini territoriali degli enti locali ma, di certo, resta un punto di riferimento essenziale per la moderna definizione dell’unità nazionale in questo paese.
Italia Cannataro
Maida, 150 anni di emigrazione
Quanti furono i meridionali che emigrarono tra il 1861, anno dell’unità, e il 1876, anno in cui il nuovo Stato pubblicò i primi risultati statistici nazionali? Le cifre oscillano, secondo gli studiosi, da 20 a 40 mila unità all’anno. Le statistiche ufficiali del periodo dal 1876 al 1890 mostrano che il primato dell’emigrazione apparteneva a tre regioni settentrionali (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte) mentre gli emigrati di Calabria, Puglia e Basilicata non superavano il 12,9% del totale nazionale. Furono gli anni della “grande emigrazione”, furono gli anni in cui i maidesi scelsero come destinazione gli Stati uniti d’America e formarono una comunità nella cittadina di Ambler, in Pennsylvania.
Dal 1930 al 1997 le partenze si susseguono inarrestabili, una vera emorragia che sconvolge famiglie, società ed economia impoverendo Maida (compresa la frazione Vena): nell’arco di 67 anni, ben 5.206 cittadini, con una media di 80 unità l’anno. Una situazione identica ai paesi del circondario.
Dal 1930 al 1940, diminuisce l’emigrazione verso l’estero e verso gli Stati Uniti ed aumenta l’emigrazione verso altri comuni italiani. La tendenza rimane costante fino alla conclusione della seconda guerra mondiale e alla caduta del Fascismo.
Con la nascita della Repubblica, l’esodo, abbandonato parzialmente l’estero, ha come destinazione prevalente le regioni del triangolo industriale. Il numero delle partenze varia dalle poche decine alle 448 unità dell’anno 1953, e a tutt’oggi continua.
Gli anni che vanno dal 1953 al 1976 sono gli anni della seconda imponente ondata migratoria provocata dal forte dislivello economico tra il Nord ed il Sud del paese e tra il Sud e il Nord dell’Europa. Una media di centocinquanta concittadini l’anno saluta i parenti per avviarsi prevalentemente verso le regioni del Nord Italia. Alcuni addirittura scelgono l’Australia.
Dal 1965 al 1982, a ridosso del boom economico italiano, la Svizzera diventa oggetto di migrazioni di maidesi. Dai cantoni di Basilea e di Zurigo si calcola che siano transitati, in quel periodo, oltre 500 maidesi e molti vi si trovano tuttora.
La crisi petrolifera della metà degli anni 70 segna la fase di controtendenza del flusso migratorio. Da quegli anni, si verificano i primi modesti saldi positivi tra il numero di emigrati e di immigrati.
Mentre durante la “grande emigrazione“ l’esperienza migratoria servì ai contadini per acquistare la proprietà della terra, le più recenti ondate hanno mirato alla costruzione della casa, favorito l’acquisto dei beni di consumo e il miglioramento delle condizioni di vita della famiglia con particolare attenzione per l’istruzione dei figli.
Se furono gli individui e le famiglie, da un lato, e lo Stato dall’altro a ricavare beneficio dall’emigrazione, i costi più gravosi si riversarono invece sulle regioni di partenza e le comunità locali. Con la crisi economica mondiale degli ultimi anni, la situazione locale si è ulteriormente aggravata: l’agricoltura si regge con il contributo dei lavoratori extracomunitari mentre il piccolo commercio ha definitivamente ceduto il passo alla grande distribuzione. Il centro storico è un susseguirsi di serrande sprangate tanto che oggi Maida appare “deserta e vuota come un De Chirico metafisico”.
Salvatore Paone
Francesco Stocco, liberale e patriota
A volte il destino gioca strani scherzi. I genitori lo chiamano Francesco, in onore del futuro re delle Due Sicilie, Francesco I di Borbone, che addirittura, da padrino, a Messina, lo terrà pure a battesimo. Fedeltà alla famiglia Borbone? Nemmeno a parlarne. Dopo qualche anno trascorso alla corte di Napoli, la storia lo ricorda quale uno dei protagonisti indiscussi dell’impresa unitaria ed indipendentista.
Francesco Stocco nasce ad Adami di Decollatura il primo marzo 1806. La sua è una famiglia aristocratica e filo borbonica. Dopo aver studiato in collegio a Cosenza, i reali Borbone lo accolgono nella capitale partenopea come “cavallerizzo”. Ma Napoli è una città grande, foriera di idee e di pensieri. Francesco entra a contatto con la scuola del letterato Basilio Puoti, uomo dai forti ideali patriottici. Inoltre il giovane Stocco, vivendo a corte, si scontra con la faccia peggiore del regime borbonico: la prepotenza, la corruzione, la viltà. Matura una coscienza liberale e aderisce alla setta dei “Figlioli della Giovane Italia”, fondata da Benedetto Musolino. Tra la fine del 1847 e l’inizio dell’anno successivo, lo ritroviamo in carcere per avversione ai Borbone. Liberato, rientra in Calabria e partecipa ai moti della primavera del 1848, guidando l’insurrezione dell’Angitola contro le truppe borboniche, comandate dal generale Nunziante. I moti calabresi falliscono e il comandante Stocco è costretto a rifugiarsi prima a Malta, poi a Genova, successivamente a Nizza dove incontra Garibaldi. Ormai il dado è tratto! Nel 1860 anch’egli veste la giubba rossa delle truppe garibaldine e si prepara ad essere una delle figure di spicco della spedizione dei Mille. A Calatafimi è ferito ad un braccio. Garibaldi lo premia nominandolo colonnello brigadiere. Organizzando il corpo dei volontari garibaldini “Cacciatori della Sila”, Francesco Stocco avrà un ruolo determinante nella battaglia di Soveria Mannelli il 30 agosto 1860. Il disarmo delle truppe borboniche con la resa del generale Ghio di fatto aprirà ai Mille la strada verso Napoli.
Con la proclamazione del Regno d’Italia, Stocco entra nell’esercito regolare con il grado di maggiore generale e, messo a riposo nel 1862, viene eletto senatore per il collegio di Nicastro. Fa parte della commissione per redigere il primo elenco dei Mille sbarcati a Marsala l’11 maggio1860. Ben presto però lascia l’attività politica per ritirarsi a vita privata nella Villa della Majolina, tra Capo Suvero ed Amantea. Muore a Nicastro l’8 novembre del 1880 ed a tenere l’elogio funebre è un altro grande del risorgimento calabrese, il filosofo Francesco Fiorentino.
Catanzaro nel 1898 gli dedica un monumento con una statua, a dimensione d’uomo, opera di Giuseppe Scerbo, uno scultore che vive la passione per l’arte, ma che incarna l’ideale della patria. Collocato inizialmente in piazza Matteotti, il monumento nel 1939 fu trasferito nella piazzetta prospiciente l’ex Ospedale Militare, alla quale oggi ha dato il nome.
Il ricordo di Francesco Stocco non è una semplice nostalgia storica. Ma piuttosto serve, in questi centocinquant’anni di Unità d’Italia, a non dimenticare che la storia è inesorabilmente legata alle vicende di una Calabria che ha molto contributo alla formazione di un paese unito.
Luigi Mariano Guzzo